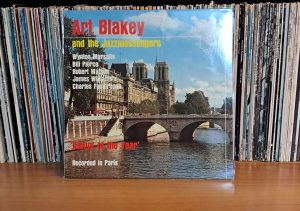Bill Evans e Jim Hall con «Intermodulation»: equilibrio, sottrazione, ascolto (Verve Records, 1966)

«Intermodulation» rimane un documento prezioso, per la capacità di trasformare il duo in un organismo sonoro unitario, quasi una monade, in cui ogni procedura musicale trova un corrispettivo nell’altro strumento, generando un tessuto espressivo che continua a rivelare inedite sfumature a ogni ascolto.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Nel corso della storia del jazz, l’incontro fra pianoforte e chitarra ha sempre rappresentato una sfida strutturale, poiché entrambi gli strumenti condividono la stessa vocazione armonica, la medesima capacità di articolare accordi complessi e un ruolo tradizionalmente destinato a sostenere l’impianto formale dell’ensemble. La loro coesistenza richiede una disciplina d’ascolto fuori dal comune, una gestione millimetrica degli spazi sonori e una consapevolezza reciproca che eviti sovrapposizioni, ridondanze, collisioni funzionali. Negli anni Sessanta, quando la prassi improvvisativa tendeva a privilegiare organici più estesi, la scelta di ridurre il campo d’azione a due strumenti accordali appariva quasi un paradosso, un gesto di sottrazione che chiedeva ai musicisti un controllo assoluto del materiale armonico. «Intermodulation» nasce esattamente da questa sfida: Bill Evans e Jim Hall trasformano un potenziale conflitto in un laboratorio di equilibrio, dove ogni voce trova un proprio spazio senza mai oscurare l’altra.
Bill Evans e Jim Hall appartengono a quella ristretta cerchia di interpreti che hanno saputo trasformare la riduzione strumentale in una risorsa poetica. Il loro incontro si fonda su un minimalismo consapevole, in cui due strumenti armonici, apparentemente destinati a sovrapporsi, trovano invece un equilibrio raro. Pianoforte e chitarra condividono lo stesso territorio funzionale, eppure riescono a evitare ogni conflitto, costruendo un dialogo che sfrutta la frugalità, la trasparenza e la misura. In un’epoca dominata da ensemble più estesi, la scelta di un organico così essenziale assume un valore quasi programmatico, rivelando quanto la profondità espressiva possa emergere dalla concentrazione, dalla cura del dettaglio e dalla capacità di lasciare spazio al silenzio. La collaborazione fra i due interpreti emerge come uno dei vertici più raffinati del dialogo cameristico nel jazz dell’epoca, un incontro in cui pianoforte e chitarra si muovono con una consapevolezza reciproca che richiama la precisione di un contrappunto interiorizzato, modellato attraverso un ascolto vigile e una sensibilità condivisa. L’incisione realizzata negli studi di Rudy Van Gelder nel 1966 restituisce un ambiente acustico terso, quasi un laboratorio in cui ogni gesto sonoro trova un alveo naturale, sostenuto da un equilibrio che valorizza la delicatezza del tocco di Evans e la fisionomia acustica del suono di Hall, sempre più vicino alla trasparenza espressiva che aveva caratterizzato le sue esperienze con Jimmy Giuffre.
La durata contenuta del disco non riduce la portata del discorso musicale, che si dipana attraverso un repertorio eterogeneo e coerente al tempo stesso, comprendendo Gershwin, Cole Porter, Joe Zawinul e due pagine originali dei protagonisti. La scelta dei materiali rivela un’attenzione alla forma che non mira alla semplice rielaborazione del canone, bensì alla costruzione di un percorso in cui ogni composizione diventa pretesto per un’indagine armonica e per una ridefinizione del rapporto fra linea melodica e sostegno accordale. L’apertura con «I’ve Got You Under My Skin» sancisce immediatamente tale prospettiva: la melodia, riconoscibile nella memoria collettiva, viene trasformata attraverso deviazioni armoniche che ne alterano la percezione, generando un clima di continua scoperta. Evans procede con un fraseggio che sfrutta la mobilità delle sostituzioni, mentre Hall interviene con un profilo acustico che predilige intervalli ampi, lasciando respirare le risonanze e creando una trama espressiva che si sovrappone alla procedura pianistica con naturalezza.
Il successivo «My Man’s Gone Now» assume una dimensione quasi rituale, con Evans che scava nelle pieghe emotive del tema attraverso un uso sapiente delle dinamiche e delle sospensioni interne alla frase, mentre Hall implementa un ambiente sonoro che amplifica la gravità del materiale gershwiniano. La pagina di Zawinul, «Angel Face», diffonde un diverso tipo di lirismo, più assottigliato, con la chitarra che delinea un percorso melodico di estrema nitidezza e il pianoforte che risponde con accordi distribuiti in modo da innescare un gioco di rifrazioni armoniche. Con «Jazz Samba», si plana invece un terreno ritmico più mobile, trattato con eleganza, evitando ogni stereotipo legato alla bossa nova e preferendo un andamento che privilegia la leggerezza della prassi esecutiva e la chiarezza delle progressioni. Le due composizioni originali rappresentano il nucleo poetico del disco. «Turn Out the Stars», una degli episodi più intimi del repertorio evansiano, si configura come un monologo interiore in cui il pianoforte esplora una serie di modulazioni che sembrano emergere da un pensiero armonico in continua trasformazione. Hall interviene con discrezione, quasi un’ombra che accompagna il percorso del pianoforte senza mai sovrapporsi. «All Across The City», firmata da Hall, promulga invece una visione urbana filtrata attraverso una sensibilità contemplativa: la chitarra traccia un disegno melodico di di facile combustibilità, mentre Evans elabora un sostegno che valorizza la serenità del tema, facendone in un piccolo affresco di quiete metropolitana.
La nozione tecnica di intermodulazione, da cui il disco prende il titolo, trova una sorprendente corrispondenza nella pratica dei due interpreti. Il fenomeno fisico che genera frequenze derivate dalla sovrapposizione di segnali diversi diventa metafora di un dialogo in cui le linee di pianoforte e chitarra producono significati ulteriori, non riconducibili alla semplice somma delle parti. Ogni intervento di Evans modifica la percezione del fraseggio di Hall e viceversa, liberando un sistema di risonanze incrociate che definisce l’identità profonda del progetto. Nel panorama contemporaneo, il duo Mehldau–Metheny offre un punto di confronto interessante, soprattutto per l’uso di materiali provenienti dalla cultura pop come base per l’improvvisazione. Tuttavia, la relazione fra pianoforte e chitarra in «Intermodulation» si colloca in un territorio diverso, più vicino alla musica da camera che al dialogo jazzistico tradizionale, con una cura del dettaglio che richiama la precisione di certi ensemble novecenteschi e una sensibilità armonica che affonda le radici nella tradizione impressionista filtrata attraverso la poetica evansiana. «Intermodulation» rimane dunque un documento prezioso, non soltanto per la qualità delle esecuzioni, ma per la capacità di trasformare il duo in un organismo sonoro unitario, quasi una monade, in cui ogni procedura musicale trova un corrispettivo nell’altro strumento, generando un tessuto espressivo che continua a rivelare sfumature a ogni ascolto.