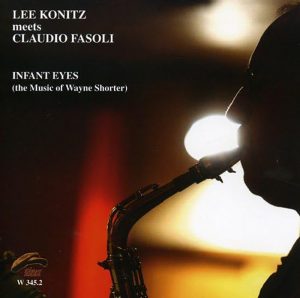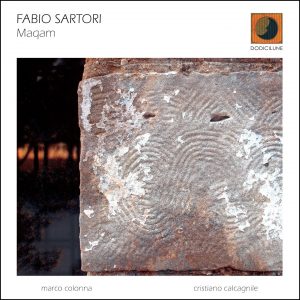È morto James Senese, artefice del Neapolitan Sound

James Senese
Senese non è stato solo un musicista, ma un pensatore sonoro, un artigiano del ritmo, un testimone della Napoli che non si piega. Con la sua scomparsa, la musica italiana perde una voce che non ha mai cercato il consenso, ma ha sempre preteso ascolto.
// a Cura della Redazione //
James Senese, figura cardinale della musica italiana del secondo Novecento. musica italiana del secondo Novecento, si è spenti all’età di ottant’anni presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato in terapia intensiva a causa di una grave infezione polmonare, aggravata da una lunga storia di dialisi. Con lui scompare non solo un sassofonista di rara intensità, ma un testimone vivente della Napoli meticcia, quella che ha saputo fondere il blues con la lingua dei vicoli, il jazz con la rabbia proletaria, il funk con la memoria popolare.
Nato da madre napoletana e padre afroamericano, soldato di stanza in Italia durante lo sbarco alleato, Senese incarna sin dalla nascita la tensione identitaria che attraversa la sua musica. Cresciuto nel quartiere di Miano, nella periferia nord della città, il giovane James attraversa mestieri e marginalità prima di trovare nel sax uno strumento di riscatto e di espressione radicale. L’ascolto folgorante di John Coltrane, avvenuto a dodici anni, segna l’inizio di un percorso artistico che non sarà mai imitativo, ma sempre trasfigurante. La sua prima affermazione avviene con gli Showmen, ensemble R&B guidato da Mario Musella, con cui partecipa al Festival di Sanremo nel 1969. Ma è con la fondazione dei Napoli Centrale, nel 1975, che Senese imprime una svolta definitiva alla musica napoletana: insieme a Franco Del Prete, e sotto l’egida morale di Eduardo De Filippo, costruisce un laboratorio sonoro che rompe con la canzone tradizionale e apre alla contaminazione linguistica, ritmica, tematica. La voce roca e il sax viscerale diventano strumenti di denuncia sociale, di narrazione urbana, di resistenza culturale.
I brani dei Napoli Centrale – da «Campagna A» a «‘Ngazzate nire», da «Simme iute e simme venute» a «Napule t’è scetà» – non sono semplici canzoni, ma quadri sonori che raccontano il Sud con una grammatica nuova, dove il dialetto si fa lingua critica e il groove diventa veicolo di coscienza. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 1983, Senese ne rilancia la seconda vita negli anni Novanta, proseguendo parallelamente un percorso solista che include titoli come «‘O Sanghe» e «Hey James», sempre fedeli a una poetica dell’urgenza e della verità. Fondamentale è anche il sodalizio con Pino Daniele, che Senese accoglie nei Napoli Centrale agli esordi, acquistandogli il primo basso. Il loro rapporto, segnato da fratellanza e reciproca influenza, culmina nella formazione di una delle band più raffinate della musica italiana, con Tullio De Piscopo, Rino Zurzolo, Joe Amoruso ed Ernesto Vitolo. Insieme firmano album epocali come «Terra mia» e «Nero a metà», dove il Neapolitan Sound raggiunge una sintesi irripetibile tra virtuosismo e radicamento.
Senese non è stato solo un musicista, ma un pensatore sonoro, un artigiano del ritmo, un testimone della Napoli che non si piega. La sua presenza nel film «No grazie, il caffè mi rende nervoso» di Lodovico Gasparini, in cui interpreta se stesso, suggella una carriera che ha sempre rifiutato la finzione per abbracciare la realtà. Con la sua scomparsa, la musica italiana perde una voce che non ha mai cercato il consenso, ma ha sempre preteso ascolto.