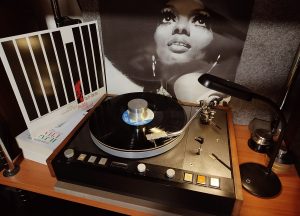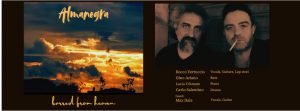Intervista a Maurizio Becker: ascoltare e raccogliere storie

// di Guido Michelone //
D In tre parole chi è Maurizio Becker?
R Mi ritengo una persona fortunata che riesce a vivere di ciò che ama, tenendo fuori dal suo cerchio magico quasi tutto quello che detesta.
D Raccontaci in breve la tua attività professionale.
R Ho iniziato a inventarmi un mestiere negli anni del ginnasio, improvvisandomi conduttore ai microfoni di una radio privata e stampando col ciclostile di mio padre una fanzine in cui parlavo degli artisti e dei dischi che ascoltavo: si chiamava Jam Session. Poi con la faccia tosta che ti regala la giovinezza ho iniziato a propormi alle riviste periodiche ufficiali, e così ho messo piede nel mondo dei professionisti. La prima testata vera che mi ha accolto è stata Ciao 2001, a metà anni Ottanta. Da lì, una lunga attività pubblicistica. In TV ho lavorato dietro le quinte, ad esempio in redazione con Sergio Zavoli, mentre in radio ho vissuto degli anni fantastici conducendo uno dei programmi più liberi mai inventati, Stereonotte. Gli ultimi vent’anni li ho invece dedicati alla carta stampata: qualche libro e tante riviste, da Musica Leggera a Classic Rock, passando per Vinile, il nuovo Ciao 2001 e adesso l’edizione italiana di Metal Hammer.
D A che età e come hai scoperto la musica?
R Verso i sette o otto anni frequentavo casa di una mia cugina appassionata di musica pop e rock. Lì ho scoperto che ai dischi di Guccini e Vecchioni preferivo quelli di Beatles, Bob Dylan, David Bowie e Frank Zappa. I quattro minuti e quarantuno secondi che mi hanno cambiato la vita sono quelli del 45 giri di Rocket Man, di Elton John.
D E come ti sei avvicinato per la prima volta al jazz?
R Al primo piano del palazzo dove abitavo c’era un ragazzo più grande di me che suonava la batteria e ascoltava soprattutto jazz. Dalla sua finestra, saliva tanta musica per me sconosciuta, il più delle volte strumentale. Fu lui a consigliarmi di acquistare qualche rivista specializzata, visto che mostravo interesse. Ma il jazz ho iniziato ad annusarlo molti anni dopo, quando ho avuto l’occasione di lavorare in radio come regista e redattore di Adriano Mazzoletti: il suo programma su Radio 1 ospitava musicisti e critici come Marcello Rosa, Giovanni Tommaso, Dino Piana e Marcello Piras. Lì ho incrociato ad esempio una delle persone a mio parere più colte e preparate dell’intero ambiente musicale italiano, un intellettuale della musica che si chiama Gianni Gualberto. Non a caso, era e ancora oggi è un cane sciolto.
D In quale ruolo ti trovi meglio: scrittore, editore, giornalista, musicologo, organizzatore o altro ancora?
R Sentirmi definire musicologo mi fa sorridere. E penso a Gianfranco Funari, col quale ho lavorato, che pur conducendo programmi che in qualche modo confinavano con il giornalismo amava definirsi “giornalaio”. All’inizio mi divertivo molto a scrivere, a recensire, a dire la mia, poi col tempo ho scoperto che la cosa più bella e gratificante per me è ascoltare e raccogliere storie. Quindi, se ne avessi il tempo, mi concentrerei soprattutto sulle interviste.
D Dei lavori (o iniziative) da te intrapresi quali ritieni siano i più gratificanti o esemplari per il tuo contributo alla cultura musicale?
R L’amicizia che mi ha legato a Lilli Greco mi ha fatto conoscere l’altra faccia del mondo della musica, quella della creazione e della produzione artistica. Il passo successivo è stato il desiderio di contribuire a salvare e tramandare la storia della RCA italiana, che non è stata solo un’importante casa discografica ma un modello industriale unico e direi insuperato. Il libro che è nato dalla nostra frequentazione, C’era una volta la RCA, rappresenta un preciso spartiacque nella mia vita professionale.
D Su cosa stai lavorando ora e nei prossimi mesi?
R I vent’anni vissuti al fianco di un uomo illuminato come Francesco Coniglio mi permettono oggi di lavorare per quello che forse è l’unico editore puro rimasto in Italia nel settore della stampa periodica specializzata. Per Sprea coordino da oltre dieci anni il mensile Classic Rock e i relativi speciali monografici. Attorno a questa attività si è sviluppata nel tempo una fitta rete di progetti: alcuni hanno avuto una bella vita, altri sono stati meno fortunati. Una delle scommesse perse a cui sono rimasto più legato è stata quella di Classic Jazz, un bimestrale con cui abbiamo tentato un approccio nuovo al racconto della musica jazz. Purtroppo, non abbiamo avuto il tempo di capire se era la strada giusta: il mondo dell’edicola è diventato spietato e pretende risultati immediati.
D Quella per il cosiddetto “vintage” musicale è una tua passione o più realisticamente hai trovato un settore di cui in Italia non si occupava nessuno?
R Guardando al presente musicale, mi verrebbe da dire che rivolgere lo sguardo al passato è l’unico modo di dare un contenuto al mio lavoro e di sentirmi in qualche modo utile.
D Negli anni Cinquanta (e primi Sessanta) esisteva una canzone jazzata: Buscaglione, Carosone, Jula de Palma, ma anche Dorelli, Teddy Reno e ovviamente il grande Arigliano; perché dopo di loro c’è stato un grande vuoto secondo te? Colpa (o merito) solo del beat o c’è altro?
R Credo dipenda dal tramonto delle orchestre. Negli anni Cinquanta in Italia c’erano cinque o seicento night club e funzionavano qualcosa come cinquemila sale da ballo o balere. Ciò significa che la possibilità di proporre musica dal vivo era sterminata: considera che un night cambiava orchestra grossomodo ogni due o tre mesi, e che la stagione durava nove mesi. In un libro del 1960, Vincenzo Buonassisi parlava di quattromila orchestre attive solamente in Italia. Quell’indotto dava da vivere a circa cinquantamila persone. Un mercato ricchissimo, ma soprattutto una palestra incredibile. Terminata quell’epoca, la formazione dei nuovi artisti è diventata di competenza quasi esclusivamente discografica.
D Sempre in quel periodo – al di là dei jazzisti veri: Basso, Valdambrini, Cerri, Rotondo, Mussolini, Intra, Cesàri, Piana, Sellani, ecc. – c’erano orchestre jazzy condotte da fior fior di musicisti come Umiliani, Piccioni, Canfora, Trovajoli, Calvi, ecc.; perché anche qui non c’è stato un ricambio generazionale?
R Chi si è formato musicalmente tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta non poteva che provenire dal jazz. Ma il jazz, fatto salvo il circuito dei locali da ballo, remunerativo ma di poco prestigio, è stato sempre in Italia un fenomeno d’élite e non ha mai avuto grandi prospettive. Non a caso, tutti i migliori talenti nati dal jazz si sono presto dati al cinema o ancora di più alla televisione, dove nel frattempo erano esplosi i grandi varietà, che avevano bisogno di orchestre, arrangiatori e direttori: pensa a Gorni Kramer, a Puccio Roelens, a Franco Pisano (oltre Canfora, Piccioni, Trovajoli da te citati), e poi via via fino a Enrico Simonetti o Lelio Luttazzi e oggi a Stefano Bollani. Insomma, i jazzisti italiani hanno capito presto che col jazz puro non sarebbero arrivati da nessuna parte.
D Stesso discorso per la musica da film, con scores firmati da Gaslini, Fusco, Micalizzi, Intra, Nascimbene, oltre quelli già menzionati come Umiliani e Piccioni, e persino in pubblicità, con un “genio” quale Franco Godi; poi, anche qui, silenzio… come mai?
R Fino a tutti gli anni Settanta e forse anche gli Ottanta, il cinema italiano ha goduto di buona salute e disponeva di budget generosi, per cui i produttori potevano permettersi di investire anche sulla musica. Poi, complici le nuove possibilità offerte dalla tecnologia, hanno prevalso modalità meno onerose. Ad esempio, l’utilizzo di musiche preesistenti, se non proprio il ricorso ai brani pop più popolari.
D Cambiando discorso, con quali modalità (anche personali) ti rapporti con i tuoi “colleghi” o con chi comunque lavora al tuo fianco o in contesti similari?
R In quasi quarant’anni di attività, ho incrociato centinaia di colleghi. Fatalmente, alcuni hanno condiviso con me lunghi tratti di percorso e sono diventati miei amici. In generale, però, io sono un animale solitario e un po’ selvatico, assolutamente poco mondano, e presenzio molto di rado a eventi, presentazioni e occasioni sociali. In questo senso, l’avvento dei social mi ha dato un grande aiuto. Nel privato, mi circondo di vecchi amici storici, con i quali evito accuratamente di parlare di musica o questioni lavorative.
D Ritieni che in Italia vi siano spazi interessanti per contribuire ad accrescere o sviluppare una vera cultura della storia della musica pop, popular o leggera?
R L’Italia è diventata un Paese strano, ossessionato dal successo, dal profitto e dagli status symbol. Le nuove generazioni devono confrontarsi con modelli devastanti, anche se sono sicuro che posseggono gli anticorpi che consentiranno loro di evitare di tramutarsi in meri “consumatori”. Ma la strada è tutta in salita. La parola “cultura” è diventata un termine impopolare, scomodo, addirittura divisivo. Da anni sostengo che sarebbe meglio abolirlo. Quando ti chiedono cosa fai e rispondi che campi occupandoti di musica, ti guardano come un marziano: e un po’ hanno ragione. Quando parli di “cultura”, scappano tutti. Quindi, per rispondere alla tua domanda: no, al momento gli spazi sono quasi inesistenti.
D Come ti rapporti all’oggetto disco, anche a livello personale?
Tutto ciò che è immateriale mi lascia freddo. Banalmente, un boomer come me potrebbe dirti che la soddisfazione di ascoltare un vinile o un CD leggendo le note di copertina è impagabile. In realtà, la questione è un po’ più complessa: l’immaterialità è il modo migliore di non lasciare traccia. Niente supporti, niente memoria collettiva. È un po’ come le fotografie: una volta le stampavamo e le raccoglievamo negli album, e ancora oggi possiamo guardarle ed emozionarci. Con i file digitali non conserviamo nulla, perché di solito a un certo punto cancelliamo dati per liberare la memoria dello smartphone, o accade che lo smarphone si rompa, o che lo perdi. E pezzi della tua vita scompaiono per sempre.
D Come ultima domanda, forse banale, ti chiedo una tua Top five o Top ten dei jazzmen più amati e, se ti va, tre dischi da isola deserta.
R Da jazzofilo distratto quale sono, faccio cinque nomi che mi danno sempre piacere e conforto: Miles Davis, Louis Armstrong, Thelonious Monk, Nina Simone e Bill Evans. Sull’isola deserta però porterei probabilmente un disco di Zappa, uno di Dylan e la collana Napoletana di Roberto Murolo. Perché, fra le altre cose, nel mio tortuoso viaggio ho imparato che la canzone napoletana è un po’ il nostro blues.