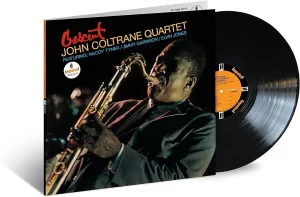Funkadelic: una frattura semantica e stilistica nel lessico della musica afroamericana

George Clinton
…Funkadelic comincia a battere, con una precisa volontà di destrutturazione estetica. Laddove la Motown costruiva l’ideale borghese della sofisticazione black, Clinton e compagni rispondevano con una teatralità plebea, oltraggiosa, che faceva della sporcizia un valore simbolico e della volgarità un linguaggio di liberazione.
// di Francesco Cataldo Verrina //
I Funkadelic segnarono una frattura semantica e stilistica nel lessico della musica afroamericana, introducendo una poetica dell’eccesso e della trasgressione che si colloca consapevolmente fuori dai codici dominanti dell’industria discografica dell’epoca. La loro proposta, incapsulata nel titolo omonimo del primo LP e sublimata dalla provocatoria definizione di soul come «una canna rollata con la carta igienica», non si limitava a deviare dal mainstream, ma lo disintegrava con la forza di un atto performativo radicale, al confine fra mistica psichedelica e militanza iconoclasta. Il termine «funkadelic», coniato per affermare un’identità irriducibile ed aliena – «non apparteniamo al vostro mondo, ma non temete, non vi faremo alcun male» – è il segnale di un’intenzione poetica che punta alla costruzione di una mitologia sonora e visuale alternativa, ibrida, refrattaria alle gabbie razziali ed ai recinti commerciali.
L’evoluzione del collettivo imbastito da George Clinton s’impose come una delle espressioni più ricche e stratificate del pensiero musicale afroamericano del secondo Novecento, incrocio vertiginoso tra estetica, ideologia e sovversione linguistica. Il momento di svolta coincise con la cesura che defenestrò tre figure centrali della prima formazione: Eddie Hazel, Tawl Ross e Billy Nelson. Epurazione dettata non da logiche artistiche, bensì dall’instabilità dei suddetti prodotta da tossicodipendenze e frizioni economiche. La decapitazione parziale, lungi dall’indebolire l’impalcatura progettuale, aprì un varco ad una nuova compagine dinamica centrata sull’energia irradiante dei fratelli Bootsy e Catfish Collins, transfughi dall’universo browniano dei J.B.’s, la cui sintassi ritmica e vocazione performativa innestarono nel lessico funkadelico una tensione propulsiva inedita. Guidata da George Clinton, figura la cui visionarietà eccedeva le categorie del frontman tradizionale per assumere i contorni del demiurgo culturale, la band si proponeva come macchina sincretica capace di riconfigurare i paradigmi della musica nera attraverso una contaminazione sistematica con le grammatiche del rock psichedelico e del teatro d’avanguardia. L’accoglienza non fu trionfalistica: «Chi ha bisogno di merda come questa?», sparò a zero Rolling Stone. L’insuccesso critico iniziale, epitomato dal sarcasmo liquidatorio della rivista, rifletteva l’inadeguatezza degli strumenti interpretativi tradizionali a fronte di una proposta artistica che sovvertiva tanto le aspettative del pubblico afroamericano, ancora legato ai modelli Motown, quanto quelle dell’ascoltatore bianco progressista, disorientato da una retorica afrocentrica che non chiedeva accoglienza, ma affermava un desiderio di presenza. Clinton stesso sintetizzerà questa condizione liminale come una duplice alterità: «troppo bianchi per i neri e troppo neri per i bianchi».
Questa ambiguità identitaria nasceva quale prodotto di una genealogia musicale stratificata che affondava le radici nel doo-wop dei Parliaments, ensemble fondato negli anni Cinquanta nella barberia Silk Palace di Plainfield, New Jersey, e ispirato ai Teenagers di Frankie Lymon. La parabola dei Parliaments, punteggiata da un unico successo radiofonico, («I Wanna) Testify» (1967), e da una mancata consacrazione sotto l’egida Motown, ebbe la funzione di preambolo all’evoluzione successiva – come già accennato – nella quale gli strumentisti reclutati da Clinton, tra cui Eddie Hazel, Billy «Bass» Nelson e Tiki Fulwood, sovvertirono la centralità vocale a favore di una prassi collettiva orientata all’eloquenza timbrica e alla dilatazione lisergica del groove. È qui che l’embrione Funkadelic comincia a battere, con una precisa volontà di destrutturazione estetica. Laddove la Motown costruiva l’ideale borghese della sofisticazione black, Clinton e compagni rispondevano con una teatralità plebea, oltraggiosa, che faceva della sporcizia un valore simbolico e della volgarità un linguaggio di liberazione. Determinante per la definizione del sound sarà il contributo di Bernie Worrell, enfant prodige dalla formazione accademica, la cui adesione al progetto segna l’irruzione di una sensibilità colta e tecnologicamente audace nel cuore pulsante del funk. La sua capacità di fondere barocco elettronico e pathos liturgico nell’architettura sonora del gruppo non solo aggiornava la tradizione afroamericana al contesto post-psichedelico, ma ne espandeva il vocabolario fino a sfiorare la dimensione del poema sinfonico urbano, dove, per riprendere una suggestiva immagine critica, «Shakespeare e Stagger Lee si calano acidi insieme nel ghetto». Tale tensione all’oltre appare manifesta fin dal secondo LP, «Free Your Mind… And Your Ass Will Follow», dichiaratamente concepito sotto l’effetto dell’LSD, che incarnava il tentativo di evocare una danza mentale, uno stato di trance collettiva e psicocorporea, a cavallo fra l’illuminazione e la farsa. Il ciclo inaugurale si chiude con «Maggot Brain» (1971), vertice emotivo e concettuale dell’intera parabola funkadelica, in cui l’assolo di Hazel nell’omonima traccia d’apertura, suonato «come se sua madre fosse appena morta», si delinea come grido catartico e sacrale, attraversato da una spiritualità elettrica che si sostanzia tanto come omaggio ad Hendrix quanto enunciazione di un lutto cosmico. La title-track, in forma di sermone apocalittico, evoca la maternità oltraggiata della Terra e la necessità di una prova esistenziale estrema per sopravvivere al disfacimento dell’universo morale: «ho assaggiato i vermi nella mente dell’Universo», proclama la voce, senza retorica ma con feroce consapevolezza. Il tema finale, «Wars Of Armageddon», affastella invece suoni, slogan, rumori, ingiurie e detonazioni in un collage fonico che riprende le strategie di Burroughs e Zappa, dando forma a un teatro della dissidenza che fa esplodere la grammatica canzonettistica tradizionale. L’uso del turpiloquio, lungi dall’essere gratuito, s’inscrive in una pratica retorica radicata nella cultura orale afroamericana, dove l’oltraggio verbale diviene esercizio di verità, strumento di decolonizzazione linguistica, arma di rottura nei confronti del formalismo bianco. In tal senso, l’adesione ai registri più crudi della stand-up comedy coeva, basti pensare a Richard Pryor, non conferma solo affinità di tono, ma di condivisione del progetto estetico e politico, ossia fare del linguaggio uno spazio di resistenza, risemantizzando lo «sporco» come categoria emancipativa. La domanda che introduce il primo disco, «Mommy, What’s A Funkadelic?», non cerca una definizione, ma una genealogia, la cui risposta rappresenta una dichiarazione d’intenti disturbante, carnale e visionaria.
George Clinton si colloca nel panorama della black music del secondo Novecento non come epigono di una tradizione, ma come suo agente mutazionale, operando una torsione profonda sia sul piano estetico sia su quello ideologico. Mentre gran parte dei suoi contemporanei – da James Brown a Curtis Mayfield, da Isaac Hayes ai Temptations «politicizzati» del periodo post-1968 – si muoveva entro coordinate che pur segnate da istanze di rinnovamento restavano ancora riconoscibili come prolungamento evolutivo del soul e del rhythm and blues, Clinton sceglie consapevolmente una linea di frattura. La sua opera, in particolare con Funkadelic e Parliament, non rappresenta una semplice radicalizzazione del funk emergente, ma la costruzione di un nuovo universo simbolico che si alimenta di detriti culturali e frammenti ideologici eterogenei, decostruendo le ortodossie identitarie della musica nera per rilanciarle in forma visionaria e trans-genere. Se Marvin Gaye, con «What’s Going On», cercava una mediazione fra spiritualità e militanza, e se Gil Scott-Heron articolava una poetica del verbo afrocentrico ancora saldamente ancorata alla dimensione poetico-narrativa del blues urbano, Clinton invece abbandona ogni pretesa di leggibilità lineare e si rifugia nella costruzione di una mitologia propria, esoterica, in cui la dissidenza prende la forma dell’assurdo, della metafora cosmica, della teatralizzazione grottesca del potere e della marginalità.
La sua distanza dai modelli egemoni della black music si misura anche nella gestione della corporeità scenica e nell’estetica visiva: laddove il soul politico manteneva un certo rigore formale, si pensi al portamento ieratico di una Nina Simone o alla compostezza da predicatore di un Al Green , Clinton rompe con l’idea stessa di rappresentanza decorosa del corpo nero, affermando un’identità caleidoscopica, travestita, barocca, volutamente eccessiva, come dispositivo di smascheramento e di derisione dell’autorità, bianca o nera che fosse. In questo, egli si avvicina più a figure eccentriche come Sun Ra – con il quale condivide una concezione cosmologica e afro-futurista della negritudine – che non ai suoi coetanei più «terreni», ancorati a una dialettica ancora bipolare fra oppressione e riscatto. Clinton dissolve questa opposizione e immagina invece un altrove, un «Mothership» da cui discendere con potere proprio, senza chiedere legittimità ad alcuna matrice storica. Non si tratta di una fuga, ma di una strategia di riappropriazione simbolica: se l’universo occidentale bianco ha costruito l’altro nero come mostro o come spettacolo, Clinton si riappropria di quella mostruosità e ne fa mitologia autonoma, paradossale, lucida, caricaturale ma potentemente politica. Anche sul piano musicale, il confronto con i coevi è eloquente: mentre la maggior parte dei protagonisti della scena soul e funk elaborava arrangiamenti sofisticati ma ancora funzionali a un modello canzone ben definito, Clinton destruttura la forma, accoglie la jam come principio generativo, elabora strutture iterative e stratificate, avvicinandosi al linguaggio della psichedelia bianca più che a quello dei suoi colleghi afroamericani. Se Sly Stone poteva essere considerato, con «There’s A Riot Goin’ On», una figura di transizione che intercettava la crisi post-utopica degli anni Sessanta, Clinton rappresenta l’esplosione postmoderna di quella crisi: non la elabora in chiave elegiaca o riformista, ma ne fa materiale di costruzione di un immaginario alternativo, capace di contenere simultaneamente l’ironia, la volgarità, la spiritualità e la teoria. Così, mentre i suoi contemporanei si battevano per conquistare o consolidare uno spazio di cittadinanza all’interno del sistema discografico e culturale americano, Clinton sceglie di sabotarlo dall’interno, riscrivendone i codici non con l’argomentazione politica ma con il gesto simbolico, con la performatività eccentrica e con la proliferazione di segni in grado di sfuggire all’assimilazione. Egli non chiede spazio, ma lo occupa con modalità proprie, irriducibili. Clinton non assume le sembianze di un semplice artista della black music, ma riveste il ruolo di un teorico per immagini e suoni della post-blackness, antesignano di una modalità di espressione culturale che rifiuta la dicotomia oppressore/oppresso come unica chiave di lettura, scegliendo invece di reinventare da capo il proprio vocabolario, come atto di insubordinazione estetica e politica.
Già nell’ambizioso «America Eats Its Young» – doppio manifesto fitto di riferimenti para-ideologici e affondi lisergici, gravato dalle interferenze simboliche della Process Church Of The Final Judgement – si coglie una transizione dalla furia acida delle origini verso un’architettura musicale più articolata e discorsiva. Con «Cosmic Slop» e «Standing On The Verge Of Getting It On», l’organismo muta ancora. L’ingresso del chitarrista Garry Shider ed il ritorno di Hazel costituiscono innesti che reintroducono, pur trasfigurata, l’anima incendiaria degli esordi. In tale costellazione mutevole, Rolling Stone individua con ritardo ma lucidità una specificità linguistica, «quella di una narrazione sonora che, sebbene spogliata di ogni intento decorativo, si fa specchio nitido – benché abrasivo – delle tensioni e delle irregolarità del vivere urbano afroamericano». Nel momento in cui Clinton si riappropria del nome Parliament, la duplicità diviene paradigma: le due entità, Parliament e Funkadelic, si pongono come facce di un medesimo dispositivo semiotico, articolato secondo una logica rizomatica che elude l’opposizione binaria tra «rock» e «blackness». Da un lato, i fiati affilati degli Horny Horns (emanazione diretta del laboratorio browniano), dall’altro le chitarre elettriche come vettori di un immaginario psichedelico afrocentrico. Questa sovrapposizione identitaria – «un sacco di gente non sapeva che fossimo lo stesso gruppo» – lungi dal disorientare, inscrive l’intera operazione in una prassi metamusicale dove l’oscillazione tra i poli non è segno di incertezza, ma dispositivo epistemologico. All’interno di questo scenario si manifesta compiutamente la «doppia coscienza» evocata da Du Bois all’alba del secolo, ossia quella frizione ontologica tra auto-percezione e sguardo eterodiretto che Clinton metabolizza non come trauma, ma come risorsa creativa. Attraverso il recupero e la dilatazione del termine «funk» – parola originariamente infetta, trasudante corporeità e marginalità, ora elevata a chiave di lettura del mondo – si inaugura un’epistemologia del groove. Non a caso, LeRoi Jones aveva già decifrato tale processo come riappropriazione semantica del negativo, laddove l’«afrore negro» veniva sublimato a emblema di autenticità radicale. La nozione di funk, nella visione clintoniana, si svincola da ogni confine stilistico per incarnare una strategia di sopravvivenza e trasformazione: «qualcosa che uno sente», una forza che plasma il negativo in positivo mediante una carica simbolica sovversiva e affermativa insieme. Questa trasfigurazione metafisica della materia sonora trova un ulteriore sviluppo nella definizione di P-Funk: non mera etichetta di genere, bensì campo semantico aperto, insieme rifugio e detonatore. Se «P» sta per «pure», l’aggettivo non allude a una purezza originaria, ma a una purezza ottenuta per attrito, per superamento del filtro coloniale della norma musicale occidentale.

George Clinton si colloca rispetto a James Brown e Sly Stone in una posizione dialettica: non semplice erede, né mero epigono, ma figura trasversale che metabolizza, decostruisce e infine trascende le coordinate dei suoi predecessori. La sua relazione con entrambi fu di riconoscimento profondo ma anche di rottura strategica, come se Clinton avesse intuito che solo smontando dall’interno i modelli della black music classica fosse possibile proiettarla verso una dimensione mitica, post-genere e post-identitaria. Con James Brown, il rapporto fu tanto filiale quanto eversivo. Clinton riconobbe sempre nel «Godfather Of Soul» un fondatore linguistico, tanto che il funk, come lo conosciamo, nasce nel corpo ritmico di Brown, nei suoi attacchi sincopati, nell’accentazione del «one» (il primo battito di ogni battuta), nel rigore quasi militaresco della sua direzione orchestrale. La macchina ritmica di James Brown era una forma di disciplina sonora, una struttura iper-controllata, quasi fordista. Clinton ne assimilò il cuore pulsante- e in particolare, come già detto, assunse direttamente nella sua band membri chiave dei J.B.’s, come Bootsy e Catfish Collins, Maceo Parker e Fred Wesley, ma rifiutò la verticalità autoritaria del modello browniano. Se Brown rappresentava la figura del padre in senso psicoanalitico, rigido, moralizzante, ossessionato dal controllo del corpo nero, Clinton optò per la dissacrazione, destrutturò la forma, disperse l’identità, moltiplicò i personaggi, teatralizzò il sesso spingendolo nel grottesco e nel kitsch. Dove Brown era marziale, Clinton era caotico; dove uno cercava il rispetto borghese per la blackness (con completi eleganti, testi edificanti, discorsi politici), l’altro esplodeva in una festosa, anarchica polifonia di voci, suoni e corpi. Eppure, senza Brown, Clinton non sarebbe stato pensabile: il suo funk è figlio deviante del rigore paterno.
Con Sly Stone, invece, il rapporto fu più orizzontale, quasi speculare. Sly rappresenta probabilmente la figura che Clinton sentì più prossima, poiché entrambi provenivano da un background gospel, operavano al confine tra psichedelia, soul e rock; ambedue vedevano nella musica uno strumento di ingegneria sociale. Stone fu il primo ad abbattere le barriere di genere e di razza in una band multietnica e multigenere come i Family Stone, il primo a cantare l’utopia del «We», della collettività e della fratellanza come gesto politico. Tuttavia, dove Sly collocava la sua visione nella speranza utopica (almeno fino al crollo psicofisico di «There’s A Riot Goin’ On»), Clinton la trasfigurava in mitologia afrocentrica e postumana. Se Sly Stone sembrava ancora parlare all’America, tentando di riconciliarla con la propria parte nera, Clinton parlava da un altrove, dal cosmo, dalla nave madre, da un futuro che non cercava più riconciliazione, ma riscrittura. Sly fu il visionario tragico; Clinton, il trickster cosmico. Appare significativo il fatto che entrambi condividessero una tendenza all’auto-sabotaggio, all’eccesso ed all’impossibilità di sostenere nel lungo periodo il peso della propria radicalità. Ma mentre Sly implose nel silenzio e nella sparizione, Clinton moltiplicò le maschere, i progetti paralleli e gli alter ego, mantenendo viva l’illusione di un’identità sfuggente, fluida e collettiva. In sintesi: se Brown si attesta come il fondamento ritmico e ideologico da cui Clinton parte, ma che supera destabilizzandone l’ordine; Sly rappresenta lo specchio inquieto e fraterno, con cui Clinton condivide utopia, ambiguità e destino, ma da cui si distanzia per ironia e capacità mitopoietica. Clinton incarna l’erede infedele, colui che prende in prestito ma si rifiuta di restituire, che cita ma mai letteralmente, che si colloca nella genealogia della black music non come punto terminale, bensì come frattura, cortocircuito e rilancio.
Il rapporto di George Clinton con figure come Sun Ra, l’Art Ensemble of Chicago e Miles Davis si inserisce in un dialogo complesso e multidimensionale che trascende i confini convenzionali tra generi musicali, ponendosi su un piano di affinità filosofiche, estetiche e politiche più che di semplice derivazione stilistica. Sun Ra, maestro dell’afrofuturismo e dell’utopia cosmica, rappresenta una fonte imprescindibile per la mitologia creativa di Clinton. Entrambi costruirono universi sonori e visivi che superano la mera musica per trasformarsi in esperienze totali: performance rituali, narrazioni mitiche, iconografie esoteriche. La cosioddetta «nave madre» di Clinton echeggia chiaramente l’archetipo della navicella spaziale di Sun Ra, simbolo di fuga dalla storia coloniale verso un altrove liberatorio e immaginifico. Entrambi utilizzano la scienza-fantascienza come strumento per ridefinire la blackness, superare il tempo lineare e costruire un’identità nera universale e trascendente. L’Art Ensemble Of Chicago, con la sua sperimentazione radicale, la contaminazione di jazz, musica etnica, teatro ed improvvisazione totale, risuona con la stessa tensione verso la liberazione espressiva che anima il progetto P-Funk. Clinton, come gli Art Ensemble, rifiuta i confini rigidi della tradizione per abbracciare la polifonia delle voci e la molteplicità delle forme, costruendo uno spazio in cui il corpo nero è protagonista di una continua ricostruzione performativa. L’estetica teatrale, il travestimento, l’uso di elementi rituali sono pratiche condivise che sottolineano la funzione politica e culturale della musica come atto di resistenza e autoaffermazione. Miles Davis, pur provenendo da un contesto jazzistico più «classico», si colloca come un altro modello fondamentale per Clinton, soprattutto per la sua attitudine all’innovazione costante ed alla reinvenzione di sé. Davis fu un pioniere nell’ibridazione tra jazz, rock, funk e musica elettronica, anticipando traiettorie che Clinton avrebbe esplorato a fondo con il P-Funk. L’approccio sperimentale, l’uso di tecnologie emergenti e la volontà di abbattere barriere stilistiche fanno di Davis un predecessore spirituale della filosofia clintoniana. Non a caso, la tensione verso la trasformazione continua e la «morte» della forma predefinita del jazz trova una corrispondenza nel rifiuto di Clinton di farsi incasellare in etichette rigide.
George Clinton si pone all’incrocio di queste tradizioni: raccoglie e rielabora l’eredità afrofuturista di Sun Ra, la sperimentazione collettiva e rituale dell’Art Ensemble e la trasformazione sperimentale e ibrida di Miles Davis. Questa sintesi produce un linguaggio unico che, pur radicato nel funk e nella black music, sfida le categorie convenzionali e amplia i confini del possibile espressivo afroamericano. Sotto tale segno, il collettivo parliafunkadelico si propone come entità proteiforme, capace di comporre comunità immaginarie attraverso riti elettrificati, scenografie cartoonesche, mitologie afrofuturiste. Pedro Bell, con il suo immaginario visivo eccessivo e onirico, amplifica la potenza simbolica dell’universo P-Funk, trasmutando le copertine in vere e proprie estensioni iconografiche della poetica clintoniana. Sul piano strettamente musicale, la sintesi proposta da Rickey Vincent ne distilla i vettori: poliritmia ostinata, fraseggio chitarristico obliquo e «untuoso», basso sintetico in funzione tellurica, stratificazioni fiati e vocali secondo geometrie gospel, e un impiego del sintetizzatore come dispositivo alienante e liberatorio. In tale contesto, Clinton assurge a figura liminale: sciamano, demiurgo e buffone sacro, architetto di una visione sonora che non ambisce all’integrazione, ma alla sovversione dell’ordine stabilito attraverso l’infezione del corpo sonoro afroamericano. Non l’ennesima voce della protesta, ma un progetto totale, inclassificabile, mobile, che agisce simultaneamente sulla carne, sulla mente e sull’immaginario. L’intero edificio simbolico del P-Funk, lungi dal risolversi in un semplice ampliamento linguistico del lessico musicale afroamericano, si delinea come un laboratorio antropologico nel quale Clinton plasma una mitologia alternativa, in equilibrio precario ma fecondo tra memoria diasporica, dissacrazione rituale e proiezione utopica.
L’espansione dell’universo parliafunkadelico nella seconda metà degli anni Settanta assume i tratti di un’epopea sincretica, in cui l’immaginazione afroamericana si emancipa definitivamente dalla subalternità simbolica e costruisce una propria cosmologia sonora, visiva e performativa. L’alleanza stretta nel 1973 con la Casablanca Records – la stessa etichetta che in quegli anni orchestrava le ascese parallele di Kiss e Donna Summer – segnò per i Parliament l’ingresso in una nuova stagione di visibilità, che si sarebbe concretizzata già l’anno seguente con «Up For The Down Stroke» e, nel 1975, con «Chocolate City», dichiarazione programmatica sotto forma di slogan urbano e satira sovversiva: «Sì, la chiamano ancora Casa Bianca, ma è una condizione temporanea». Clinton non si limitava ad iniettare contenuto politico nel tessuto musicale, ma rifondava l’iconografia stessa del potere, spostandone il baricentro dal bianco monumentale al nero palpitante, vibrante, collettivo. In parallelo, i Funkadelic, appena congedati dalla Westbound, firmavano per la Warner Bros. con «Hardcore Jollies», mentre altri esiti delle medesime sessioni confluirono in «Mothership Connection» dei Parliament e in «Stretchin’ Out» della Bootsy’s Rubber Band. Una proliferazione vertiginosa di sigle, alias, ensemble fittizi e reali, che Clinton orchestrava con sapienza da demiurgo, moltiplicando le identità come strategia di resistenza contro le logiche monolitiche del mercato discografico. Il 1976 segnò così il parossismo produttivo del sistema P-Funk: cinque album, quattro denominazioni, tre etichette, una sola visione.
A condensare e teatralizzare tale visione fu l’approdo della Mothership, non un semplice espediente scenico ma epifania tangibile dell’afrofuturismo sonoro incubato nel ventre della black music fin da Sun Ra, ora espanso fino ad occupare fisicamente lo spazio scenico. La navicella madre, reliquia oggi conservata dallo Smithsonian, fungeva da oggetto rituale, totem tecnologico e monumento ludico al contempo. Clinton la descriveva come un ibrido surreale, un incrocio tra un’auto americana anni Cinquanta, un gioco per bambini ed un insetto cosmico. Eppure, al di là della superficie pop e dell’eccesso visivo, la Mothership si inscriveva in una grammatica profondamente radicata nella tradizione africana, dove la cesura tra sacro e profano semplicemente non esiste. Ogni gesto era insieme danza e preghiera, travestimento e rivelazione, parodia e profezia. Nel cuore del P-Funk Earth Tour – vera e propria liturgia itinerante, inaugurata il 27 ottobre 1976 a New Orleans e immortalata nel doppio album «Live: P-Funk Earth Tour» la navicella scendeva dall’alto tra fumi e bagliori dopo una sequenza di invocazioni modellate sulla struttura call-and-response del gospel, un battesimo di massa in chiave funk, dove lo spettacolo si trasformava in rito comunitario. La produzione, dispendiosa al punto da segnare un record storico per la black music (275.000 dollari), fu affidata a Jules Fisher, figura chiave del teatro rock e supervisore di spettacoli epocali da Jesus Christ Superstar a Bowie, dagli Who ai Kiss. Un’estetica del sovraccarico, del travestimento barocco, della saturazione visiva, che Clinton assimilò e decostruì, traducendola in parodia identitaria. In scena, l’eccesso diventava dispositivo semiotico, dove una corte dei miracoli composta da venti performer travestiti da archetipi deformati, ossia papponi galattici, neonati in pannolone, sciamani glam e caricature afrocentriche, le quali sfilavano accanto a Clinton nei panni del Dr. Funkenstein, alter ego tra lo stregone, il predicatore e l’imbroglione. Ogni personaggio del pantheon P-Funk, da Starchild a Sir Nose d’Voidoffunk, da Mr. Wiggles all’Undisco Kidd, era tassello di una narrazione mitologica che opponeva la Funkentelechy (intelligenza funk positiva) alla Placebo Syndrome della disco music: non una sterile polemica estetica, ma una precisa messa in discussione dei valori dominanti dell’intrattenimento black, percepiti come addomesticati, neutralizzati, apolitici.
Il 1978 vide infine l’irruzione del progetto nella cultura di massa con «One Nation Under A Groove», sintesi riuscitissima tra urgenza danzabile e utopia sociale, consacrato dalla risposta commerciale e dalla ricezione critica. L’omonimo singolo divenne un inno intergenerazionale, mentre «Flash Light» e «Aqua Boogie» dei Parliament, potenziati dall’invenzione timbrica di Bernie Worrell al basso Moog, consolidavano il dominio P-Funk nel mainstream. Al punto che la Mattel, fiutando il potenziale narrativo e visivo della saga, ipotizzò una linea di action figures modellata sui personaggi clintoniani. Il progetto abortì a causa di dispute economiche, ma fu rivelatore del grado di penetrazione culturale raggiunto da quella che era nata come un’operazione radicale di riscrittura dell’identità nera attraverso il suono. L’ultimo atto simbolico del decennio fu «Uncle Jam Wants You» (1979), opera dall’estetica più marcatamente elettronica e copertina che ritraeva Clinton alla maniera di Huey Newton, seduto su un trono armato, emblema della continuità tra utopia afrofuturista e retaggio del Black Power. Il messaggio era chiaro: non vi era cesura tra arte e politica, ma una complicazione necessaria tra la reinvenzione della rappresentazione e la lotta per il riconoscimento. Clinton, consapevole dei propri limiti tecnici non suono, non canto, non arrangio come altri. Per contro, si proponeva come visionario integrale, capace di osservare dall’alto ed agire come architetto di una polis sonora fluida, eccentrica, inclusiva. Il punto d’equilibrio stava proprio lì: nell’irriducibile capacità di tenere insieme estetiche apparentemente antitetiche, ossia l’oltranza freak ed il rigore militante, la danza sfrenata e l’invocazione sacrale, l’ironia demenziale e l’afropietà, componendo, nella forma e nella sostanza, la più radicale enciclopedia sonora dell’esperienza afroamericana del secondo Novecento. Tanto che, già allora, si profilava, invisibile e sinistro, il rischio dell’entropia interna, dell’eccesso che divora sé stesso, della creatura mitica che fatica a rigenerarsi. Chissà se Clinton, scrutando «la situazione dall’alto», ne avvertì il presagio.
Appare del tutto plausibile e storicamente fondato affermare che George Clinton e il suo ecosistema creativo siano stati oggetto di discriminazione sistemica, tanto sul piano della ricezione critica quanto in termini di riconoscimento istituzionale. La tardiva inclusione nella Rock and Roll Hall of Fame, avvenuta nel 1997 (con i Parliament-Funkadelic nel loro insieme), a fronte dell’impatto epocale e strutturale del loro operato già a partire dalla metà degli anni ’70, rappresenta una spia significativa di questa dinamica. L’establishment culturale bianco, che ha storicamente detenuto le leve della legittimazione all’interno del rock e delle narrazioni ufficiali della musica popolare occidentale, ha spesso dimostrato lentezza, quando non resistenza esplicita, nell’assorbire forme espressive afroamericane non immediatamente riconducibili a codici «decifrabili» secondo i canoni eurocentrici. Il P-Funk, con la sua politicità implicita, la sua estetica eccessiva, il suo rifiuto di ogni categorizzazione, risultava difficilmente assimilabile. In altre parole, Clinton non solo era nero, ma troppo nero, ossia non rappresentava «l’acceptable blackness» che il mainstream era disposto a tollerare, ma un’esplosione anarchica di identità multiple, sessualità ambigue, visioni afrofuturiste ed ironia iconoclasta. Questa complessità non fu solo motivo di esclusione simbolica, ma anche di marginalizzazione discografica. Il sistema P-Funk, per quanto rivoluzionario, si esaurì commercialmente molto prima che artisticamente, travolto da un mix di crisi economiche, contratti vessatori, battaglie legali per i diritti d’autore e, non da ultimo, il cambio di paradigma imposto dal nuovo ordine musicale degli anni Ottanta, che privilegiava forme più compatte, linearmente mercificabili, depurate del disordine postmoderno che Clinton incarnava.
Nel confronto con artisti bianchi coevi – anche quelli che derivavano o saccheggiavano direttamente dal funk nero – il divario nei tempi e nei modi della canonizzazione è evidente. Basti pensare che i Parliament-Funkadelic hanno dovuto attendere l’ingresso nella Rock Hall fino a ben quattordici anni dopo l’ammissione dei Grateful Dead (1994), una band simile per proliferazione mitologica e struttura collettiva, ma culturalmente radicata nella controcultura bianca. Analogamente, i Talking Heads – i cui dischi fondamentali si reggono su un’evidente assimilazione della grammatica funk, e che nel 1980 registrarono «Remain In Light» con un Clinton ancora emarginato – vennero introdotti già nel 2002. Ed ancora, i Queen, band sicuramente innovativa ma stilisticamente più ortodossa, furono inclusi nel 2001, mentre Prince, anch’egli afroamericano, ma percepito come figura più «domabile», venne accolto nella Hall Of Fame nel 2004, a dispetto della sua stessa filiazione diretta da Clinton. Il ritardo, quindi, non può essere letto semplicemente come svista cronologica o difetto di valutazione artistica, piuttosto quale sintomo di una gerarchizzazione strutturale che ha sistematicamente privilegiato le narrazioni bianche del rock ed ha marginalizzato, re-interpretato o minimizzato il contributo afroamericano, anche quando esso si configurava come fondativo. Clinton, come altri innovatori neri (basti pensare a Sly Stone o Gil Scott-Heron), ha subìto non solo l’oblio selettivo, ma anche la riappropriazione parziale. Il suo lessico musicale è stato spesso riciclato da artisti bianchi senza che ciò comportasse un riconoscimento simmetrico del suo valore.
L’evoluzione artistica e biografica di George Clinton a partire dalla conclusione degli anni Settanta rappresenta un capitolo cruciale per comprendere tanto il declino quanto la resilienza di una delle figure più emblematiche della black music contemporanea. Dopo un decennio di straordinaria prolificità, che vide la pubblicazione di diciannove album tra Funkadelic e Parliament, accompagnati da vendite rilevanti nell’ordine di milioni di copie, il sistema creato da Clinton entrò in crisi a causa di fattori molteplici e convergenti. Problemi finanziari dilaganti, contenziosi legali legati ai diritti d’autore e tensioni interne dovute all’abuso di sostanze stupefacenti segnarono il progressivo smantellamento di un impianto musicale fino a quel momento rivoluzionario e coerente. Il richiamo di Bootsy Collins, che sintetizzò efficacemente l’impatto disgregativo della cocaina rispetto all’originaria coesione garantita dall’LSD, fotografa bene la contraddizione che attraversò il gruppo. Il suo ritiro dal palcoscenico nel 1980, in concomitanza con una residenza all’Apollo Theater, simboleggiò il momento in cui la macchina creativa P-Funk cominciò a perdere slancio, fino alla definitiva interruzione dell’attività live nel 1981. Il lavoro discografico continuò, seppur con difficoltà evidenti, con l’uscita di «The Electric Spanking Of War Babies», un album che, con la partecipazione di Sly Stone, evidenziava il legame tra passato glorioso e nuove sfide artistiche, mentre il postumo «By The Way Of The Drum» testimonia un’attività creativa ancora pulsante ma disgiunta dalla forza propulsiva precedente. La svolta degli anni Ottanta fu segnata da un tentativo di rilancio solista con l’uscita di «Computer Games» nel 1982 e il singolo «Atomic Dog», ultimo grande successo commerciale di Clinton. Il decennio vide anche collaborazioni prestigiose, tra cui la produzione per i Red Hot Chili Peppers e il sodalizio con Prince nella scuderia Paisley Park, a conferma del riconoscimento del suo ruolo fondativo anche tra generazioni e contesti musicali differenti. Tuttavia, la sua presenza pubblica divenne intermittente, in parte a causa delle difficoltà personali che ne accompagnarono la parabola artistica.
Gli anni Novanta rappresentarono una nuova fase di rinascita, favorita dalla convergenza tra la cultura elettronica emergente della techno di Detroit e l’esplosione globale dell’hip hop, che accolse Clinton come figura ispiratrice e fonte primaria di campionamenti e riferimenti stilistici. Il suo contributo divenne fondamentale per il cosiddetto G-Funk californiano, incarnato da Dr. Dre, che trasse linfa vitale proprio dall’estetica e dal sound prodotti da Clinton e dalla sua compagine. L’album «Dope Dogs» del 1994 sancì questo nuovo impulso creativo, mentre la partecipazione al festival Lollapalooza dimostrava il suo rinnovato interesse e coinvolgimento nel panorama musicale contemporaneo. La vita privata e pubblica di Clinton negli anni successivi fu segnata da episodi emblematici, come l’incontro con Chelsea Clinton, che fotografa le contraddizioni di una figura che, pur avendo raggiunto la dimensione di icona, rimaneva segnata da fragilità umane e dipendenze. Nonostante ciò, la sua eredità non si affievolì: l’uscita di nuovi album nei decenni successivi, tra cui il monumentale «First You Gotta Shake The Gate» del 2014 e il doppio «Medicaid Fraud Dogg» del 2018, testimonia una volontà di continuare ad innovare ed a dialogare con le trasformazioni della black music. Le collaborazioni con artisti come Kendrick Lamar e Flying Lotus confermano il suo status di mentore e riferimento imprescindibile per le generazioni più giovani. Il conferimento nel 2019 del Grammy Lifetime Achievement Award rappresenta un riconoscimento tardivo ma dovuto alla portata e alla profondità dell’impatto culturale di Clinton. Tuttavia, il progressivo deterioramento delle sue condizioni di salute, culminato con l’innesto di un pacemaker e l’abbandono definitivo dei concerti, segna la conclusione di un percorso che ha saputo attraversare senza perdere la propria essenza una delle epoche più complesse e fertili della musica afroamericana e mondiale, incarnando un paradigma di resilienza artistica e innovazione culturale.
In ultima istanza, va detto che Clinton stesso, pur avendo denunciato la disparità di trattamento e la durezza dell’industria nei confronti degli artisti neri, non ha mai costruito la sua retorica pubblica attorno al vittimismo. Piuttosto, ha scelto la via del travestimento, dell’esagerazione comica, dell’allegoria mitologica per esprimere tensioni e ferite: la nave madre, i personaggi grotteschi, le parodie della supremazia bianca sono strumenti critici mascherati da spettacolo. Clinton è stato discriminato non solo per la sua blackness, ma per la radicalità con cui ha rivendicato e reinventato quella blackness in forme inclassificabili. La tarda ammissione nella Hall of Fame non ha cancellato quella lunga invisibilizzazione, ma ne rappresenta il tardivo riconoscimento. Un riconoscimento dovuto più ai suoi epigoni che ai suoi contemporanei.