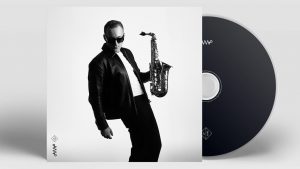Jimmy Smith, la rivoluzione pacifica dell’organo Hammond

Jimmy Smith
Smith non ha seguito la corrente, ma l’ha deviata, incanalata in una nuova direzione, e nel farlo ha creato un linguaggio che, pur dialogando con quello dei suoi colleghi, mantiene una singolarità che lo rende, a tutt’oggi, riconoscibile fin dalle prime battute.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Se nel jazz moderno lo swing è il ritmo, il soul lo spirito guida, il funk è il nerbo, un fermento attivo, uno scudiscio sferzante di energia che produce il cosiddetto groove, un misto di anima e beating. Figlio del blues, della stessa sostanza del padre, generato non creato, il funk è stato un elemento cardine soprattutto nell’evoluzione dell’hard bop. Esiste anche un funk figlio sui generis di quell’ala dissenziente ed antagonista del soul metropolitano, nato molti anni dopo da una costola della new thing, che porterà fino alla nascita dell’hip-hop, il quale, a sua volta, diventerà elemento di commistione con il jazz a partire dagli anni Ottanta, reiterando quella circolarità tipica della cultura afro-americana, basata sul principio dei vasi comunicanti.
Quando si parla di soul-jazz nell’accezione più larga del termine, appare inevitabile fare riferimento all’organo ed al suo principale alfiere, Jimmy Smith, il quale operò una ricollocazione dello strumento in un contesto più moderno e laico, ma soprattutto rendendolo applicabile al linguaggio e alle dinamiche del bop. La storia dell’organo nel jazz è sicuramente collegata all’Hammond, strumento progettato da Laurence Hammond che, a partire dal 1935, cominciò a diffondersi nelle chiese battiste afro-americane a supporto dei canti gospel. Fu un’invenzione epocale che incontrò subito i favori di molte comunità religiose per via dei costi ridotti e per la facile trasportabilità rispetto ai pipes organ (organi a canne) utilizzati nel rito cristiano-cattolico. Grazie all’ideazione di potenti amplificatori, gli Hammond-Leslie, l’organo divenne uno strumento assai versatile, oltrepassando l’ambito sacro e ponendosi al centro del mercato discografico: fu proprio Jimmy Smith, negli ’50 e ’60, a reinventarne l’uso definendo quel sound riconoscibile, tipico dell’organo trio, attraverso i suoi primi dischi marchiati Blue Note, tanto da influenzare numerose generazioni di «hammondisti». Fats Waller, Count Basie e Wild Bill Davis lo avevano preceduto, ma attraverso un uso più rudimentale dello strumento. Fu Jimmy Smith a rendere l’organo popolare ed universalmente accettato, estendendone il vocabolario sonoro oltre ogni immaginazione, tanto da renderlo uno strumento solista alla pari dei fiati e del pianoforte.
Soprannominato «The Incredibile» per la sua tecnica straordinaria, Jimmy Smith, figlio di due pianisti professionisti, a nove anni vinse un concorso per giovani talenti partecipando a vari programmi radiofonici nei panni del classico «bambino prodigio». Dopo aver studiato contrabbasso e pianoforte, scelse di passare definitivamente all’organo formando un trio con il quale si esibì regolarmente al Bohemia Café di New York, dove conquistò la stima ed il rispetto di quasi tutta la critica dell’epoca, ma soprattutto, in breve tempo, fece compiere all’organo elettronico nel jazz un salto evolutivo paragonabile a quello innescato da Charlie Christian con la chitarra elettrica. A partire dal 1962, Smith allargherà i suoi confini musicali in quell’area indefinita, una sorta di porto franco, compreso tra il jazz e il rhythm and blues, divenendo molto popolare anche tra un pubblico, non solo di colore, interessato a una forma di musica più fruibile, ballabile e commerciale. Smith fece un uso diverso rispetto a quello riservato solitamente al pianoforte o all’organo da chiesa. Senza la sua innovativa tecnica e le ricerche sulla sonorità il mondo del jazz avrebbe mantenuto una certa distanza da questo strumento che tendeva a sovrastare tutti gli altri. Smith eseguiva linee di basso in movimento con accordi provenienti dalla mano sinistra, mentre gli assoli erano suonati con la mano destra, attraverso una mistura esplosiva di soul-funk che punteggiava ogni brano, in particolare i tagli up-tempo. Una perfetta fusione di influenze R&B, blues e gospel con riferimenti e dispositivi bebop dava vita ad un suono festoso ed attraente, il quale produsse nell’immediato una fitta schiera di replicanti e succedanei, tra cui Charles Earland, Richard «Groove» Holmes, Jack McDuff, John Patton, Johnny «Hammond» Smith e Lonnie Smith, mentre le sue sessioni per la Blue Note, tra 1956 ed il 1963, divennero dei tormentoni nell’airplay radiofonico di quegli anni, inducendo altri ambiti musicali, come il soul ed il rock, nonché artisti di differente estrazione, a fare uso dell’Hammond B3.
l’Hammond è uno strumento fragoroso e dominante, ed è proprio in questa natura ridondante che Jimmy Smith ha trovato il terreno più fertile per la sua rivoluzione sonora. L’organo Hammond, lungi dall’essere uno strumento da sottobosco timbrico, s’impone con una voce che occupa lo spazio e lo modella: le sue risonanze vibrano nell’architettura armonica con una potenza che non lascia margini all’indifferenza. Smith ha saputo incanalare questa energia, domarla senza smorzarla, trasformandola in un veicolo narrativo capace di passare dalla solennità gospel alla frenesia bebop, dal lirismo blues alla tensione modale. Non è mai uno sfondo: è un protagonista, ma non prevaricatore. Nel suo fraseggio c’è densità, ma anche dinamica; c’è volume, ma anche controllo. Il fragore diventa struttura, e la dominanza si fa ascolto. Altri avrebbero ceduto all’eccesso decorativo o al virtuosismo vuoto, Smith invece scolpisce lo spazio sonoro come un architetto espressionista, dove ogni ruggito dell’Hammond diventa parola, ogni vibrazione un pensiero. «Mi ci sono volute due settimane e mezzo per trovare il mio suono e quando l’ho fatto, gli ho tirato fuori tutto ciò che ho potuto trovarci dentro». Cosi, Jimmy Smith racconta la conquista dello strumento. Il suo tempismo fu perfetto, quasi un contraccolpo in opposizione alla scuola cool, proprio quando il jazz era in procinto di tornare alle origini, riscoprendo la matrice blues e gospel. All’epoca, Laurens Hammond stava migliorando il modello di Hammond A, introdotto per la prima volta negli anni ’30, perfezionandone le specifiche e ridimensionando le due tastiere, nonché l’eccesso di pedali e drawbar, per giungere al più elegante e sofisticato design del B3. Smith riuscì ad avere il suo primo Hammond B3 nel 1953 e presto ideò un metodo per domare la complessità della macchina: «Quando finalmente ho avuto abbastanza soldi per dare un acconto, ho preso il mio organo, l’ho messo in un magazzino, ho preso un grande foglio di carta ed ho disegnato una planimetria dei pedali. Ogni volta che volevo misurare gli spazi e quando abbassare il piede e su quale pedale, guardavo il grafico. A volte restavo lì quattro ore o forse tutto il giorno quando avevo nuove idee da studiare». Sviluppare uno stile indipendentemente da qualsiasi influenza esterna, isolandosi dal mondo e per lungo tempo, fu la chiave di volta del successo. La sua tecnica, immersa nella tradizione gospel, con corse rapide sulla tastiera ed un uso bizzarro dei pedali, divenne qualcosa di unico e di mai sentito prima. Smith aveva iniziato a suonare nei club di Filadelfia, accogliendo allo Spider Kelly’s un giovane John Coltrane per un breve periodo. Ricorda Trane: «Sono stato con Jimmy Smith, per circa un paio di settimane, prima di unirmi a Miles. Sì, l’organista! Mi svegliavo nel cuore della notte, amico, ascoltando quell’organo. Sì, quegli accordi che mi urlano ancora in testa».

Non passò molto tempo prima che il «fenomeno» dell’organo attirasse il boss della Blue Note Alfred Lion il quale, intuendone le potenzialità, offrì a Smith un contratto discografico. Il successo fu istantaneo, tanto che la presenza di Jimmy Smith alla Blue Note, alle cui sessioni parteciparono Kenny Burrell, Art Blakey, Lee Morgan, Lou Donaldson, Stanley Turrentine e Jackie McLean, produsse un flusso di reddito garantito per circa sette anni. A metà degli anni ’70 Smith scelse di stabilirsi con la moglie nella San Fernando Valley, in California, per gestire un Supper Club, il quale fallì nel breve volgere di qualche tempo, costringendo l’organista a riprendere le registrazioni e le esibizioni nei vari festival, ma senza ottenere il consenso ricevuto in passato. Con l’arrivo della disco-music e del funk da discoteca Smith si approccio a questo nuovo genere di consumo ricevendo, però, solo qualche lusinghiera recensione. In fondo, la giubilante stagione Blue Note ed i fasti della Verve erano stati archiviati agli atti e sull’altare del jazz mainstream, mentre altri sacerdoti presidiavano ai sacrifici e alle orazioni, mentre molti eretici banchettavano in cene sontuose e trimalcionesche con l’intrigante ninfa dell’elettronica. Quando Smith assurse agli onori della cronaca, era un musicista completo, ma ciò che lo rendeva attrattivo era quel suo modo unico di suonare l’organo, con il quale attraverso un inedito uso dei pedali poteva sostituire il classico walkin’ bass. L’organista aveva assorbito il veloce lessico bop di Charlie Parker e gli ornamenti pirotecnici di Art Tatum, manifestando una spiccata ed innata abilità melodico-armonica. Il pianista Freddie Redd, avendo assistito ad un’esibizione di Smith a Filadelfia, ne rimase talmente colpito che allertò immediatamente Alfred Lion, il quale non esitò a scritturare il trentunenne maestro d’organo ed aggiungerlo al formidabile roster di artisti già sotto contratto con la sua etichetta.
Tra il 1956 e il 1963, Jimmy Smith incise per la Blue Note una sequenza impressionante di album che non solo hanno ridefinito il ruolo dell’organo Hammond nel jazz, ma hanno anche tracciato una traiettoria stilistica coerente e progressiva, capace di fondere idiomi gospel, blues e bebop in una sintesi personale e riconoscibile. L’esordio, con la serie «A New Sound… A New Star», testimonia già una padronanza tecnica e una visione estetica che si distaccano dalla tradizione organistica precedente, orientata più verso l’intrattenimento che verso la ricerca timbrica e formale. Smith impone un linguaggio ritmico serrato, una scansione del tempo che si avvicina alla pulsazione del walking bass, realizzato con la mano sinistra e con l’uso sapiente dei pedali, mentre la destra articola frasi bebop con una fluidità che richiama i sassofonisti della scuola parkeriana. La serie di registrazioni dal vivo al Club Baby Grand, così come i volumi «Groovin’ at Smalls’ Paradise», restituiscono l’energia del trio in contesto performativo, dove l’interazione con il pubblico e la libertà improvvisativa si fondono in un flusso musicale continuo. In «The Sermon!» e «House Party», Smith si circonda di solisti di primo piano – Lou Donaldson, Lee Morgan, Art Blakey, costruendo lunghe suite modali che anticipano certe soluzioni del soul jazz e del funk strumentale. «Home Cookin’» e «Midnight Special» accentuano la componente blues, con un fraseggio più rilassato ed una tavolozza timbrica che sfrutta le possibilità dinamiche dell’Hammond in modo narrativo, quasi cinematografico.
«Back at the Chicken Shack» e «Prayer Meetin’» rappresentano una sorta di compendio della poetica smithiana: il primo coniuga groove e lirismo; il secondo si avvale della presenza di Stanley Turrentine per esplorare territori più intimisti, dove la spiritualità non è mai declamata ma suggerita attraverso la scelta dei registri e la costruzione delle progressioni armoniche. «Plays Fats Waller» rivela una dimensione filologica, in cui Smith omaggia la tradizione pianistica afro-americana trasponendola sull’organo con rispetto ed inventiva. Le incisioni successive, come «Bucket!», «Rockin’ The Boat», «Softly As A Summer Breeze», pur mantenendo la cifra stilistica dell’autore, mostrano una maggiore attenzione agli arrangiamenti e alla struttura formale, segno di una maturazione che non rinuncia alla spontaneità, ma la incanala in un disegno più articolato. «Open House» e «Plain Talk», registrati nel 1960, ma pubblicati solo nel 1968, offrono una visione retrospettiva del percorso compiuto, con episodi che alternano indagine e slancio ritmico. L’ultima fase del sodalizio con la Blue Note, culminata con «Go for Whatcha Know» e «The Master», testimonia una continuità espressiva che non si piega alle mode del momento, ma riafferma la centralità dell’organo come strumento capace di sostenere un discorso jazzistico completo, autonomo, ed al tempo stesso aperto al dialogo con altri idiomi musicali. Smith non ha semplicemente suonato l’organo: lo ha reinventato, rendendolo protagonista di una narrazione sonora che ancora oggi conserva intatta la sua forza evocativa.
Al momento della pubblicazione di «The Sermon!» Jimmy Smith aveva registrato 14 album per la Blue Note ed era una delle attrazioni più richieste dal vivo nei circuiti jazz di quegli anni. Registrato in due sessioni distinte al Manhattan Towers Ballroom di New York, «The Sermon!» rappresenta il vertice espressivo della prima fase discografica di Jimmy Smith per la fucina di Alfred Lion. Pubblicato nel 1959, l’album si articola in tre composizioni che, pur nella loro autonomia, formano un continuum narrativo in cui l’organo Hammond assume il ruolo di protagonista assoluto, non come semplice strumento solista, ma come centro gravitazionale attorno al quale ruotano le dinamiche dell’ensemble.«The Sermon!» non è soltanto un album, ma una dichiarazione di intenti. Smith non si limita a suonare: costruisce ambienti, plasma atmosfere, impone una visione. La scelta dei collaboratori, la durata dei brani, la qualità della registrazione curata da Rudy Van Gelder, tutto concorre a fare di questo disco un punto di riferimento imprescindibile, non solo per gli appassionati dell’Hammond, ma per chiunque voglia comprendere le potenzialità narrative del jazz. «The Sermon!» si avvale di una formazione che, pur variando tra le due sessioni di registrazione (agosto 1957 e febbraio 1958), mantiene una coerenza stilistica e una tensione espressiva che trascende la semplice somma dei singoli contributi. Smith guida l’ensemble con l’organo Hammond, attorno al quale si costruisce un impianto sonoro fitto e stratificato, dove ogni strumento assume una funzione dialogica più che decorativa.
Nella sessione del 25 febbraio 1958, che comprende «The Sermon» e «Flamingo», si ritrovano Lou Donaldson al sax alto, Tina Brooks al tenore, Lee Morgan alla tromba, Kenny Burrell alla chitarra e Art Blakey alla batteria. Donaldson e Brooks sanciscono due approcci complementari: il primo con un fraseggio incisivo e diretto, il secondo con una cantabilità più estesa e meditativa. Morgan, già allora figura emergente, imprime al costrutto una vitalità ritmica che si crogiola con la chitarra di Burrell, sobria e melodica. Blakey non si limita a scandire il tempo, ma lo scolpisce, lo modella, conferendo alla narrazione una pulsazione rituale. La sessione del 25 agosto 1957, da cui proviene «J.O.S.», presenta George Coleman al sax alto, Eddie McFadden alla chitarra e Donald Bailey alla batteria, con Lee Morgan nuovamente alla tromba. Coleman si distingue per un fraseggio più articolato e riflessivo, mentre McFadden, meno noto rispetto a Burrell, contribuisce con un accompagnamento essenziale ma efficace. Bailey, batterista discreto e preciso, secerne un solido groove che consente a Smith di esplorare con libertà le possibilità timbriche dell’organo. La scelta di alternare musicisti di diversa estrazione e sensibilità non risponde ad una logica casuale, ma ad una precisa volontà di costruire un discorso musicale polifonico, dove ogni voce contribuisce alla definizione di un clima e di un’atmosfera. Smith non impone, suggerisce; non dirige, convoca. Il risultato è un concept che, pur nella sua apparente semplicità strutturale, rivela una complessità relazionale che ne costituisce la vera forza.
Le incisioni di Jimmy Smith per la Blue Note si collocano in un territorio espressivo che, pur condividendo alcuni tratti con il linguaggio hard bop dominante tra la metà degli anni Cinquanta e i primi Sessanta, se ne distaccavano per una precisa scelta timbrica e strutturale. Mentre artisti come Horace Silver, Art Blakey, Lee Morgan e Hank Mobley costruivano un jazz energico, ritmicamente incalzante ed armonicamente sofisticato, Smith operava una trasposizione di quegli stessi principi su uno strumento fino ad allora marginale nel contesto jazzistico: l’organo Hammond B3. La differenza non risiede soltanto nel medium sonoro, ma nella concezione stessa del trio. Laddove il piano trio si fondava su una dialettica tra pianoforte, contrabbasso e batteria, Smith sostituì il basso con la pedaliera dell’organo, creando un impasto sonoro più compatto e meno arioso, ma capace di una profondità ritmica inedita. In questo senso, le sue incisioni si avvicinano più alla logica del combo R&B che alla tradizione bop, pur mantenendo una complessità improvvisativa degna dei suoi contemporanei. Rispetto ad altri organisti dell’epoca, come Jack McDuff, Jimmy McGriff o Shirley Scott, Smith si distinse per una maggiore ricchezza espressiva e per una visione più strutturata del discorso musicale. Se McGriff privilegiava il groove e l’immediatezza, e Scott si muoveva in ambiti più lirici, Smith costruì veri e propri affreschi sonori, dove la spiritualità del gospel si fondeva con la tensione armonica del bebop. Il confronto con chitarristi come Grant Green o Kenny Burrell, spesso suoi collaboratori, evidenzia un’interessante complementarità. Mentre la chitarra lavora per sottrazione, con fraseggi asciutti e swinganti, l’organo di Smith riempie lo spazio, lo modella, lo plasma. In questo senso, le sue incisioni non si pongono in competizione con quelle dei suoi contemporanei, ma ne rappresentano una deviazione laterale, un percorso parallelo che ha ampliato le possibilità espressive del jazz moderno. Smith non ha seguito la corrente, ma l’ha deviata, incanalata in una nuova direzione, e nel farlo ha creato un linguaggio che, pur dialogando con quello dei suoi colleghi, mantiene una singolarità che lo rende, a tutt’oggi, riconoscibile fin dalle prime battute.
Il debito che il rock inglese bianco contrasse con Jimmy Smith non risulta tanto diretto quanto strutturale, l’organista non influenzò il rock britannico attraverso citazioni esplicite o imitazioni stilistiche, ma modificando il paesaggio sonoro in cui quel genere prese forma. La sua reinvenzione dell’organo Hammond come strumento solista, capace di sostenere un discorso ritmico ed armonico completo, aprì una via che molti musicisti britannici percorsero, spesso senza saperlo. Jon Lord dei Deep Purple, Keith Emerson degli Emerson, Lake & Palmer, Rick Wakeman degli Yes, Peter Bardens dei Camel, Brian Auger e persino Greg Rolie dei primi Santana – sebbene statunitense – riconobbero l’impatto di Smith sulla loro concezione dell’organo elettrico. Lord, in particolare, traspose l’aggressività ritmica e l’opulenza timbrica dell’Hammond smithiano in un contesto hard rock, amplificandone la potenza con l’uso del Leslie speaker e con una scrittura che fondeva barocco e blues. Emerson portò quell’eredità nel progressive, accentuandone la teatralità e la complessità strutturale. Smith non dispensò modelli melodici o armonici da replicare, ma ridefinì il ruolo dell’organo da strumento di accompagnamento a protagonista. In questo senso, il rock inglese bianco gli deve una ridefinizione dell’architettura sonora, una nuova grammatica timbrica che consentì di superare il dualismo chitarra-pianoforte e di esplorare territori più ampi, dal prog al jazz-rock, dal funk psichedelico alla fusion. Il debito risulta quindi implicito, ma profondo. Senza Smith, l’organo non sarebbe stato percepito come veicolo di espressione potente e versatile. Il suo impatto non si misura in citazioni, ma in possibilità aperte. E quelle possibilità sono state esplorate, amplificate, distorte, ma raramente superate.