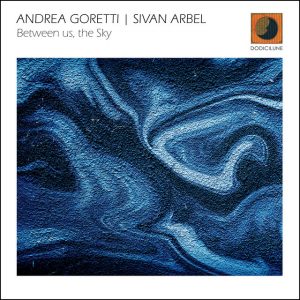Lorenzo Conte & Michele Polga con «Big Pulse», tra Shorter e Chambers: forma e sostanza dell’improvvisazione (Caligola Records, 2025)

Se il jazz contemporaneo rischia talvolta di smarrire la propria urgenza espressiva nell’ossessione per la perfezione sonora, lavori come questo ricordano quanto sia essenziale il gesto, la tensione creativa, l’imprevisto che accade solo nel momento.
// di Francesco Cataldo Verrina //
La registrazione dal vivo, sovente relegata a documento collaterale rispetto alla produzione in studio, assume in alcuni casi il carattere di testimonianza irripetibile, capace di restituire l’immediatezza del gesto musicale con una forza che la rifinitura digitale spesso attenua. «Big Pulse», pubblicato dalla Caligola Records, appartiene a questa ristretta categoria di lavori che riescono a cristallizzare l’energia di un’esecuzione senza filtri, restituendo all’ascoltatore l’impressione di trovarsi a pochi passi dal palco, immerso nella dinamica del dialogo improvvisativo.
Affidato a un quartetto di comprovata esperienza, il disco si apre su coordinate chiaramente riconoscibili: il repertorio attinge con intelligenza alla tradizione afro-americana, selezionando otto componimenti che oscillano fra lo standard colto e la composizione firmata da autentici maestri del tenore, da Wayne Shorter a Joe Henderson, passando per Frank Foster. Una scelta che suona tutt’altro che casuale, se si considera la centralità di Michele Polga nel progetto, da anni considerato fra i più autorevoli interpreti del sassofono tenorile in Italia. La sua voce strumentale, nitida e allo stesso tempo incisiva, si muove con padronanza tanto nei territori più lirici quanto in quelli di maggiore densità ritmica, senza mai indulgere in manierismi. Accanto a lui, Dario Carnovale cesella ogni intervento con misura e lucidità, dimostrando un senso armonico che riesce a fondere introspezione e brillantezza senza forzature. La sezione ritmica, formata da Pasquale Fiore alla batteria e da Lorenzo Conte al contrabbasso, offre un supporto solido ma mai inerte, capace anzi di alimentare continuamente il flusso creativo del quartetto. In particolare, il lavoro di Conte si distingue per una chiarezza di fraseggio e una tensione interna che rimandano direttamente a Paul Chambers.
«Big Pulse» si apre con il brano eponimo, composizione di Wayne Shorter che, sin dalle primissime battute, consente al quartetto di delineare con chiarezza le coordinate espressive entro cui si muoverà l’intero lavoro. L’attacco ritmico è deciso, incalzante, con Pasquale Fiore che articola una trama percussiva nervosa, ma mai invadente, lasciando spazio a un basso pulsante e centrato, in cui Lorenzo Conte modula le risonanze dello strumento con una sensibilità timbrica che esclude ogni meccanicità. Il tema viene esposto da Polga con un fraseggio serrato e un controllo dell’intonazione millimetrico, capace di passare dal registro mediano a quello acuto con naturalezza, senza perdere il corpo sonoro del tenore. Carnovale, dal canto suo, si insinua con intelligenza tra le maglie ritmiche, evitando il virtuosismo gratuito e preferendo linee armoniche dense ma sempre coerenti, spesso risolte in soluzioni che sanno di Monk quanto di Hancock. Senza strappi, il passaggio a «Simone» di Frank Foster trasporta l’ascoltatore in un ambito di diversa grammatura, più disteso ma non meno ricco di sfumature ritmiche. Il motivo si sviluppa su un andamento meno frenetico, e proprio per questo consente alla formazione di esplorare con maggiore libertà l’articolazione dei singoli interventi. Polga si mostra particolarmente attento alla costruzione tematica, privilegiando un discorso che si evolve per metamorfosi più che per rottura, con un uso molto accorto dello spazio e della pausa, che conferisce al suo assolo una qualità quasi narrativa. Il pianoforte lavora per sottrazione, lasciando che la struttura armonica emerga da pochi accordi isolati e ben calibrati, mentre la batteria disegna un sottotesto fluido, che asseconda i picchi emotivi senza mai anticiparli. Il repertorio vira poi verso l’immortale «Body and Soul», pagina che ogni strumentista jazz rilegge almeno una volta nella vita, e che proprio per questo si espone a maggior rischio di manierismo. Nulla di tutto ciò in questa interpretazione, che si distingue per una sobrietà disarmante. La scelta di tempi distesi permette a Polga di distillare ogni frase, lavorando su sottili micro-variazioni dinamiche e su un vibrato appena accennato, mai invasivo. L’accompagnamento è di una delicatezza quasi cameristica: il contrabbasso sostiene con discrezione, il pianoforte cesella arpeggi e clusters armonici con mano leggera, mentre la batteria si riduce a una punteggiatura essenziale, fatta più di intenzione che di suono.
Con «Inner Urge», Joe Henderson torna ad imporsi come riferimento stilistico, ed il quartetto affronta la complessità strutturale del brano con rigore e naturalezza. Il tema, articolato e frastagliato, è reso con precisione ritmica e chiarezza timbrica, mentre l’assolo di Polga si distingue per un uso calibrato delle sostituzioni armoniche, che conferiscono profondità senza compromettere la linearità del discorso. Dal canto suo, Fiore si mostra in tutta la sua versatilità: non solo accompagna, ma partecipa attivamente alla costruzione del fraseggio collettivo, con break e accenti che dialogano in tempo reale con gli altri strumenti, senza mai appesantire l’impalcatura sonora. Il ritorno a un clima più rarefatto avviene con «I Remember You», motivo dall’andamento medio-veloce, in cui il quartetto raggiunge uno dei suoi momenti più compiuti di interplay. La comunicazione tra i musicisti è totale: ogni intervento sembra la naturale prosecuzione del precedente, mentre ogni risposta nasce da un ascolto reciproco che travalica la mera intesa tecnica. Polga abbandona la spigolosità dei componimenti precedenti per adottare un fraseggio più rotondo, quasi canoro, mentre Carnovale si concede una costruzione solistica di straordinaria lucidità formale, dove la componente melodica non è mai sacrificata alla complessità armonica. La sequenza prosegue con «Darn That Dream», episodio di estrema delicatezza, in cui emerge in modo particolare la qualità timbrica dell’intero line-up. Il contrabbasso suona come uno strumento lirico, capace di scolpire ogni nota con il giusto peso, mentre la batteria si riduce a un sussurro ritmico, più evocazione che impulso. Polga affronta il tema con un controllo del suono impressionante: ogni nota vibra di un’intenzione precisa, ogni attacco è calibrato nei minimi dettagli, senza mai perdere la naturalezza dell’emissione. L’improvvisazione che segue si sviluppa in un flusso continuo, senza fratture, sorretta da un accompagnamento che si direbbe respirare insieme al solista.
«Con Yes Or No» si ritorna all’universo shorteriano, ma in una declinazione più spigolosa e propulsiva. La sezione ritmica si fa qui protagonista, con un drive incalzante che non conosce cedimenti. Il tema, spezzato ed irregolare, viene reso con straordinaria chiarezza esecutiva, lasciando spazio a una serie di assoli costruiti su una tensione crescente. Fiore, in particolare, si distingue per un assolo articolato ed incisivo, ricco di escursioni dinamiche e di un controllo timbrico che non indulge mai all’esibizione muscolare. Il quartetto o sembra lavorare come un organismo unitario, in cui ogni gesto trova eco e rilancio negli altri, con una tensione collettiva che si fa quasi fisica. Il cerchio si chiude con «Whims Of Chambers», omaggio sentito e dichiarato a Paul Chambers, figura seminale per ogni contrabbassista moderno. Conte lo interpreta non come semplice tributo, ma come sintesi della propria visione musicale: solida, articolata, generosa nel sostegno e sottile nell’articolazione ritmica. Il contrabbasso guida il discorso, senza imporsi, come una voce che conosce il valore del silenzio tra le note. L’ensemble agisce con naturalezza, trovando un equilibrio tra intensità e misura che rappresenta forse il punto più alto del disco in termini di coesione estetica. «Big Pulse» non si limita dunque a documentare un riuscito live-act: è piuttosto un atto di fiducia nella vitalità della prassi jazzistica dal vivo, un’ode alla fragilità luminosa del tempo musicale condiviso. Se il jazz contemporaneo rischia talvolta di smarrire la propria urgenza espressiva nell’ossessione per la perfezione sonora, lavori come questo ricordano quanto sia essenziale il gesto, la tensione creativa, l’imprevisto che accade solo nel momento. Un disco da ascoltare nella sua interezza, lasciandosi trasportare da quel «grande battito» che pulsa sotto la superficie delle note e ne costituisce la linfa vitale.