Vittorio Castelli, voce della tradizione

// di Valentina Voto //
Vittorio Castelli è un esperto di jazz tradizionale, collezionista, musicista, produttore discografico e critico musicale. Ha lavorato per molti anni alla Ricordi e, come produttore e critico, ha collaborato anche con la rivista Musica Jazz. Come clarinettista e sassofonista, figura inoltre tra i protagonisti della vivacissima scena jazz della Milano post-bellica, essendo stato, all’inizio degli anni Sessanta, tra i fondatori dei gruppi Bovisa New Orleans Jazz Band (insieme all’inseparabile Luciano Invernizzi al trombone) e La Swinghera, di cui è tuttora il leader.
D In tre parole, chi è Vittorio Castelli?
R L’ho scritto da qualche parte, forse su Facebook, con una citazione modificata tratta dai Peanuts: “Nacque, vive e morirà”. Mah, non c’è una risposta… cosa dico? Una volta, a un mio compleanno, mi regalarono un biglietto con scritto “Non ti curar di lor, ma guarda e suona”… ecco, potrei rispondere con queste parole – che non sono tre, ma un po’ di più –, nonostante io abbia “guardato” eccome durante la mia vita: in ottantatré anni ne ho vissute di cose.
D Quali sono i tuoi primi ricordi della musica da bambino?
R Non so se questo episodio lo ricordo davvero, forse me lo hanno solo raccontato: mia madre era diplomata in pianoforte, suonava sempre, e ricordo che aspettavo che finisse di suonare – forse anche piangendo un po’ – seduto sul vasino proprio sotto il suo pianoforte. Questo per dire che in casa mia la musica c’è sempre stata. Mia madre, tra l’altro, insieme a mia zia – musicista formidabile, diplomata in violino e con l’orecchio assoluto – negli anni Trenta ha inciso diversi dischi in trio vocale. Facevano cose un po’ alla trio Lescano… ma erano più brave! Mio padre, al contrario, era stonato, però mi ricordo di una mattina tremenda in campeggio, all’Isola D’Elba: ci siamo svegliati ben prima dell’alba per andare in cima al monte Capanne e ricordo che mio padre cantava “La montanara”. Io l’ho imparata quel giorno e, beh, se l’ho imparata, vuol dire che doveva averne fatto un “fac-simile” dignitoso!
D Come sei arrivato al jazz? Come nasce il tuo amore per il jazz?
R Il percorso è stato lungo, e non privo di accidenti… Quando ero in quarta o in quinta elementare, la maestra aveva spiegato a noi “piccoli villici” alcune cose sulla musica: aveva parlato della musica classica e del Teatro alla Scala, e aveva chiuso il suo discorso con “E poi c’è il jazz”. Alla mia domanda su cosa fosse questo ‘jazz’, mi aveva risposto con ignoranza sincera “È quella cosa che senti alla radio”… ma si capiva che non teneva il genere in alcun conto. Ricordo quindi di aver chiesto informazioni a mia madre, la quale però quanto a cultura jazzistica non andava al di là della Rapsodia in blu di Gershwin e non aveva le idee molto chiare. Non ho più pensato alla lezione della mia maestra fino a quando, durante una gita di terza media, non ho sentito alcuni compagni più grandi parlare fitto di jazz e trascorrere l’intera giornata in questo modo.
D E quindi cosa ti è successo?
R Al tempo, il settimanale Epoca aveva pubblicato, in due o tre puntate, una storia del jazz corredata di tante belle fotografie e firmata da Arrigo Polillo; l’ho letta e ho capito che lì succedevano cose interessanti… il mondo della musica classica, guardandolo con i miei occhi di bambino, mi sembrava irraggiungibile, quasi astratto, invece il jazz mi pareva affascinante per le storie di cui era ricco… ed erano solo gli anni Cinquanta! Molto doveva ancora succedere… Alla fine, mi sono fatto portare da mio padre a una delle conferenze con dischi che organizzava Arrigo Polillo e che si tenevano presso una biblioteca sede dell’Usis … Ma c’erano anche i dischi di mia zia paterna, che aveva solo otto anni in più di me e che consideravo un po’ una sorella maggiore: qualche Duke Ellington, Jelly Roll Morton, Harry James, forse anche qualche Armstrong… Da lì ho iniziato a comprare qualche disco anche io… e sono arrivato a lavorare e a vivere in mezzo ai dischi.
D In quali vesti ti trovi meglio: musicista, produttore, critico o collezionista?
R La parola “critico” non mi piace molto: i critici tendono sempre, o quasi, a sovrapporsi agli artisti, pretendendo di insegnare loro cosa dovrebbero fare…Errore! Quello che un critico dovrebbe fare è cercare di far capire cosa succede, cosa si sta ascoltando, senza dire “Questo è bene e questo è male”. Inoltre è dura essere sia critico musicale che musicista: non puoi farlo! Quindi, no, non mi definirei un critico… Collezionista per forza: è difficile dire di no! E sono e sono stato un produttore, certo: ho fatto molti dischi anche per conto mio. Quanto all’essere musicista, ecco, posso dire che quando suono sono contento, perché quello che faccio evidentemente raggiunge il pubblico, ma secondo me non sono un musicista molto bravo… certo, sono un musicista perché suono, ma in fondo non credo di esserlo.
D Vorresti raccontare qualcosa della tua collaborazione con Musica Jazz e della tua attività di critico?
R Per Musica Jazz ho realizzato tanti LP… me ne commissionavano parecchi principalmente per due ragioni: perché sapevo cosa volesse dire progettare un disco, visto che lo facevo quotidianamente, e perché, come collezionista, avevo molto materiale. Se volevano un disco dedicato a Eddie Condon, serviva loro qualcuno che avesse i dischi di Eddie Condon e io li avevo. Ho scritto anche, ma poco. Ho cominciato grazie a un’amica d’infanzia che collaborava con L’Europeo. L’ho incontrata casualmente su un tram e in quell’occasione mi ha proposto di iniziare a scrivere. Era un bel tipo: mi diceva sempre che “lottavo con la lingua” e che non sapevo scrivere, ma che avevo stile. Nonostante questa “lotta continua”, ho scritto per diverse testate, oltre a Musica Jazz e L’Europeo, e sono stato per qualche anno anche il corrispondente italiano della rivista Billboard.
D E della tua esperienza alla Ricordi?
R Ho lavorato alla Ricordi per dodici anni. La mia mansione era quella di Label manager, direttore di etichetta, e mi occupavo della musica Internazionale, quindi mi occupavo di tutto, da Joan Baez a Ella Fitzgerald, da Elton John a Charlie Parker (ad esempio, quando avevamo il contratto di esclusiva con la MGM, avevamo anche tutto il catalogo Verve e quindi… jazz come se piovesse!). Tra l’altro è stata mia l’idea di estendere il logo della Ricordi – quello a tre cerchi bianchi e neri su campo arancione – all’intera etichetta del 45 giri.
D Tornando al jazz ti chiedo: per te ha ancora un senso oggi la parola ‘jazz’?
R No, non ha più senso. Non ha più senso perché non è più jazz. Una volta, almeno in Italia, la parola jazz era guardata con un assoluto sospetto, poi è diventata persino di moda. Io ti do la mia risposta da tradizionalista: i musicisti di jazz sono tutti morti (o quasi). Non vorrai mica chiamare jazz la fusion! I musicisti fusion fanno le loro cose, ma non fanno jazz. E non è un giudizio, ma una constatazione… anche se questa mia opinione non è proprio popolare. Una simile perplessità l’ho espressa anche a Franco D’Andrea, che trovo simpaticissimo e che ritengo un gentleman – oltre che un musicista di solida competenza jazzistica – dopo la sua pubblicazione di quei quattro CD dedicati a Duke Ellington… per me di Ellington lì non c’era nulla. Lo avevo invitato a non chiedermi un giudizio in merito: “Per me va bene perché lo hai fatto tu” gli ho detto “ti do credito perché sei un musicista serio, che sa quello che fa. Però che capisca quello che hai fatto è troppo… non capisco quello che fai, perciò è difficile che giudichi, non posso” E lui ha capito, non si è offeso per nulla. Fa musica al di là del jazz.
D Dunque per te non si può parlare di ‘jazz italiano’… O di qualcosa che è definibile come ‘jazz italiano’ o ‘jazz europeo’…
R Ecco, la questione gira proprio intorno ai musicisti italiani. Il jazz è sempre stato una musica che con l’Italia non c’entrava nulla: ci sono stati e ci sono dei semplici appassionati e dei musicisti che lo amano molto e giustamente vogliono fare jazz, esserne parte, ma il problema è che giocano sempre in serie B, sono destinati ad andare a traino. Da qui per me non si scappa. Diverso tempo fa, al Teatro Manzoni di Milano, ho assistito al concerto in trio di un pianista americano che aveva come batterista un fantastico giovane musicista, figlio di un batterista noto. Ecco, questi sono ragazzi che, sì, studiano lo strumento, ma il linguaggio jazzistico lo captano nell’aria, perché fa parte del loro giro, della loro vita, perché ci nascono dentro…noi invece per forza dobbiamo andare a traino… Penso che in Italia suonare come John Coltrane sia tradizionale tanto quanto suonare come Johnny Dodds: tu cerchi di capire e di riprodurre il linguaggio di Dodds o di Coltrane, ma suoni alla Dodds o alla Coltrane, non inventi nulla … d’altra parte, se inventi troppo, esci dal jazz e fai altro, qualcosa che sa un po’ di jazz, certo, ma che in fondo è altro – musica serissima! ma non jazz. E questo non piace a nessuno, infatti non c’è più nessuno che lo dice. Perciò, può anche darsi che il jazz sia finito… ma non c’è da preoccuparsene un granché: anche la musica barocca non c’è più. Così va la storia.
D Cosa distingue l’approccio al jazz di americani e afroamericani da quello di noi italiani ed europei?
R Il problema è vasto e la prima distinzione da fare per me è proprio quella tra bianchi e neri, anche se non è solo una questione di colore (per spiegarmi meglio ti racconto questo episodio: avevano appena eletto Obama e avevo chiesto a Sonny Rollins se fosse contento di avere un presidente nero, al che lui mi ha risposto che, beh, sì, certo, era contento, ma fino a un certo punto, dal momento che Obama non era nero – sua moglie lo era, lui no!). Alla fine, quelli che hanno fatto la storia del jazz sono sempre i neri… non che i bianchi non sappiano suonare! Magari strumentalmente sono anche più bravi – ormai la situazione è tale che se soltanto hai sentito parlare di un musicista vuol dire che ha una classe professionale altissima –, ma il jazz per me è nero, e l’europeo si colloca dietro al bianco americano. Mi viene in mente Franco Cerri: lo ho conosciuto, ed era un musicista fantastico, ma non si impara il jazz con Franco Cerri. Con Eddie Lang sì, invece: lui ha fatto scuola. Arrigo Polillo (mi sembra fosse lui) si chiedeva perché Django Reinhardt fosse il più originale dei musicisti di jazz europei, e la risposta che si dava era “Perché non conosceva bene il jazz!”: non aveva nessun modello che lo “schiavizzava” ma suonava jazz ugualmente e, per questo, è diventato più originale degli altri.
D Secondo te il jazz deve parlare, attraverso i suoni, di temi sociali, politici, ambientali, filosofici?
R La mentalità jazzistica non è tanto filosofica… però l’importante è che tutti questi temi non siano programmatici: possono emergere dalla musica ma non devono mai essere messi davanti e prima della musica (il problema del Sessantotto, per esempio, era proprio questo!)
D Come vivi tu il jazz in Italia, anche in rapporto alle tue esperienze di musicista sul territorio?
R La situazione è dura in questo momento e il punto di rottura è stato il Covid: come musicisti eravamo arrivati a un livello vivibile che ora sembra dissolto, – e non solo dissolto per me, perché ho ottantatré anni…
D Quanto ai nuovi musicisti di jazz, ce ne sono di significativi in Italia a tuo parere?
R Musicisti di jazz ce ne sono in Italia, anche se con la riserva di cui ti ho detto… ce ne sono molti e anche di un ottimo livello, ma la questione è: fanno la storia del jazz oppure sono solo un fenomeno locale ognuno nel suo momento? I giovani escono dal Conservatorio, sono preparatissimi e suonano bene, tuttavia suonano un jazz formale, non di sostanza… come la musica classica, che viene suonata moltissimo… le scuole ci stanno portando a un punto in cui si organizza un concerto dedicato a Charles Mingus, si assegna una parte a tutti e ognuno suona quello che c’è scritto: questo non è più jazz.





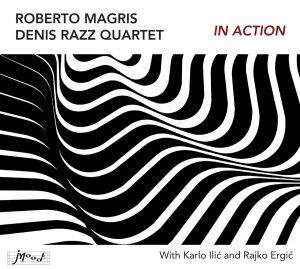

Ciao Vittorio, che Dio ti benedica perchè esisti.
Non ho mai dimenticato gli anni belli vissuti assieme ai tempi del Liceo Scientifico Paolo Grassi di Saronno, ai tempi del C.E.S. e delle nottate musicali improvvisate nella cantina della tua nonna nella villa di Mozzate.
Ti ricordo sempre come un ragazzo, una persona fuori dagli schemi, autenticamente LIBERA.
Sto ascoltando la musica del Duca, e mi sei venuto in mente tu.
Vittorio, grazie di esistere, un grande abbraccio.
Pierangelo.