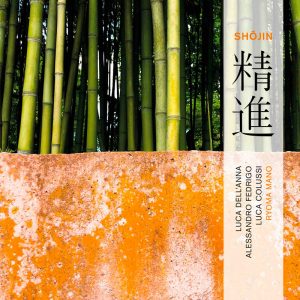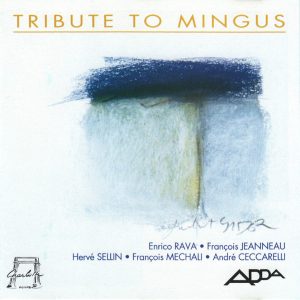Un genio ai margini. Intervista su Johann Fritz Tannhäuser

Paolo Baltaro
// di Guido Michelone //
Nel settembre scorso viene pubblicato in lingua italiana per Banksville Books di Londra il volume “Johann Fritz Tann häuser. Un genio ai margini”, biografia a cura dell’Associazione Culturale Johann Fritz Tannhäuser, i cui principali esponenti – assieme alla direttriceGreta Überlegen – il multistrumentista e produttore Paolo Baltaro e il cantautore e bluesman Giuseppe Garavana sono altresì membri dei S.A.D.O. Società Anonima Decostruzionismi Organici, mitica band tra free, prog, avant-rock, autrice del capolavoro Weather Underground (2010) ma che in questi mesi si sta occupando di eseguire i brani ritrovati del Maestro nei teatri italiani. Ecco quindi l’intervista a Baltaro e Garavana in merito alla misteriosa figura di un compositore sperimentale che a un certo punto scopre la batteria jazz (e quindi il jazz) che gli cambierà per sempre l’estro creativo.
Così, a bruciapelo chi era Johann Fritz Tannhäuser?
Giuseppe: Ogni compositore del passato che si analizza e si esegue, spesso ha la peculiarità di rimanere artisticamente vivo grazie alla bellezza delle sue opere, alla loro popolarità e cosa più importante, alle innovazioni che hanno portato. Johann Fritz Tannhäuser è stato certamente uno dei più grandi innovatori del secolo scorso unendo il contrappunto seicentesco alla modalità tardo impressionista e in base ai periodi storici: all’atonalità, alla serialità e alla musica elettronica. Sul piano personale, possiamo definirlo un intellettuale con sprazzi di follia.
Mi racconti ora il tuo primo contatto con la sua musica?
Paolo: Siamo stati contattati direttamente da Greta Überlegen, direttora dell’Associazione Culturale Tannhäuser, lo scorso febbraio. Personalmente non conoscevo il Maestro, se non per averne soltanto sentito parlare quando frequentavo lezioni di pianoforte con Ettore Righello. Quando mi furono sottoposte le partiture capì immediatamente la portata e il livello delle opere, ne sono rimasto semplicemente folgorato.
Quali sono i motivi che hanno spinto l’associazione che porta il suo nome a occuparsi di lui?
Giuseppe: La grandezza del personaggio contrapposta all’omertà culturale da parte in primis “dell’intellighenzia musicale contemporanea” nei confronti dell’operato del Maestro è stato un campanello d’allarme, convertitosi in un’iniziativa importante. Mantenere vive le opere note, divulgarle con attività di ogni tipo e ricercare nuova documentazione sono gli obiettivi principali dell’Associazione. Siamo infinitamente grati alla direttora Greta Überlegen per la pubblicazione del libro “Un Genio ai Margini” e in realtà per aver iniziato tutto questo.


In particolare cosa è stato scoperto di così importante dai documenti di Asmara?
Paolo: Nei documenti di Asmara è stato innanzitutto rinvenuto un manoscritto della moglie, Johanne Dietlinde. In esso sono contenuti dettagli sulla vita del Maestro a tutt’oggi inediti che hanno chiarito finalmente molti aspetti del suo percorso creativo. Nei documenti sono stati inoltre ritrovate numerose partiture di opere di cui non si sospettava l’esistenza. Alcune di esse sono state oggetto di studio per il nostro gruppo, i S.A.D.O. per riproporli dal vivo adattandoli alla strumentazione moderna. Abbiamo già fissato numerose performances, fra le quali il 19 di ottobre 2024 alla Casa della Musica di Parma, in apertura del concerto del grande Patrizio Fariselli, tastierista degli Area.
Come mai un artista così aperto e progressista come lui non lasciò mai la Germania nazista?
Giuseppe: In realtà fin dall’inizio del regime iniziò a frequentare circoli operai, anche se non in modo assiduo e senza mai iscriversi ad alcun partito politico. Proprio in quegli anni aveva finalmente trovato un lavoro (per mantenersi) nel mondo del cinema che da poco aveva conosciuto l’invenzione del sonoro. Il suo impiego ufficiale era la microfonazione per la ripresa audio, ma talvolta la composizione di musica applicata. Adorava lavorare con registi emergenti per cercare di ottenere una sinestesia sperimentale senza precedenti (come in “Das Geheime Labor”). Inoltre in pochi sanno che collaborò alla realizzazione di “Olympia” ( anche se riuscì a non farsi accreditare per evitare un contatto anche solo nominale con il regime. Solo all’inizio degli anni Quaranta si unì al “Bekennende Kirche” (chiesa confessante), un movimento di resistenza cristiana contro il nazismo e contro la manipolazione della fede.
Lui da cristiano non si accorse mai delle atrocità dei nazisti verso gli Ebrei?
Paolo: La sua appartenenza al “Bekennende Kirche” testimonia la sua avversione al Nazismo, tuttavia non dobbiamo dimenticare che in quel periodo non era chiaro a tutti cosa stava avvenendo al di là di certi fili spinati. La stessa posizione morbida del Pontefice rendeva difficile la percezione dei fatti ma è chiaro che l’essere attivo in un movimento di resistenza prova una probabile posizione del Maestro al riguardo.
Quali sono i concetti o i sentimenti associabili alla musica di Tannhäuser?
Giuseppe: Nel periodo berlinese (1917-1926) sicuramente il sentimento di rabbia nei confronti delle istituzioni tedesche per la carneficina della prima guerra mondiale fu importante (oltre che contro gli stati vincitori per il ripugnante trattato di Versailles). Nel conflitto aveva perso la maggior parte dei suoi amici d’infanzia e quello fu un dei motivi per cui si spostò a Berlino. Due delle opere più importanti di questa epoca sono proprio legate a questa tematica: “Wiein Stücke Gerissene Küken (Come pulcini fatti a pezzi) e Vermisste Freunde (Amici Scomparsi). Nel periodo in cui lavorò come tipografo presso la stamperia musicale sviluppò anche un sentimento contrario allo sviluppo tecnologico ed alla meccanizzazione della vita moderna. Da qui scrisse la composizione totalmente innovativa “Nachhaltige Zentralheizung” (Riscaldamento Centralizzato). Nella maturità trattò abilmente temi come la seduzione di ciò che è materiale (in ““Der Prinz auf dem Granatapfel” – “Il Principe sul Melograno”, 1950) alla scalata sociale tardosettecentesca della borghesia con analogie a lui contemporanee (in “Palingenese des Niedergangs von Baron Hoffmann” – “Palingenesi della Decadenza del Barone Hoffmann”, 1955). il tema del “l’amore” era sempre presente nelle sue opere del dopoguerra, ma mai in prima linea.
E cosa significava per lui il jazz di cui usò la batteria per molte composizioni?
Paolo: Cito testualmente dalla biografia appena pubblicata: “Una sera, presso il Ballhaus “Zum Seppl”, un famoso locale frequentato dagli studenti, Tannhäuser assistette all’esibizione del trombettista Philippe Brun. La bravura e il carisma del batterista Polly Guggisberg lo colpì. Ascoltando un suo assolo nel brano “Study in G” gli parve di sentire più percussionisti in un unico esecutore e realizzò che avrebbe potuto affidare a un unico musicista l’esecuzione di parti che sarebbero state normalmente affidate ad almeno tre professori d’orchestra.”
Quanto contava la scrittura e quanto l’improvvisazione nel suo modo di fare musica?
Giuseppe: La scrittura rappresentava molto per Johann essendo un musicista di formazione quasi totalmente classica. Tuttavia, con il suo innamoramento del jazz negli anni 30 iniziò a prediligere organici sempre più ridotti (anche per le opere liriche create ed eseguite nel dopoguerra) per garantire una maggior coesione, ed interattività tra gli elementi che eseguivano la sua musica. Si sostiene che alcuni pezzi fossero sue improvvisazioni scaturitegli dal pensiero e trascritte sul momento. Essendosi appassionato anche di musica elettronica (per l’evoluzione strumentale soprattutto) aveva una mentalità tridimensionale probabilmente senza precedenti. L’uso delle Onde Martenot è stato sicuramente uno degli elementi più iconici nelle sue composizioni.
Tra i brani che ha composto ce n’è uno a cui l’associazione è particolarmente affezionata?
Paolo: Non mi è dato sapere quale brano l’Associazione prediliga, tuttavia posso dirti che, nell’eseguire i brani, il nostro gruppo è stato particolarmente colpito da “Rund”, il pezzo nato dai confronti dialettici fra il Maestro e il filosofo Karl Jaspers.
E se si dovessero fare dischi su di lui con quale opera si potrebbe iniziare?
Giuseppe: Uscirà (a data da destinarsi) un disco tratto da varii concerti performati dal tour dei S.A.D.O. sull’antologia della maturità di Tannhäuser (tra i varii concerti uno con Patrizio Fariselli degli Area)
Qual è stato il momento più bello della sua carriera di musicista?
Paolo: Immagino che il dopoguerra, con la composizione della “Kunstliche Trilogie” (Trilogia Artificiale) il Maestro abbia goduto dei suoi tempi migliori. Questa trilogia, concepita come un percorso di esplorazione artistica e filosofica, rappresentava un’evoluzione naturale del suo lavoro, andando oltre i temi dell’alienazione e della decadenza, nell’ottica di una sperimentazione musicologica unica nel suo genere.
Come vedete la situazione su un possibile rilancio della figura e dell’opera di Tannahuser?
Giuseppe: È già capitato che grandi compositori del passato siano stati per un periodo tralasciati per poi essere ripresi dopo anni da altri (penso a Bach per mano di Mendelsshohn), noi facciamo semplicemente in modo che questo possa accadere con Johann Fritz Tannhäuser il prima possibile.