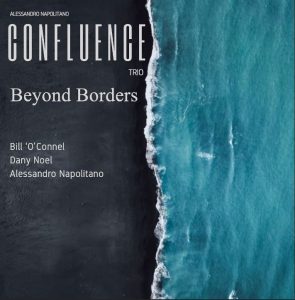Vinile sul Divano: schizzofonie terzomondane

// di Gianluca Giorgi //
Ian Carr, Belladonna (1972 ristampa 2021)
Ian Carr, trombettista scozzese classe 1943, è stato tra i fautori e tra i più importanti musicisti del jazz moderno britannico. Quasi contemporaneamente alla svolta elettrica di Miles Davis, in Inghilterra (da dove peraltro provenivano John McLaughlin e Dave Holland, chitarra e basso di “In a silent way”) si sviluppò una vitale via europea al jazz-rock. Insieme a Soft Machine e Matching Mole, ma un po’ defilati rispetto a quello che viene comunemente ricordato come il ‘Canterbury sound’, troviamo i Nucleus, fondati nel 1970 dal trombettista Ian Carr, tra i primi a tentare la fusione alchemica dei due generi. Il trombettista in precedenza aveva dato vita al Rendell-Carr Quintet. Tutto inizia da qui, da questo disco seminale che scuote la scena musicale inglese col suo jazz elettrico, a volte etereo a volte duro ma suonato con immensa maestria. Un suono che accontenta sia chi ama il rock e chi segue il Jazz. Dopo Miles Davis sicuramente il più coraggioso e sperimentale dei Jazzisti non solo in Inghilterra. Di fatto è il suo primo album solista. Il titolo del disco è “Belladonna”, suo picco massimo a livello compositivo e strumentale. “Belladonna” è un punto di svolta per Ian Carr in quanto caratterizzato da suoni molto suggestivi, la fusione tra jazz e rock in tutti i brani che compongono questo progetto è perfetta. Il fiore all’occhiello è sicuramente la svolta rock e psichedelica che dà Holdsworth con la sua chitarra. Notevoli i suoi assoli. “Belladonna” è un torrente di note che sgorga ora rapido e vibrante ora riflessivo, leggiadro e sofisticato. Musica elevata, destinata ad un ascolto elevato e quanto mai selezionato. Un applauso alla Mr. Bongo per questa ottima ristampa lungamente attesa!
The Invisible Session, Echoes of Africa (2020)
Dopo quasi 15 anni di silenzio, il co-fondatore della Schema Records Luciano Cantone in collaborazione con Gianluca Petrella e un nuovo gruppo di musicisti, presentano il secondo album dei The Invisible Session “Echoes of Africa”, primo titolo pubblicato sulla neonata etichetta Space Echo e distribuito dalla Schema Records. I punti di partenza sono l’afro-beat, le registrazioni di Africa 70 e il drumming di Tony Allen. Altre influenze entrano in gioco, con melodie centrate su scale pentatoniche orientali, così come il funk, l’afrobeat, la psichedelia, il jazz modale ed etilico, più incursioni nel pop e nella cinematica.
NAT BIRCHALL, Songs Of The Ancestors – Afro Trane Chapter 2 (ltd ed 2023)
Nat Birchall ci presenta il secondo capitolo del suo omaggio ai grandi sassofonisti del XX secolo e di tutti gli artisti che diffondono la Musica in giro per il mondo, dai primi tempi fino ad ora. Un disco “preso in prestito” dal Jazz Modale e dallo Spiritual Jazz. Questa è la quinta delle registrazioni “one-semble” di Nat in cui suona lui tutti gli strumenti. La musica attraversa i continenti, le culture ed il tempo, e quando parla della verità, trascende la genealogia musicale e continua una linea temporale dalle prime fonti fino ai giorni nostri. Questo è il pensiero di Nat che con questo album rende omaggio alla musica e ai musicisti che lo hanno ispirato in tanti modi, non solo in quelli musicali. Cedric Brooks, Count Ossie, John Coltrane, Pharoah Sanders e tutti coloro che suonano musica con passione disinteressata e che parlano al cuore. Il sassofonista Nat Birchall è sempre stato una specie di enigma, un sassofonista sublimemente soul nascosto sulle colline settentrionali dell’Inghilterra. Cresciuto in un villaggio settentrionale non si è avvicinato alla musica con il jazz, ma attraverso alcuni amici con cui ha conosciuto le radici reggae e dub nei primi anni ’70 e sono stati i leggendari sassofonisti giamaicani influenzati dal jazz, Cedric Brooks, Tommy McCcook, che lo hanno ispirato a prendere il sassofono e attraverso di loro ha scoperto la musica di John Coltrane. Birchall per molto tempo ha resistito alla chiamata della scena londinese e ha continuato a cercare la musica che sentiva dentro. È stato l’incontro con il trombettista Matthew Halsall (The Gondwana Orchestra) che lo ha ispirato a produrre materiale proprio. Il suo album di debutto Sixth Sense (1999) è un album di hard-bop modale pulsante, ma il suo “successo di culto” lo ha ottenuto con il successivo Akhenaten, inciso ben 10 anni dopo (2009), disco di jazz spirituale molto ispirato, l’Independent On Sunday lo ha descritto come “jazz spirituale intriso di pioggia da Manchester”, Gilles Peterson (Dj e fondatore di diverse etichette come Talkin’ Loud, Acid Jazz e Brownswood Rec.) considera Nat “uno dei migliori musicisti del Regno Unito”. La musica di Nat si ispira alle opere spirituali di luminari come John Coltrane e Pharoah Sanders, è molto semplice, armonicamente e melodicamente e quindi come dice Nat: “devi suonare con quanta più convinzione e anima possibile perché non c’è nulla da nascondere dietro, solo la verità di come senti la musica”. Sono composizioni che spesso enfatizzano le linee di basso e i ritmi come nella musica giamaicana che per prima ha attirato Nat al sassofono. Un musicista poco appariscente con un suono di sassofono notevolmente comunicativo, per una musica jazz fatta con molto “soul”. Consiglio l’ascolto perché il disco è veramente bello.



King Khan, Infinite ones (2020)
Musicista canadese di Montreal dalle origini indiane, King Khan (aka Arish Ahmad Khan) è un artista emerso nella seconda metà degli anni ’90 nell’area punk, arricchendo progressivamente il suo bagaglio stilistico con influssi jazz, fusion, il mondo delle colonne sonore, la letteratura beat di autori come William S. Burroughs, il funk / r’n’b, la psichedelia, con un approccio eccentrico che lo ha reso uno dei più rinomati performers alternativi della sua generazione. “Infinite Ones” è il terzo album solista di King Khan, inciso con Marshall Allen e Knoel Scott (Sun Ra Arkestra), John Convertino e Martin Wenk (Calexico), Brontez Purnell (Younger Lovers), Be Ra (King Khan & the Shrines) e Davide Zolli (The Mojomatics). “The infinite ones” è un’opera carica di tributi a musicisti che hanno influenzato Khan; Danny Ray Thompson (il brano “Tribute to the pharaoh’s Den” è un requiem per lui) a Yahya El Majid (“Theme for Yahya”), entrambi a lungo membri della Sun Ra Arkestra, e Hal Wilner (“Hal”), il visionario curatore e produttore di interessantissime compilations a tema come: “Lost in the stars: the music of Kurt Weill” (1984), “Leonard Cohen: I’m your man” (2006, colonna sonora dell’omonimo documentario del 2005). Questi personaggi sono tutti scomparsi nel corso del 2020, e le melodie di molti brani dell’album hanno un tono malinconico, lirici e personali requiem; ma in “The infinite ones” si celebra anche la musica di altri artisi, da Alice Coltrane ad Ennio Morricone, da Miles Davis a John Carpenter a Quincy Jones, dal cinema noir a quello della vecchia Bollywood, il tutto con uno stile che intreccia con eleganza e toni notturni, il jazz con i suoi assoli ed il suo lato più lirico, il groove r’n’b, il calore del soul jazz, la malinconica e composta vena di autori come Miles Davis, la suspence ed il mistero delle colonne sonore di genere. Gran bel disco!
Kalia Vandever, We Fell In Turn (2023)
“We Fell In Turn” è l’ultimo disco della trombonista hawaiana Kalia Vandever con sede a Brooklyn, musicista con una sfilza di crediti, tra cui artisti del calibro di Harry Styles, Lizzo e Japanese Breakfast. È un album di trombone solo, strumento non sempre molto attraente da suonare in solo, malgrado ci siano stati ottimi tentativi di diversi musicisti, George Lewis, Albert Mangelsdorf, Paul Rutherford, fra gli altri. La Vandever, comunque, è riuscita nell’intento di produrre un disco non rigorosamente jazz ma neanche troppo lontano da esso. L’album, malgrado le dieci tracce è molto breve, leggermente superiore a mezz’ora. La musica è il risultato di una sessione di registrazione di tre giorni, durante la quale Kalia Vandever ha semplicemente improvvisato, supportata solo dalle istruzioni del suo fido collaboratore e produttore Lee Meadvin, che è anche responsabile delle registrazioni e di tutto il resto. Il risultato è molto vicino allo stile ambient, un po’ più Gavin Bryars che Rico Rodriguez. Durante le registrazioni dell’album l’artista ha ammesso di essere stata ispirata dai ricordi della sua infanzia, trascorsa nella sua nativa Hawaii e ciò si sente nel risultato finale che rimane sempre in uno stato d’animo sottile e malinconico. Il più delle volte i suoni del trombone sono elaborati o affondati in riverberi ambientali, a volte, come nel caso di “Stillness in Hand” o “Teased Traces”, ci sono anche sovrapposizioni sotto forma di parti aggiuntive del trombone. We Fell In Turn è certamente contemplativo, ma coraggioso e splendidamente sobrio.