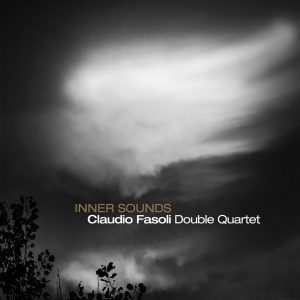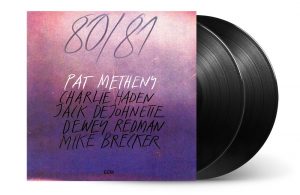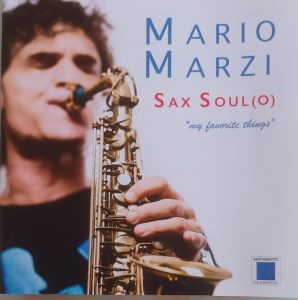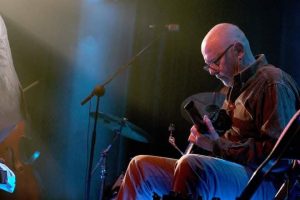«Star Bright» di Dizzy Reece, dove ogni nota è la sillaba di un idioma che parla direttamente al corpo (Blue Note, 1960)

«Star Bright» emerge con le sembianze di un’impalcatura estetica compiuta, un flusso sonoro che sguazza nel mare magnum dell’hard bop con una fisiologia propria, in grado di far affiorare una grammatica musicale che favorisce l’equilibrio, la coesione e la qualità del pensiero esecutivo.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Al momento della pubblicazione, «Star Bright» ricevette accoglienza calorosa da parte della critica specializzata che ne evidenziò la solidità dell’ensemble e la finezza estetica che attraversa l’intero album. Il disco, inciso nel 1959 e pubblicato da Blue Note nel marzo 1960, si colloca come centro gravitazionale di una trilogia che include «Blues in Trinity» e «Comin’ On». Alphonso «Dizzy» Reece, nato a Kingston nel 1931, si forma tra le pieghe della diaspora caraibica che attraversa l’Europa nel secondo dopoguerra. Dopo un periodo parigino e londinese, approda a New York nel 1959, portando con sé una grammatica timbrica che riflette la scuola europea, ma vibra di tensioni afro-americane. Dizzy Reece si fece largo come trombettista dotato di sensibilità espressiva e padronanza tecnica, capace di delineare un profilo acustico soulful e narrativamente variegato. Purtroppo il giamaicano non riuscì mai ad eguagliare la nomea della l’altro Dizzy, ossia Gillespie, vero innovatore ed asse portante della storia del jazz moderno insieme a Charlie Parker. Ciononostante, la voce di Reece si affermò con naturalezza all’interno del paesaggio hard bop, contribuendo con una fisionomia sonora riconoscibile, costruita sulla misura e sull’intensità emotiva. «Star Bright» è l’epitome di un modus operandi propedeutico a quella tipologia di concept ricercati soprattutto dai collezionisti interessati al jazz quale repertorio più che linguaggio evolutivo, sebbene la duratura presenza nel catalogo Blue Note testimoni una visione musicale indirizzata verso la coerenza e la qualità del gesto esecutivo.
L’apporto dei singoli interpreti si dispone secondo una logica di dialogo timbrico. Reece, alla tromba, articola un fraseggio che unisce precisione tecnica e profondità espressiva, delineando una trama sonora che si fa memoria. Hank Mobley, al sassofono tenore, elabora assoli che respirano, modellati con cura ed orientati alla fluidità narrativa. Wynton Kelly, al pianoforte, disegna progressioni che illuminano il tessuto armonico, alternando accompagnamenti calibrati ed interventi solistici di notevole musicalità. Paul Chambers, al contrabbasso, implementa la base ritmica con un rigore mercuriale ed un’intonazione impeccabile, offrendo un sostegno accordale che si riconosce per temperamento e precisione. Art Taylor, alla batteria, scolpisce il tempo con dinamismo e reattività, trasformando ogni episodio in uno spazio ritmico condiviso. La produzione di Alfred Lion e l’ingegneria sonora di Rudy Van Gelder conferiscono all’album una qualità acustica che valorizza ogni sfumatura esecutiva. Van Gelder, con la sua esperienza, catturava il suono con calore e nitidezza, rendendo ogni strumento parte di un disegno armonico coerente. Il Van Gelder Studio, progettato con una ratio architettonica ispirata a Frank Lloyd Wright, non rappresentava un semplice espediente, ma una cassa armonica, un un luogo di risonanza ed un habitat ideale capace di trasfigurare la registrazione in un’esperienza tridimensionale. Rudy Van Gelder, ingegnere del suono, non documentava, ma modellava. Ogni album inciso in quel tempio – da «A Love Supreme» a «Soul Station» – porta la sua impronta invisibile, fatta di microfonazioni segrete ed acustiche calibrate come geometrie timbriche. Il progetto visivo, curato da Reid Miles per il design e da Francis Wolff per la fotografia, completa il progetto di Reece con un impianto grafico che riflette la filosofia estetica della Blue Note, ossia rigore, eleganza e riconoscibilità. Sulla base di tali presupposti, «Star Bright» emerge con le sembianze di un’impalcatura estetica compiuta, un flusso sonoro che sguazza nel mare magnum dell’hard bop con una fisiologia propria, in grado di far affiorare una grammatica jazzistica propedeutica all’equilibrio, la coesione e la qualità del pensiero esecutivo.
La trama dell’album si srotola attraverso sei episodi, ciascuno simile al capitolo di un racconto che non cerca il colpo di scena, ma la continuità. «The Rake» apre con un raccordo melodico che si comporta alla medesima stregua di un filo teso tra due alberi, in cui la tromba di Reece vibra come una corda pizzicata ed il tenore di Mobley risponde come un’eco che non si spegne. Kelly concima il terreno armonico, similmente ad un giardino geometrico, mentre Chambers e Taylor scuotono il tempo, convertendolo in vento che non si vede, ma si sente. «I’ll Close My Eyes» scrive una lettera d’amore mai spedita, in cui il trombettista giamaicano canta con la voce arsa di colui conosce la malinconia, mentre Kelly ribatte con tocchi che sembrano passi su neve fresca. L’ensemble si dispone in cerchio a protezione, lasciando che la melodia si espanda come un pensiero che non cerca risposta. «Groovesville» raffigura una strada di città che vibra al tramonto, dove il blues s’insinua tra le pieghe del ritmo, mentre Kelly accende il pianoforte, facendone lampioni che s’illuminano uno ad uno. Reece e Mobley procedono come due viandanti che conoscono il passo dell’altro, senza bisogno di guardarsi, mentre il swing batte come cuore che sa ascoltare. «The Rebound» si comporta come dialogo tra due menti che pensano in velocità, in cui Reece e Mobley si scambiano frasi alla stregua di duellanti che non puntano alla vittoria, ma alla precisione. Kelly interviene come arbitro che conosce le regole del gioco; dal canto loro, Chambers e Taylor sostengono, impiantando solide fondamenta che non tremano. «I Wished On The Moon» si conforma come sogno che non svanisce al risveglio, in cui la tromba di Reece si fa voce che conosce il desiderio, Mobley gli fa da sponda con fraseggi che sembrano ricordi, mentre il clima si addensa, diffondendosi in una stanza in penombra, dove ogni suono diviene luce filtrata. «A Variation On Monk» chiude il ciclo come un epilogo che rilancia. Gli intrecci tematici si dispongono come geometrie oblique ed i ritmi si articolano quali pensieri avulsi dalla linearità. Reece non cita Thelonious, ma lo evoca come spirito che attraversa la stanza senza parlare, mentre i suoi sodali contribuiscono da conoscitori delle dinamiche gioco, senza mai, però, ripeterle mnemonicamente. A conti fatti, «Star Bright» si attesta come una camera d’eco incisa su vinile, un luogo in cui il suono si rifrange come luce su un cristallo, senza dispersioni. La partitura s’irradia sulla scorta di un perfetto storytelling, senza opposizioni o deviazioni. Reece si lascia scoprire, mentre la sua tromba s’inscrive nel tessuto del jazz alla stessa maniera di un inchiostro che non sbiadisce e di una firma che permane.