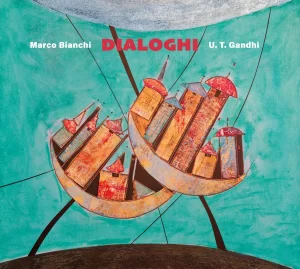Orange Mun con «Love», un altrove sonoro deliberatamente inafferrabile (Filibusta Records, 2025)

La dimensione jazzistica, da cui entrambi i membri provengono, agisce in profondità, non tanto come genere, ma quanto attitudine al rischio, alla sospensione e all’ambiguità.
// di Cinico Bertallot //
Risulta assai difficile stabilire il punto esatto in cui la materia sonora si fa soglia del simbolico; eppure «Love», del duo Orange Mun, alias Martina Gurrieri ed Emilio Longombardo, sembra collocarsi proprio lì, sul crinale mobile fra la dimensione timbrica e quella visionaria, fra la gravità del suono e il volo dell’immaginazione.
Non siamo davanti a un semplice compendio di brani elettronici. «Love» è un lavoro coeso, a tratti claustrofobico, ma mai gratuito nel suo incedere cupo; un concept album solo in apparenza, poiché la coerenza che lo governa non è quella della narrazione esplicita, bensì una tensione costante, tonale, emotiva e retorica, verso un altrove che rimane deliberatamente inafferrabile. Fin dai primi suoni di «All Over You», si avverte un’irrequietezza che non cerca esplosione, ma implosione: la voce si fa fragile invocazione, mentre la grana elettronica, sostenuta da un sapiente utilizzo di synth, drum machine e tastiere, evoca più un magma in subbuglio che una geometria danzante. La lezione della deep house e del soul si percepisce in filigrana, ma è come se venisse filtrata attraverso una lente offuscata, un diaframma emotivo che la rende altra, più introversa e meno coreutica. Con «Healing» si entra nel cuore del progetto: brano quasi liturgico, fondato su un’idea di purificazione sonora che evita ogni retorica new age per sostituirvi un’ascetica scarnificazione timbrica. Gurrieri canta come chi cerca la salvezza non in una luce esterna, ma nel buio stesso da cui si proviene. Il canto non redime, ma incide.
«Future» si configura invece come il nodo critico del progetto, quale interrogazione sulla contemporaneità, sulla tensione performativa dell’io e sulla mistificazione del progresso. Qui l’elettronica si fa più tagliente, pulsante, forse più vicina alla lezione di certa scuola berlinese, ma sempre temperata da una malinconia liquida che impedisce ogni slancio assertivo. Nessuna risposta, ma solo un disorientamento lucido. L’ascolto prosegue fra episodi atmosferici, come «Innocent», dove il sogno e la disillusione si compenetrano in modo perturbante o «S», piccolo poemetto ambientale dove l’aereo, l’addio e la sospensione si intrecciano in una visione rarefatta e straniante. In «Sunrise Overflow» e «One More Sunrise», la polarità giorno/notte, tempo/atemporalità, si fa centro poetico, in una continua tensione verso una rinascita che si lascia solo intravedere. Nulla è lineare, mentre il tempo diventa un labirinto. «Alright» rappresenta forse il momento più «terrestre» del disco, l’affermazione (più desiderata che creduta) che «andrà tutto bene» si staglia su un paesaggio sonoro che ricorda le trame crepuscolari dei Notwist o le confessioni digitali di James Blake, pur mantenendo un’identità linguistica autonoma. Infine, «Lost», ambientato idealmente nella metropolitana parigina, chiude il cerchio nel segno dello smarrimento. Ma non si tratta di un’uscita drammatica o decadente, ma piuttosto di un lento dissolversi nella folla, nella distanza, in una solitudine condivisa che assume i tratti del reale.
Il suono di Orange Mun, Martina Gurrieri ed Emilio Longombardo, si diffonde come una nube sonora densa, opaca, ma con riflessi iridescenti. La scrittura appare introspettiva senza mai essere autoreferenziale, e l’interazione fra voce e suono diviene il vero punto di forza dell’intero lavoro. La dimensione jazzistica, da cui entrambi i membri provengono, agisce in profondità, non tanto come genere, ma quanto attitudine al rischio, alla sospensione e all’ambiguità. In un panorama italiano spesso polarizzato tra l’elettronica «intelligente» es il cantautorato sentimentale, «Love» s’impone come un corpo sonoro anomalo, refrattario a ogni classificazione netta. Siamo di fronte ad un disco che non chiede di essere ascoltato, ma abitato. E forse è proprio questo il suo gesto più radicale.