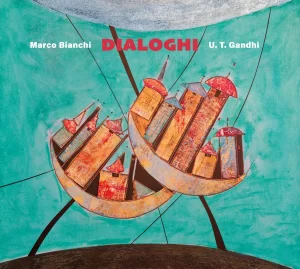Don Rendell / Ian Carr Quintet con «Change Is»: una svolta meditata nel cuore del jazz britannico (Columbia, 1969)

«Change Is» rappresenta un momento di svolta, ma anche una sintesi della poetica del Quintetto. La sua vitalità risiede nella capacità di coniugare esplorazione e disciplina, apertura e rigore, intuizione e consapevolezza.
// di Francesco Cataldo Verrina //
«Change Is», registrato nel 1969 e nuovamente accessibile grazie al lavoro di recupero discografico degli ultimi anni, rappresenta l’ultimo capitolo del Quintetto guidato da Don Rendell e Ian Carr prima della biforcazione dei rispettivi percorsi: Carr diretto verso l’avventura elettrica dei Nucleus, Rendell impegnato nella definizione del suo quartetto senza pianoforte, meno celebrato ma non meno fertile. L’album si colloca dunque in un momento di transizione, ma non per questo risulta frammentario; al contrario, rivela una sorprendente compattezza interna, come se il gruppo avesse voluto condensare in un’unica seduta l’intero patrimonio di invenzione accumulato negli anni precedenti.
Il carattere del disco si fonda su un equilibrio raro tra disciplina strutturale e slancio immaginativo. Le composizioni, firmate dai vari membri dell’ensemble, delineano un territorio in cui il post-hard bop britannico si apre verso nuove possibilità, senza rinnegare la propria matrice acustica. La scrittura si articola con una lucidità che non soffoca l’improvvisazione, ma la orienta entro un disegno coerente, sostenuto da un interplay che testimonia una lunga consuetudine di lavoro collettivo. «Elastic Dream», pagina inaugurale, funge da manifesto programmatico: una perlustrazione nelle viscere dal jazz estremo. Il tema sinuoso, quasi serpentino,, si dispiega su un organico ampliato che comprende due contrabbassi e le percussioni di Guy Warren, generando un ambiente sonoro stratificato, ricco di sfumature e di incastri ritmici. La sezione improvvisata, lasciata a una libertà controllata, crea un ponte naturale verso il brano successivo, anticipando alcune delle soluzioni che Carr elaborerà nei primi lavori dei Nucleus. L’assenza della chitarra – elemento cardine della futura formazione elettrica – non indebolisce la struttura, che anzi si regge su una sorta di orchestrazione cameristica, dove ogni voce contribuisce a un equilibrio interno attentamente calibrato. Con «One Green Eye» il disco assume una fisionomia più diretta, grazie alla scrittura di Mike Pyne e alla presenza dello stesso al pianoforte. Qui si materializza l’ingresso di Stan Robinson, la cui voce tenorile si affianca a quella di Rendell con una naturalezza sorprendente. Il suo intervento solistico, energico e lucidissimo, conferisce all’ordito tematico un carattere quasi celebrativo, come se la compagine volesse ribadire la propria vitalità proprio nel momento in cui si avvicinava alla dissoluzione.
«Boy, Dog And Carrot» diffonde un colore inatteso grazie all’uso del clavicembalo da parte di Michael Garrick, che trasforma l’episodio in un piccolo cantiere timbrico. La leggerezza del tema si intreccia con un accompagnamento che alterna pulsazioni regolari e improvvise aperture armoniche, mentre Rendell e Carr modellano le loro linee con un controllo del fraseggio che porta in auge una profonda consapevolezza strutturale. Con «Cold Mountain» l’habitat muta radicalmente. Garrick attinge a scale di derivazione raga, delineando un impianto modale che si dispiega con lentezza meditativa prima di sfociare in una sorta di danza vorticosa. Rendell impiega il soprano con un’intensità quasi rituale, mentre Carr, al flicorno, scolpisce frasi che sembrano emergere da un paesaggio abissale. Il contrabbasso di Dave Green, autorevole e incisivo, conferisce al costrutto sonoro una profondità ulteriore, come se la struttura stessa respirasse attraverso il suo sostegno. «Black Hair», anch’esso di Garrick, prosegue la perlustrazione modale, ma con un carattere più raccolto. Rendell passa al flauto, aggiungendo alla pagina una trasparenza quasi pastorale, mentre Carr torna alla tromba, alternando slanci lirici e accenti più marcati. La scrittura, pur essenziale, determina una cura minuziosa nella disposizione delle voci, come se ogni gesto fosse pensato per mantenere un equilibrio tra tensione e quiete. Il percorso trova il suo compimento in «Mirage», firmato da Rendell. Il componimento si dispiega con una procedura che richiama la sospensione contemplativa del Miles Davis di «Kind of Blue», ma senza alcuna imitazione. Carr, nuovamente al flicorno, elargisce uno dei suoi assoli più intensi, mentre Rendell delinea un intervento di rara eleganza, versato nel coniugare rigore e spontaneità. L’intero Quintetto sembra muoversi come un organismo unico, consapevole di trovarsi al termine di un ciclo e deciso a concluderlo con una dichiarazione artistica di notevole maturità.
La coesione dell’album non deriva da un’omogeneità di materiali, ma da una visione condivisa del fare musica: un approccio collettivo che privilegia l’ascolto reciproco, la cura delle transizioni, la ricerca di un’identità sonora che, pur radicata nella tradizione afroamericana, possiede una qualità inconfondibilmente britannica. Non si tratta di richiami folklorici o di citazioni esplicite, ma di un modo di plasmare il suono, di articolare le dinamiche, di concepire la forma, quale processo in evoluzione, più che come struttura rigida. «Change Is» rappresenta dunque un momento di svolta, ma anche una sintesi della poetica del Quintetto. La sua vitalità risiede nella capacità di coniugare esplorazione e disciplina, apertura e rigore, intuizione e consapevolezza. Riascoltarlo oggi significa ritrovare un capitolo essenziale del jazz europeo, un crocevia di idee che continua a parlare con sorprendente attualità.