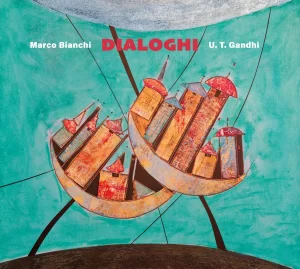«Lush Life» di Lou Donaldson: un ambizioso progetto orchestrale (Blue Note, 1967/1980)

L’album si conforma come un ciclo coerente, in cui le ballad non si susseguono per semplice contiguità, ma si richiamano l’una con l’altra mediante un disegno armonico che privilegia la continuità del respiro e la trasparenza delle sovrapposizioni.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Con «Lush Life» del 1967 Lou Donaldson concepì un progetto che, all’interno della sua produzione, assume il valore di un gesto deliberatamente laterale: un’incursione meditata nel territorio delle ballad orchestrate con cura quasi cameristica, lontana dalle consuetudini soul-jazz che avevano reso il suo nome immediatamente riconoscibile. La pubblicazione tardiva del 1980 non attenua la portata dell’operazione, anzi ne accentua la singolarità, poiché restituisce un Donaldson immerso in un clima sonoro costruito con disciplina formale e con un’attenzione al dettaglio timbrico che raramente aveva trovato spazio nei suoi lavori coevi.
La presenza di Duke Pearson come responsabile degli arrangiamenti orienta l’intero impianto compositivo verso una geometria orchestrale nitida, dove la sezione dei fiati – sei voci distribuite lungo un arco che va dal flauto al baritono – modella un tessuto armonico in filigrana. Pearson non sovraccarica, ma dosa con perizia le sovrapposizioni, lasciando emergere colori acustici che si insinuano nelle pieghe delle melodie senza mai soffocarle. L’organico, sostenuto da una ritmica di assoluto prestigio – McCoy Tyner, Ron Carter e Al Harewood – agisce come un oleato ingranaggio fatto di equilibri interni, in cui ogni intervento solistico s’interseziona con naturalezza nella trama orchestrale. Donaldson, al centro di questo dispositivo, affronta gli standard con una voce strumentale che conserva la sua consueta agilità inventiva, ma la piega verso un fraseggio più levigato, quasi contemplativo. La sua andatura melodica non indulge in sentimentalismi, piuttosto ricerca un controllo del respiro che gli consenta di scolpire le frasi con una chiarezza quasi canora: il profilo acustico espone una qualità vellutata, mentre affiora una cantabilità che rimanda alla tradizione più lirica del sax contralto, senza mai cadere in imitazioni o manierismi. La compattezza del programma – sette pagine musicali accomunate da un’identica lentezza di pulsazione e da un’identica intenzione espressiva – genera tuttavia una certa uniformità. Non si tratta di un limite strutturale, ma di una scelta estetica. Pearson e Donaldson elaborano un ambiente sonoro coerente, quasi un ciclo di meditazioni sul repertorio romantico americano, in cui la varietà non deriva dal cambio di atmosfera, ma dalle microvariazioni implicite al fraseggio, alle armonizzazioni e alle sfumature dinamiche. L’ascoltatore più attento riconosce come la ripetizione del movimento lento diventi un campo di esplorazione, non un vincolo.
Il nonetto, pur nella sua potenziale complessità, mantiene una trasparenza sorprendente. Freddie Hubbard, Wayne Shorter, Pepper Adams e Garnett Brown intervengono con brevi incisi che ampliano la prospettiva timbrica senza sottrarre centralità al contralto di Donaldson. La loro presenza non mira a un virtuosismo esibito, ma a un dialogo calibrato, quasi cameristico, che conferisce profondità al disegno armonico complessivo. La riedizione curata da Rudy Van Gelder restituisce una qualità sonora limpida, che valorizza la fisionomia del suono di ciascun interprete e permette di cogliere la finezza delle sovrapposizioni orchestrali. Non compaiono materiali aggiuntivi, ma la pulizia del restauro rende l’ascolto particolarmente rivelatore, soprattutto nelle sezioni più rarefatte. «Lush Life» non rappresenta un episodio marginale, ma un momento di consapevole espansione del linguaggio di Donaldson. Lontano dalle consuetudini del blues urbano e dalle pulsazioni dell’hard bop, il sassofonista dimostra una versatilità che non si limita alla padronanza tecnica, ma si manifesta nell’attitudine ad abitare un contesto estetico diverso, modellandolo con sensibilità e rigore. L’album si colloca così nel solco delle opere che, pur non cercando l’effetto, rivelano una maturità interpretativa profonda e una rara attenzione alla forma. Il punto di partenza risiede nella scelta di un linguaggio che, pur radicato nella tradizione del songbook americano, viene filtrato attraverso una sensibilità moderna, attenta alla mobilità interna delle voci e alla delicatezza delle transizioni. Pearson non forza mai le progressioni, piuttosto le modella con accordi di passaggio che smussano gli angoli delle cadenze e con dominanti secondarie che ampliano la percezione dello spazio tonale. La sezione fiati, distribuita su sei strumenti, non agisce come massa compatta, ma alla stregua di un organismo flessibile, capace di espandersi o contrarsi secondo le esigenze del fraseggio di Donaldson. Ne deriva un ambiente sonoro in cui ogni colore acustico s’inserisce con agilità nel flusso generale, senza creare fratture. Pearson concepisce l’impianto armonico di «Lush Life» come un unico arco espressivo, non come una successione di episodi isolati. La sua scrittura procede per metamorfosi interne, lasciando che ogni standard si trasformi nel successivo attraverso affinità di colore, di conduzione delle voci e di gestione delle tensioni. L’album si conforma come un ciclo coerente, in cui le ballad non si susseguono per semplice contiguità, ma si richiamano l’una con l’altra mediante un disegno armonico che privilegia la continuità del respiro e la trasparenza delle sovrapposizioni.
«Sweet Slumber» inaugura il percorso con un andamento armonico che alterna discese morbide e risalite cromatiche, quasi a predisporre l’orecchio a un ascolto privo di bruschi contrasti. La voce del contralto emerge da un fondale accordale ampio, dove le voci dei fiati si dispongono come piani sovrapposti, facendo germogliare una velatura che accompagna il tema senza appesantirlo. Quando si giunge a «You’ve Changed», la continuità non viene interrotta, bensì trasformata: le armonie si raccolgono, i voicings si fanno più compatti, e la malinconia del tema trova un corrispettivo nella scelta di intervalli più ravvicinati, che conferiscono un carattere quasi cameristico all’intero episodio. «The Good Life» dischiude una finestra luminosa, ma non spezza il filo: Pearson amplia i registri, lascia respirare le voci, introduce dominanti secondarie che dilatano la percezione tonale, mentre Donaldson ribatte con un fraseggio più disteso, come se la struttura stessa lo invitasse a un atteggiamento più aperto. La transizione verso «Star Dust» avviene senza soluzione di continuità, poiché la scrittura orchestrale mantiene la stessa cura nella distribuzione dei singoli asset. La delicatezza degli accumuli intervallari innesca un’aura fonica che avvolge il tema, mentre le modulazioni interne vengono trattate con una finezza che evita qualsiasi effetto di cesura. In «What Will I Tell My Heart» la coerenza del concept si fa ancora più evidente: Pearson alterna tensioni e distensioni con una precisione che non mira alla sorpresa, bensì alla continuità. Le cadenze non vengono mai esposte in modo diretto, ma filtrate attraverso accordi di passaggio che attestano il flusso in costante movimento. La ritmica sostiene senza invadere, lasciando che la linea del contralto si posi con spontaneità sulle armonie. «It Might As Well Be Spring» divampa con una mobilità più vivace, ma rimane all’interno dello stesso respiro: le progressioni ascendenti conferiscono un senso di apertura, mentre la distribuzione dei fiati crea una leggerezza che non contraddice il clima generale, ma lo rinnova dall’interno. Il ciclo trova compimento con «Sweet and Lovely», che raccoglie e sintetizza le scelte precedenti. Pearson costruisce un disegno armonico basato su i movimenti paralleli dei fiati, dispensando un’ambientazione avvolgente che non rinuncia alla chiarezza. Le modulazioni vengono trattate con una delicatezza che permette al contralto di emergere senza forzature, come se l’intero percorso trovasse qui la sua naturale conclusione. Donaldson, ormai pienamente immerso nel linguaggio dell’album, elabora una lettura che unisce eleganza e introspezione, confermando la sua abilità nel cavalcare un repertorio lirico con una maturità che trascende le etichette stilistiche.
L’unità dell’album non deriva dunque dalla ripetizione di un habitat emotivo, ma piuttosto dalla coerenza del disegno armonico e dalla continuità della procedura orchestrale. Pearson implementa un percorso che si dipana nel fluire delle progressioni, nella cura delle sovrapposizioni, nella gestione delle tensioni interne, mentre Donaldson vi s’inserisce con un modus agendi che, pur riconoscibile, si lascia trasformare dal contesto. «Lush Life» assume così le sembianze di un rituale meditativo, in cui ciascun passaggio contribuisce a un’unica traiettoria espressiva, senza mai perdere la propria identità.