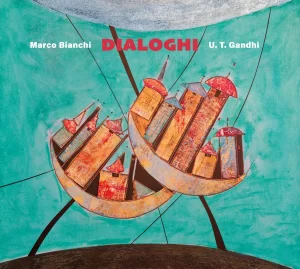«The Concert Jazz Band», l’orchestra secondo la visione di Gerry Mulligan (Verve Records, 1960)

«The Concert Jazz Band» si attesta quale testimonianza preziosa della visione orchestrale di Gerry Mulligan, basata sulla compliance fra tradizione e modernità, tra scrittura e libertà, che continua a mostrare la sua forza a distanza di decenni.
// di Francesco Cataldo Verrina //
«The Concert Jazz Band» del 1960 fu un progetto con cui Gerry Mulligan rilanciò l’idea di big band in un periodo in cui quel formato sembrava ormai consegnato alla storia. La decisione di adottare un organico privo di pianoforte, in continuità con le sue esperienze nei piccoli gruppi, indicava il desiderio di mantenere la libertà del combo unitamente a una scrittura orchestrale fondata su linee chiare, sovrapposizioni calibrate e un’attenzione costante al dialogo interno delle sezioni.
Il disco mostra sin da subito la compattezza dell’ensemble. Mulligan guida una formazione che agisce con naturalezza, dove gli strumenti non si riducono a sostenere la struttura, ma partecipano a un intreccio di voci che evita ogni pesantezza. L’assenza di uno strumento accordale apre spazi inusuali: ottoni e sassofoni si annodano con precisione, facendo germinare un tessuto sonoro mobile, ricco di incastri melodici e di contrappunti che mettono in luce una profonda consapevolezza del rapporto tra orchestrazione e improvvisazione. Il repertorio alterna pagine originali e riletture, divenendo un opificio di dinamiche interne che richiama la tradizione senza cadere nella citazione; che affronta le partiture con un tempo lentissimo, assumendo una postura quasi cameristica, come se Mulligan volesse trasformare la malinconia dei temi più lenti in un paesaggio sonoro rarefatto; che evita ogni sentimentalismo, puntando su una linearità melodica tesa a valorizzare la voce del baritono. Sul piano solistico emergono figure centrali della cerchia mulliganiana. Bob Brookmeyer dispensa interventi di estrema lucidità, con un valve trombone che pennella linee essenziali e mai ridondanti; Zoot Sims, in «Broadway», promulga un discorso incisivo, sorretto da una retroguardia ritmica che privilegia la chiarezza del gesto più che la spinta propulsiva. Mel Lewis e Buddy Clark mantengono un equilibrio impeccabile: la batteria vive in simbiosi con l’orchestra, il contrabbasso cammina sul morbido senza calcare la mano, contribuendo così alla trasparenza complessiva del suono. La prassi di Mulligan domina l’album senza soffocare l’ensemble: ogni arrangiamento lascia spazio a deviazioni improvvisative che non rompono la coerenza formale. La logica interna delle voci, la cura per le dinamiche e la capacità di far convivere leggerezza e rigore rendono questo lavoro un esempio raro di come la grande orchestra potesse rinnovarsi all’inizio degli anni Sessanta senza inseguire mode né rifugiarsi nel passato.
«Sweet and Slow» mette subito in circolo un’aria precisa: l’andamento non corre, ma scivola, come se l’orchestra stesse prendendo le misure della stanza. Gli ottoni stendono una stoffa morbida, priva di spigoli, mentre le ance ricamano linee sottili che non cercano mai di imporsi, ma insinuano una seconda lettura sotto la melodia. Il baritono di Mulligan non irrompe, piuttosto pesa le sillabe sonore, calibra le durate, si appoggia alla ritmica come a un pavimento elastico che restituisce ogni passo senza rimbombo. Il contrabbasso non spinge, ma sostiene, mentre la batteria non marca, ma suggerisce. Ne deriva un ambiente acustico in cui nessuna maestranza alza il tono, ma tutte, collegialmente, si prodigano nel definire il clima, come lampade disposte con cura in punti diversi della stessa stanza. Con «Bweebida Bobbida» la scena cambia inclinazione. Il tempo si fa più compatto, le sezioni si stringono, gli incastri tra trombe, tromboni e ance assumono la forma di una conversazione rapida, fatta di frasi brevi, quasi fendenti. Mulligan ragiona come un geometra del suono, distribuendo gli ingressi, alternando blocchi compatti a risposte più sinuose, , ma soprattutto lasciando che la ritmica tenga il filo senza irrigidirlo. Mel Lewis lavora sui micro-accenti, sposta il peso del tempo di mezza tacca, innescando una tensione interna che permette a Brookmeyer di puntellare un intervento lucidissimo, asciutto e privo di orpelli. Il baritono non si accontenta di svolgere il ruolo solistico, ma rivolta il tema, lo allunga, lo accorcia, lo osserva di sbieco, mentre l’orchestra reagisce come un organismo unico, che registra ogni variazione e la rimanda indietro in forma di risposta collettiva, mentre comunicazione interna,sebbene non dichiarata, circola alla stregua di una corrente sotterranea. «Manoir de Mes Rêves» rovescia la prospettiva. L’andamento rallenta fino quasi a fermarsi, come se qualcuno avesse deciso di osservare il materiale da distanza ravvicinata, nota per nota. Gli ottoni non suonano semplicemente, sagomandosi in blocchi morbidi, come nuvole che passano lente, mentre i sassofoni mantengono la malinconia di Django senza trasformarla in lamento. Mulligan, con il baritono, cammina in punta di piedi dentro questo paesaggio: poche note, scelte con cura, lasciate sospese quel tanto che basta perché il silenzio tra una e l’altra diventi parte integrante dell’intreccio motivico. Le armonie non vengono ammassate, ma distillate; un intervallo vale più di un accordo pieno, un’entrata di sezione pesa più di una cascata di suoni. L’ensemble funziona come una lente d’ingrandimento che allarga i dettagli, rallenta il tempo interno, costringendo l’ascoltatore a concentrarsi sulle sfumature.
Con «You Took Advantage Of Me» la luce cambia ancora. Il procedimento si fa più brillante, il passo della ritmica acquista una leggerezza quasi danzante, senza mai scadere nel gioco di maniera. Le sezioni si alternano con una precisione quasi da incisione orafa, dove gli ottoni lanciano frasi brevi, le ance rispondono con sequenze più morbide, il baritono accarezza il compost melodico, lo innerva, ma lascia intatta la riconoscibilità. la dimensione orchestrale delinea un tratto quasi cameristico, dove le armonie non vengono accatastate, ma diramate come colori su una tavolozza, con spazi vuoti lasciati apposta perché il suono possa circolare. La ritmica non è un motore, ma una cerniera elastica che tiene insieme le parti senza farsi notare. «Out Of This World» sposta il baricentro verso zone più scure. Il registro grave prende il sopravvento, in cui baritono e clarinetto basso scavano una base profonda, su cui gli ottoni avanzano in blocchi compatti, quasi masse sonore che si frantumano lentamente nell’ambiente circostante. Le ance, invece, s’incaricano di incrinare questa compattezza con divergenze armoniche che allargano l’orizzonte del costrutto, come fenditure che lasciano filtrare luce laterale. L’andamento resta controllato, la ritmica si tiene un passo indietro, ma non per timidezza, piuttosto si tratta di una scelta di regia, che permette all’impalcatura accordale di emergere con chiarezza. L’orchestra somiglia a un edificio visto in sezione, fatto di piani sovrapposti, pesi distribuiti con attenzione e linee di forza che s’incrociano senza collidere. «My Funny Valentine» rifiuta qualsiasi tentazione di sentimentalismo. Mulligan non indulge, non allunga le frasi per compiacere, non gonfia le dinamiche, ma mantiene il disegno melodico in primo piano, lasciandolo rotolare con una sobrietà quasi spiazzante. L’orchestrazione appare trasparente, quasi ascetica, imperniata su gli interventi brevi delle sezioni, come annotazioni a margine, che ampliano il portato armonico senza schiacciarlo. Il passo è lento, ma non immobile; la ritmica accompagna con un battito controllato, mentre il baritono conserva una compostezza che rende questa lettura sorprendentemente attuale. Le armonie vengono cesellate con precisione millimetrica, avulse da ridondanze, soprattutto niente accumuli, ma solo ciò che serve perché l’asse principale del tema resti intellegibile. «Broadway» porta con sé una spinta diversa. Zoot Sims affonda davvero i denti nel materiale, tanto che il tenore non si placa rigirandosi sul tema, ma lo oltrepassa, lo sconvolge e lo incalza, con la complicità di una ritmica che marca i punti di snodo con intelligenza, senza mai cadere nel martellamento. Gli ottoni rispondono con strappi brevi, quasi fendenti, le ance s’innestano con sprazzi più morbidi, alimentando una trama serrata ma mai confusa. L’ensemble reagisce in tempo reale a ogni curva del solista, come se l’intera formazione fosse un unico organismo nervoso. Un accento della batteria, una spinta del contrabbasso e un rientro degli ottoni, mentre tutto concorre a dare la sensazione di una macchina collettiva perfettamente oliata, ma tutt’altro che automatica. «The Concert Jazz Band» si attesta quale testimonianza preziosa della visione orchestrale di Gerry Mulligan, basata sulla compliance fra tradizione e modernità, tra scrittura e libertà, che continua a mostrare la sua forza a distanza di decenni.