«Opera Viva» degli Alkord: contrappunto e coabitazione, nella la grammatica sonora di Capelli (Brutture Moderne, 2025)
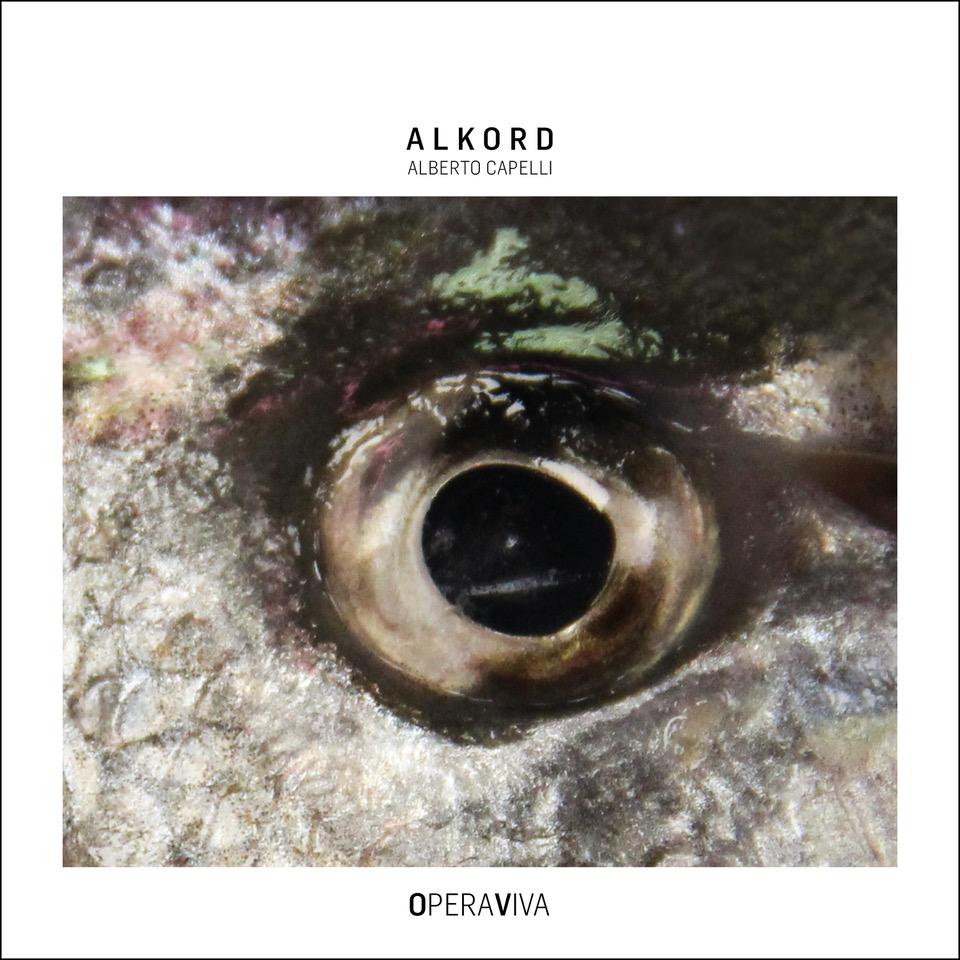
La scrittura di Capelli, tecnicamente raffinata ed interiormente articolata, fa vibrare ed affiorare suggestioni molteplici. Ogni tassello del mosaico promulga un costrutto concettuale coerente, ma sempre in bilico tra tensione e rilascio.
// di Francesco Cataldo Verrina //
La musica degli Alkord non si lascia definire per generi: jazz, flamenco, minimalismo, progressive rock e musica classica contemporanea non sono etichette, bensì tracce, indizi, frammenti che si sovrappongono secondo una logica di contrappunto. Il gruppo non fonde, ma piuttosto fa dialogare, fa emergere e fa risuonare linguaggi differenti, sulla scorta di una tessitura armonica a maglie larghe che si apre alla densità politematica.
Nel solco di una ricerca che non si accontenta della superficie, il ultimo album, «Opera Viva», si presenta come una pagina musicale che si posiziona tra vita e dissoluzione, tra forma e deriva, tra gesto sonoro e pensiero critico. L’ensemble guidato da Alberto Capelli, tessitore di trame acustiche e regista armonico di lungo corso, non propone un semplice lotto di brani, bensì un impianto compositivo che si sviluppa secondo una logica di stratificazione timbrica e tensione formale, dove ogni episodio riflette sulla fragilità del presente. La fisionomia sonora del gruppo, già delineata nei precedenti lavori («Nelle mie corde», «L’Attesa» e «Minimale»), individua in questa nuova struttura tematica una modulazione ulteriore, nella quale la vocazione acustica si espande, si complica e si fa porosa, accogliendo il colore elettrico della chitarra e la velatura acustica degli archi, in un ambiente armonicamente inquieto che non punta la fusione, ma piuttosto alla coabitazione. Il quintetto, affiancato dal corno inglese di Giulia Baruffaldi nella quarta traccia, dispone le voci secondo una geometria timbrica che non indulge mai nel decorativo, ma costruisce relazioni, tensioni ed aperture multistrato. La scrittura di Capelli, tecnicamente raffinata e interiormente articolata, fa vibrare ed affiorare suggestioni molteplici. Ogni tassello del mosaico promulga un’idea musicale coerente, ma sempre in bilico tra tensione e rilascio. Le composizioni firmate da Gabriele Rampi e Lyle Mays non interrompono il flusso, ma lo espandono, Il titolo stesso, «Opera Viva», suggerisce una riflessione che non si esaurisce nel gioco semantico: la linea di galleggiamento evocata da Capelli non costituisce una metafora generica, ma un discrimine acustico, una soglia timbrica ed un punto di rottura tra ciò che emerge e ciò che si dissolve. Il mare, in tale prospettiva, non va considerato quale paesaggio da attraversare, ma luogo da sondare. Registrato e masterizzato da Andrea Duna Scardovi, il disco si avvale anche dell’apporto visivo di Silvia Moscati, che integra e dilata la dimensione percettiva dell’opera. La scelta di un etichetta come Brutture Moderne non risulta casuale, ma caratterizza una produzione che rifiuta il banale compromesso del mainstream a presa rapida, cercando nella trasversalità la propria genesi espressiva.
Sin dall’opener «Bulletin Scolaire» si avverte subito una tensione in cerca di articolazione e cricolarità relazionale. La chitarra di Capelli assume il ruolo ad interim del suggeritore, imponendosi come voce interiore che cerca un varco. Il clima sonoro rimanda a certe pagine di Pascal Quignard, dove la musica diventa rivelatrice. L’interplay fra gli strumenti si risolve in una trama che si fa e si disfa, come nel cinema di Béla Tarr, in cui ogni gesto diviene sospensione e attesa. «Chorino», firmata da Lyle Mays, si attesta come deviazione, quasi un interludio che apre una finestra su un scenario diverso. Il colore acustico diviene più luminoso, ma non per questo meno articolato. La batteria di Rapicavoli disegna traiettorie ritmiche che sembrano richiamare talune geometrie visive di Tarkovskij, dove il tempo non scorre, ma si dilata; dal canto suo, il contrabbasso di Rampi sostiene senza gravare, come se il suono fosse sospeso in una camera d’eco. «Il Lago Buio» riesce a far affiorare suggestioni molteplici. La progressione armonica sguazza in equilibrio instabile, come se ogni accordo fosse una domanda. Il violoncello di Dal Paos plasma una velatura acustica che rimanda a certi situazioni descrittive di Ingeborg Bachmann, ne quali la parola si fa suono e il suono diviene ferita. La chitarra elettrica s’inabissa come una corrente sotterranea che modifica il clima senza alterarne la fisionomia. «Luci» srotola forse la sequenza più cinematografico dell’intero album, dove il corno inglese introduce una sfumatura che si trasforma in un’impronta. Il tema si dirama similmente ad una sequenza visiva, come se ogni frase musicale fosse un’inquadratura. Il line-up cerca continuamente la complicità, sebbene ogni strumento mantenga la propria identità, lasciandosi contaminare. Il risultato è una tessitura armonica che potrebbe evocare le atmosfere di «La doppia ora» di Giuseppe Capotondi, dove la luce non illumina, ma inganna. «Strass» si presenta alla stregua di un frammento, quale inciso che interrompe il flusso per aprire una fenditura. La scrittura di Capelli diventa più percussiva, più nervosa, come se il suono fosse scolpito con urgenza. Il violino graffia, il contrabbasso fissa il cammino, tanto che il clima rimanda a certe pagine di Thomas Bernhard, in cui la ripetizione non è ossessione, ma struttura.
«Unnecessary Song», firmata da Rampi, non risulta affatto superflua, attestandosi quale punto di snodo, in cui la forma si rimodella. La progressione armonica si dipana secondo una logica di dissolvenza, quasi che ogni suono fosse destinato a svanire. Il gruppo mira alla rarefazione e alla sospensione. Emerge così una pagina musicale che potrebbe dialogare con le atmosfere di «Synecdoche, New York» di Charlie Kaufman, dove ogni frammento diventa mondo, qualunque dettaglio descrive un universo. «Vanilla» non indulge nella dolcezza: il titolo appare fuorviante, ma il contenuto sorprende. La chitarra disegna una progressione che si diffonde alla medesima stregua di un racconto, il violoncello introduce una velatura inquietante, mentre il clima sonoro rimanda a certe pagine di Marguerite Duras, nelle quali il silenzio risulta più eloquente della parola. In «Your Turn» la compagine si sagoma come organismo vivente, mentre ogni strumento si colloca in un ordine relazionale che non cerca protagonismi. Il risultato è una struttura formale che si evolve secondo una logica di sottrazione, non dissimile al cinema di Chantal Akerman, dove il gesto minimo diventa rivelazione. «Wormhole» apre una fenditura, nella quale il suono si piega, si torce e si dissolve. La chitarra elettrica formula punti di confluenza, mentre dalla retroguardia, il contrabbasso si sposta come massa fluida e la batteria batte territori che sembrano protrarsi all’infinito, al punto che l’ambientazione riecheggia alcune pagine di Philip K. Dick, in cui la realtà è sempre altrove. «Ribelle Placato – preludio» chiude con una sorta di finale aperto. Il titolo suggerisce una tensione che non si risolve, una ribellione che non esplode. La scrittura diventa minimale, ma non povera, in cui ogni nota si sostanzia come una scelta e qualunque pausa si delinea come una costruzione, quasi come se il racconto non fosse finito, ma solo interrotto. Dedicato ai naufraghi senza volto, «Opera Viva» sancisce il valore un concept da sondare in profondità, in cui ogni nota formula una domanda, qualsiasi pausa un punto di svolta e qualunque progressione offre una possibilità di ripresa. Ed in questo gioco di ruolo che l’album, nella propria interezza, si riconosce nella vocazione dell’ensemble, ossia quella di pensare il suono come forma di resistenza.






