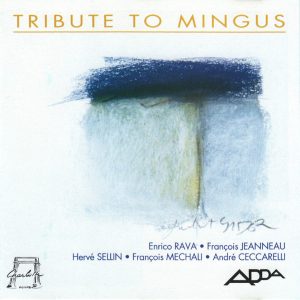Morto Eddie Palmieri: un ponte fra due emisferi sonori. Aveva 88 anni

Eddie Palmieri
La relazione che Eddie Palmieri ha intrattenuto con il jazz nordamericano del secondo dopoguerra si distingue per complessità, ricchezza dialettica e reciproca influenza, mai riducibile ad una semplice osmosi tra latinidad e mainstream afro-americano. Palmieri non si è limitato ad assorbire le innovazioni formali del jazz moderno – il bebop, il cool, il modalismo e il post-bop – ma ha saputo riarticolarle all’interno di un lessico percussivo ed armonico in cui la matrice afro-caraibica non rappresenta un colore locale, bensì un principio strutturante.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Figura eccentrica e al contempo rigorosa, Eddie Palmieri ha incarnato una visione musicale in cui la matrice afro-caraibica non viene mai relegata a folklore pittoresco o esotismo da esportazione, bensì innalzata a linguaggio composito, fertile, stratificato, in perpetuo dialogo con il jazz d’avanguardia, la musica colta afro-americana, il sincretismo ritmico e timbrico della diaspora. Nato nel 1936 nel Bronx da genitori portoricani, Palmieri non si è limitato ad assimilare le coordinate del Salsa o del latin jazz, ma le ha scardinate, infuse di tensioni armoniche impreviste, attraversate da politonalità debitrice tanto a McCoy Tyner quanto a Thelonious Monk, imbevute di una ritmica tellurica capace di fondere le metriche yoruba, la clave e il battito irregolare del post-bop.
La sua parabola creativa non si presta a una tassonomia lineare. La fondazione della band La Perfecta nel 1961 segna un punto di rottura non solo per la scelta di sostituire la sezione di trombe con due tromboni, ottenendo un impasto sonoro più scabro e grave, ma anche per la decisione di articolare un discorso pianistico che rifiuta la funzione ancillare dell’accompagnamento, restituendo allo strumento una centralità timbrica e concettuale. L’album «Azúcar pa’ ti» (1965), con l’infuocata estensione improvvisativa di «Azucar», annuncia già una poetica dello scarto e della dismisura, in cui la reiterazione ossessiva di cellule ritmiche si tramuta in trance collettiva, in fervore quasi liturgico, senza mai cedere alla prevedibilità della formula. Palmieri ha costantemente rifiutato la compartimentazione dei generi, concependo la musica come campo di forze in perenne oscillazione. Nel capolavoro «Harlem River Drive» (1971), registrato con una formazione che include jazzisti afro-americani e percussioni latine, il suo linguaggio si dilata fino a includere la poetica del funk più militante, l’istanza politica della Black Power Era, la lezione modale di Davis e la febbrile densità orchestrale di Sun Ra. Il pianoforte, strumento percussivo per eccellenza nella sua estetica, diventa tramite di una visione quasi demiurgica, capace di tenere insieme l’urgenza espressiva e l’astrazione formale. La componente rituale, il richiamo a un universo spirituale radicato tanto nella santería quanto nel misticismo sincretico delle culture caraibiche, attraversa l’intera produzione di Palmieri. Non vi è gesto musicale che non si carichi di un’intenzionalità sacrale, che non rimandi ad un orizzonte comunitario, mai individualistico o autoreferenziale. Il suo approccio alla composizione e all’arrangiamento, nutrito anche da una costante riflessione teorica (frequente fu il riferimento esplicito a Olivier Messiaen e ai suoi studi sul ritmo), travalica il semplice mestiere artigianale, per configurarsi come prassi alchemica, incessante sperimentazione timbrica, estensione delle possibilità metriche e tonali del Salsa ben oltre le sue codificazioni commerciali. Negli anni successivi, egli ha saputo attraversare le mutazioni del linguaggio afro-latino senza mai cadere nel manierismo o nell’autocitazione. Il suo sodalizio con musicisti come Brian Lynch, Donald Harrison o Giovanni Hidalgo testimonia una perenne apertura al divenire, all’innesto, alla metamorfosi, con un’attitudine che potremmo definire diasporica non solo sul piano culturale, ma anche su quello musicale. Ogni sua registrazione postula un altrove sonoro che, pur germinando da radici profonde, non conosce confini.
La relazione che Eddie Palmieri ha intrattenuto con il jazz nordamericano del secondo dopoguerra si distingue per complessità, ricchezza dialettica e reciproca influenza, mai riducibile ad una semplice osmosi tra latinidad e mainstream afro-americano. Palmieri non si è limitato ad assorbire le innovazioni formali del jazz moderno – il bebop, il cool, il modalismo e il post-bop – ma ha saputo riarticolarle all’interno di un lessico percussivo ed armonico in cui la matrice afro-caraibica non rappresenta un colore locale, bensì un principio strutturante. L’attenzione di Palmieri per il jazz statunitense appare già evidente sin dai primi anni Sessanta, ma non si configura come sudditanza imitativa, piuttosto, si tratta di una tensione costante verso l’elaborazione di una grammatica ibrida, in cui il concetto stesso di improvvisazione, così centrale nella poetica afro-americana, viene riletto attraverso la ciclicità ritmica della clave e delle tradizioni yoruba e congolese. Si può ravvisare proprio nel cortocircuito tra queste due temporalità – quella spiraliforme delle musiche afro-diasporiche caraibiche e quella più lineare del jazz statunitense – il gesto radicale di Palmieri, ossia un ripensamento della forma, un sabotaggio costruttivo del concetto di chorus ed una reinvenzione del dialogo strumentale. Non de ve sorprendere se, in tale contesto, Palmieri abbia guardato con particolare interesse ai pianisti più innovativi della scuola be-bop e post-bop, in primis Thelonious Monk, McCoy Tyner ed Herbie Hancock. Dall’uno ha derivato l’uso idiosincratico dello spazio, l’irregolarità delle accentazioni, il gusto per l’anomalia intervallare; dall’altro la verticalità degli accordi quartali, l’espansione modale, la dimensione quasi orchestrale della tastiera. Tuttavia, il suo modo di incorporare tali elementi rimane eminentemente circoscritto, tanto che il pianoforte di Palmieri non diventa mai mero doppione del linguaggio jazzistico, ma conserva una corporeità ritmica, una forza percussiva ed una collocazione rituale del tutto estranee alla liturgia del jazz da club o da concerto. Particolarmente significativa fu la sua collaborazione con musicisti afro-americani a partire dagli anni Settanta, quando Palmieri si fa promotore di un dialogo tra avanguardia nera e tradizione caraibica. «Harlem River Drive» (1971), opera seminale concepita – come accennato – quale veicolo politico-musicale, coinvolge figure provenienti tanto dal soul jazz quanto dal funk e dalla Black Power music. In tale contesto, il jazz non è più solo un referente estetico, ma un campo ideologico, una forma di lotta. Palmieri intuisce che il linguaggio jazzistico può diventare cassa di risonanza per un discorso afro-latino militante, capace di trascendere le categorizzazioni commerciali imposte dall’industria discografica. Va inoltre sottolineato che, nella fase più matura della sua carriera, Palmieri ha collaborato stabilmente con jazzisti di levatura internazionale come Joe Lovano senza mai snaturare la centralità del tumbao, del montuno, dell’interazione percussiva. La sua concezione orchestrale, sempre attenta all’equilibrio tra improvvisazione individuale e costruzione collettiva, gli ha permesso di elaborare strutture formali complesse, articolate secondo logiche più vicine alla suite jazzistica che alla canzone tropicale. La sua relazione con il jazz nordamericano post-bellico, dunque, non si limita a una frequentazione linguistica o stilistica, ma sancisce un contributo teorico, come ridefinizione delle gerarchie tra centro e periferia. Palmieri non ha mai voluto «fondere» il jazz con il latin, ma piuttosto ridefinire l’intero spazio delle musiche afro-americane a partire da un paradigma polimorfico, diasporico e plurivocale. Secondo tale schema, la sua opera rappresenta un atto di critica musicale incarnata, capace di mettere in discussione non solo i generi, ma le narrazioni stesse attraverso cui il jazz è stato storicamente costruito.
Anche le incursioni di Eddie Palmieri nell’ambito della musica pop nordamericana non rappresentano deviazioni opportunistiche rispetto alla sua rigorosa traiettoria musicale, bensì episodi di trasfigurazione linguistica in cui l’incontro con forme apparentemente estranee si trasforma in detonatore creativo. Lungi dal conformarsi alle logiche omologanti dell’industria, Palmieri ha saputo attraversare i territori del pop con spirito trasgressivo, preservando la propria cifra estetica anche quando il contesto sembrava imporre un registro più anodino. Fra le collaborazioni più emblematiche, si segnala quella con Santana, figura altrettanto eccentrica e borderline, con cui Palmieri condivide l’inclinazione per una spiritualità musicale sincretica, la fascinazione per l’improvvisazione come trance, nonché l’interesse per le matrici afro-latine come fondamento comune. La loro convergenza non è mai un semplice innesto decorativo, ma piuttosto un’esaltazione reciproca di energie ritmiche e visioni sonore. L’incontro tra la chitarra elettrica psichedelica di Santana e l’architettura pianistica tellurica di Palmieri genera un’ibridazione che sfugge alle tassonomie, in cui la linearità pop si frantuma in riverberi poliritmici e frasi modali. Non meno significativa è la partecipazione di Palmieri a progetti incrociati con cantautori e interpreti dell’universo soul e R&B, come nel caso di La Lupe, diva iconoclasta il cui pathos drammatico trova nel pianismo febbrile e teatrale di Palmieri un contraltare ideale. I loro dischi congiunti, ben lontani dal facile sentimentalismo radiofonico, restituiscono un affresco sonoro carico di tensione, in cui il grido della voce trova nella percussività martellante del piano una cassa di risonanza emotiva di rara efficacia. L’operazione condotta con La Lupe non appartiene alla sfera del «duetto» popolare in senso canonico, bensì si avvicina piuttosto a una forma di teatro musicale ritualizzato, dove ogni episodio vocale è inscrivibile in un campo di forze drammaturgiche. Va menzionato anche il rapporto, talora più sotterraneo ma influente, con figure di spicco del pop latino contemporaneo. Diversi artisti attivi tra gli anni Novanta e Duemila, da Marc Anthony a Gloria Estefan, hanno attinto, in forma diretta o indiretta, al patrimonio armonico e ritmico palmieriano, traendo ispirazione dalla sua concezione orchestrale e dalla sua capacità di costruire climax emotivi attraverso la tensione timbrica e la reiterazione ciclica. Seppur non sempre formalizzate in collaborazioni ufficiali, tali influenze testimoniano l’impronta profonda lasciata da Palmieri anche su una generazione cresciuta all’interno di circuiti commerciali più canonici. L’aspetto più rilevante di queste interazioni risiede tuttavia nella capacità di Palmieri di rimanere sempre se stesso anche nel contesto pop: il suo stile, lungi dall’annacquarsi, s’impone come forza centrifuga, capace di decostruire la forma canzone, di sovvertire l’armonia prevedibile, di far emergere la componente rituale latente persino nei prodotti più radiofonici. Non si tratta dunque di semplici «collaborazioni» nel senso industriale del termine, ma di episodi di contaminazione critica, di deviazioni consapevoli, di infiltrazioni creative all’interno del pop mediale, attraverso cui Palmieri ha potuto disseminare il proprio codice sonoro anche oltre i confini della sua nicchia stilistica. La sua presenza nella musica pop non è tanto visibile come marketing quanto udibile come resistenza, quasi una sorta di «contropunto diasporico» che, silenziosamente ma inesorabilmente, ha inciso sulle strutture percettive di un vasto pubblico, espandendo la nozione stessa di latinidad oltre i cliché della commerciabilità.
Nella vastissima produzione discografica di Eddie Palmieri, alcuni album si impongono non come semplici pietre miliari del Salsa o del latin jazz, bensì come veri e propri dispositivi sonori che interrogano la forma musicale, l’identità multietnica e la politicità del ritmo. Cinque di questi lavori si distinguono per ricchezza concettuale, audacia sperimentale e coerenza visionaria, componendo una traiettoria che va ben oltre la documentazione di una carriera, per configurarsi piuttosto come corpus estetico coerente e sfaccettato. «Azúcar pa’ ti» (1965) costituisce un punto di svolta non solo per Palmieri, ma per l’intera storia della musica afro-caribica del secondo Novecento. L’omonima traccia di apertura, con i suoi oltre otto minuti di durata, infrange le convenzioni del formato radiofonico, imponendo una struttura ipnotica basata su estese sezioni strumentali, improvvisazioni oblique e uno sviluppo timbrico che restituisce alla salsa una dimensione labirintica e tellurica. In quest’opera, il pianoforte di Palmieri cessa definitivamente di essere mero accompagnamento ritmico per assumere il ruolo di agente propulsivo, carico di tensione armonica e pulsione percussiva. L’interazione tra i tromboni di Barry Rogers e José Rodrigues conferisce all’insieme una cupezza e una verticalità che anticipano l’estetica urbana del Salsa «duro» degli anni Settanta. È un album che trasforma il ballo in trance, la pista in rito collettivo. «Harlem River Drive» (1971) rappresenta forse la più esplicita incursione di Palmieri nel territorio della musica come dichiarazione politica. Registrato con una formazione mista di musicisti latini e afro-americani, l’album si pone come manifesto sonoro della solidarietà tra i due versanti della diaspora nera, costruendo un ponte tra il funk militante della Black Power Era e le architetture modali della tradizione afrocubana. Le tracce, dense di groove sincopati, sezioni vocali corali e articolazioni ritmiche complesse, si sviluppano secondo una logica di accumulo e scarto, che annulla ogni distinzione tra danza e dissidenza. Il pianoforte agisce come detonatore armonico, sempre in bilico tra lo spirituale e l’agonistico. Più che un disco, si tratta di un’operazione culturale che ambisce a rifondare le coordinate della musica afroamericana a partire da un paradigma insurrezionale. «The Sun Of Latin Music» (1974), vincitore del primo Grammy Award mai assegnato nella categoria Latin, si presenta come un’opera di sintesi e insieme di superamento. La scrittura si fa più raffinata, quasi cameristica in certi momenti, ma senza rinunciare all’energia bruta che caratterizza la produzione precedente. La presenza di Lalo Rodríguez alla voce introduce una dimensione melodica più fluida, ma mai sentimentale, mentre le linee vocali s’intrecciano con le architetture strumentali in una polifonia caleidoscopica, dove ogni elemento – timbro, ritmo ed armonia – concorre alla costruzione di un discorso sonoro unitario. Le composizioni si dipanano come organismi viventi, in cui le sezioni si generano l’una dall’altra per proliferazione interna, secondo una logica quasi organica. Siamo alle prese con l’album in cui Palmieri, pur restando fedele al proprio lessico afro-caraibico, sfiora la forma sinfonica.
«Lucumi, Macumba, Voodoo» (1978) rappresenta la vertigine esoterica dell’intera poetica palmieriana, nonché la sua declinazione mistica e visionaria. In questo lavoro, i riferimenti alle tradizioni religiose della diaspora africana non vengono trattati come elementi folclorici o decorativi, bensì come strutture epistemiche e cosmologiche che informano il processo compositivo stesso. Le percussioni batá, le invocazioni rituali, le dissonanze quasi sacre e le forme iterative evocano una dimensione liturgica, in cui la musica diventa atto sacrale, trasmissione energetica e conoscenza incorporata. La trama sonora, fitta e labirintica, sembra generarsi da un altrove temporale, in cui la distinzione tra improvvisazione e composizione, tra memoria e trance, viene sospesa. È l’album in cui Palmieri si fa sciamano e medium sonoro di forze ancestrali. «Listen Here!» (2005), infine, documenta la fase più tarda ma non meno ardente della sua produzione. Circondato da un cast stellare che include Nicholas Payton, Michael Brecker, Regina Carter e John Scofield, Palmieri dimostra di non aver perso né lo slancio innovativo né la capacità di dialogare con i linguaggi più aggiornati del jazz contemporaneo. L’album si muove agilmente tra standard rivisitati, composizioni originali ed ibridazioni sofisticate, ma ciò che colpisce è la capacità del leader di orchestrare il tutto senza mai appiattire l’identità latina a semplice marchio stilistico. Ogni traccia viene trattata come un laboratorio timbrico, in cui convivono improvvisazione e struttura, virtuosismo individuale e dinamica collettiva. Il risultato rappresenta una testimonianza della longevità creativa di Palmieri, che s’impone come figura di riferimento non solo per la musica latina, ma per il jazz globale. In questi cinque album, distanti cronologicamente ma uniti da una coerenza interna che travalica le mode e le contingenze, si delinea con estrema chiarezza l’itinerario di un artista che ha saputo costruire un linguaggio inconfondibile, capace di attraversare i generi senza dissolversi in essi, e di modulare una visione del mondo, in cui il suono non è mai neutro, ma sempre gesto critico, segno incarnato e memoria attiva.
La sua scomparsa a 88 anni priva il mondo musicale non solo di un virtuoso del pianoforte e di un compositore innovativo, ma soprattutto di un pensatore musicale la cui opera esige di essere letta come una forma di epistemologia incarnata, una riflessione sul ritmo, sull’identità e sull’altrove, sviluppata non attraverso la parola scritta, ma attraverso l’azione sonora, il gesto percussivo, la vibrazione collettiva. Nessuna commemorazione potrà restituire compiutamente il peso di una simile eredità, che continuerà ad abitare i solchi, le poliritmie ed i silenzi significativi di un catalogo discografico tra i più visionari del XX secolo.