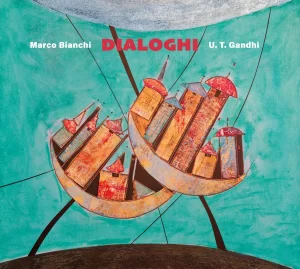Solcando i luoghi della memoria: Pat Metheny all’Anfiteatro Quercia del Tasso di Roma (1980/81, ECM)

La mia memoria, ovviamente, non può ricordare a distanza di quarantacinque anni i dettagli della serata, che ricordo magica come la cornice naturale dove si svolse. Per rinverdire la musica di quel concerto vado a prendere il disco che comprai nel 1980 e lo metto sul piatto.
// di Marcello Marinelli //
Generalmente si fa riferimento ai luoghi della memoria in relazione ai fatti tragici di questa tribolata umanità. In questo caso, però, i luoghi della memoria sono i luoghi della mia memoria musicale e mi scrollo di dosso, almeno per la durata di questo scritto, la brutta memoria storica che tanto ci ha fatto soffrire e che ci fa soffrire ancora. Quartiere Monteverde di Roma, teatro Vascello. Dopo aver ritirato i biglietti dello spettacolo di quel geniale performer teatrale che corrisponde al nome di Antonio Rezza, decido di farmi un giretto in una delle più belle zone di Roma. Raggiungo a piedi il Gianicolo, colle di Roma che non fa parte dei famosi sette colli della capitale perché sorge fuori dalle mura antiche. È uno dei luoghi più panoramici della città insieme al Pincio e a Monte Mario. Decido di scendere alle pendici del colle verso il quartiere Trastevere seguendo la passeggiata del Gianicolo. Improvvisamente una reminiscenza del tempo che fu: l’Anfiteatro della Quercia del Tasso poco distante, l’indimenticabile festival jazz di fine anni ’70/inizi anni ’80. Il pensiero va al concerto di Pat Metheny del settembre del 1981.
L’anfiteatro Quercia del Tasso è una cavea naturale costruita dai religiosi dell’oratorio San Filippo Neri nel XVII secolo utilizzando la pendenza naturale del luogo, e di fronte si apre il panorama mozzafiato sulla città eterna. Il nome Tasso è in onore al poeta Torquato Tasso che tanto amava quel posto insieme a una miriade di altri cittadini illustri. In passato campeggiava una quercia che dominava il posto, ora ne rimangono solo dei poveri resti recintati. Il posto mi sembra molto più piccolo di quanto mi ricordavo, ma andando a spulciare tra gli archivi pare che la capienza sia di 400 posti. Il luogo è un po’ lasciato andare ed è un peccato, ma è ancora attivo per gli spettacoli teatrali, evidentemente lo rimettono in sesto per l’estate. La mente ritorna a quella magica serata del settembre del 1981, e pensare che il luogo fu un ripiego di quello originariamente scelto dal Murales e dal Music In che all’epoca organizzavano il Roma Jazz Festival, ovvero le Terme di Caracalla. Il super gruppo era formato da Pat Metheny alle chitarre, da Dewey Redman e Mike Brecker al sax tenore, Charlie Haden al contrabbasso e Jack DeJohnette alla batteria. Ora la mia memoria, ovviamente, non può ricordare a distanza di quarantacinque anni i dettagli della serata, che ricordo magica come la cornice naturale dove si svolse. Per rinverdire la musica di quel concerto vado a prendere il disco che comprai nel 1980 e lo metto sul piatto. Visto il tanto tempo che è passato da allora, non posso che constatare amaramente che l’unico sopravvissuto di quel super gruppo è il chitarrista che all’epoca era il più giovane. Dewey Redman è morto nel 2006, Mike Brecker nel 2007, morto troppo giovane, Charlie Haden nel 2014, Jack DeJohnette nell’ottobre del 2025. Non è una lugubre lista di lutti, ma solo il normale destino di ogni mortale, e visto che li sto ascoltando in questo momento, il pensiero che mi viene in mente è che gli uomini passano ma la musica rimane e li rende immortali, o se preferite, l’immortalità della musica. Cari amici musicisti, che possiate riposare in pace, I love you.
Ora, visto il momento di commozione nel ricordo di questi straordinari artisti, non posso che iniziare il mio racconto del disco dalla composizione del chitarrista che compare sulla quarta facciata del doppio album: «Every Day (I Thank You)». Forse fu dedicata a Mike Brecker, un musicista che Metheny ammirava moltissimo. Una ballad che inizia lentamente per poi aumentare di ritmo, per me un capolavoro del jazz moderno. Avrò esagerato? Può darsi! Il suono di Mike Brecker appare cristallino come l’acqua di un torrente di montagna e la commozione riaffiora. Segue l’assolo del chitarrista con il suo tocco vellutato e intimistico e di seguito il solo del sassofonista, ispirato e intenso, e poi di nuovo la chitarra del leader in solitaria (sento nitidamente i polpastrelli che sfregano la tastiera della chitarra). Poi finisce da dove era cominciato, il tema struggente e malinconico, e questo pezzo termina dopo tredici minuti abbondanti di musica. Con una vena nostalgica, in «Every Day (I Thank You)» faccio mio il ringraziamento di gratitudine alla musica tutta, a tutti i musicisti di questo disco e non solo. Da qui all’eternità: «Ogni giorno (ti ringrazio)».
Il disco uno si apre con «Two Folk Songs (1st and 2nd)». Pat Metheny è un chitarrista poliedrico e le sue fonti di ispirazione sono molteplici; una di queste è la musica country. Proveniente dallo stato del Missouri, le sue radici «midwest» riecheggiano. Per alcuni appassionati di jazz queste influenze diverse dalle radici più propriamente afroamericane sono viste come un limite e il suo stile è considerato un ibrido troppo sbilanciato verso la fusion e, per gli appassionati e per i critici intransigenti, Pat Metheny rimane un alieno. Io non la penso così e penso che questo musicista abbia scritto una pagina importante della musica jazz moderna. Le «Due Folk Songs» sono a ritmo sostenuto e Brecker impazza su questi ritmi per lui inusuali; il suo sax tenore ‘ulula’ e a proposito di questa parola mi viene in mente la famosa battuta di Martin Feldman in «Frankenstein Junior», ossia «Il lupo ululà, il castello ululì», qui però c’è l’accento sulla «a». Queste due ballate folk non si possono suonare intorno a un falò perché il pezzo è energico, sostenuto e intrinsecamente jazz, sebbene non abbia la scansione usuale del jazz. L’assolo di Jack DeJohnette è mirabile e un omaggio spaziale a questo monumentale batterista che sapeva come muoversi nei più disparati contesti. Poi è il turno dell’assolo di Charlie Haden, e per lui invece questi erano anche i suoi contesti e ci azzecca come il cacio sui maccheroni essendo lui dello Iowa, altro paese del Midwest. Il pezzo finisce e finisce anche l’atmosfera country evocata.
Incredibile ma vero, nella facciata B del primo disco e nella facciata A del secondo si fa un’inversione a «U» e si celebra un musicista che col country c’entrava come i cavoli a merenda, ovvero il padre putativo del free-jazz, Ornette Coleman. ‘80/81’ rende l’omaggio evidente, entra in scena Dewey Redman, antico collaboratore di Ornette Coleman al pari di Charlie Haden, e l’atmosfera è quella tipica dei gruppi di Ornette Coleman. Il tema, eseguito all’unisono tra il sax e la chitarra, è meraviglioso al pari degli assoli. Come si fa a non amare questo pezzo jazz con un Groove pazzesco? Critici sulla musica di Pat Metheny, possiamo concordare su questo pezzo jazz al 100%? Almeno su questo pezzo. Se non considerate jazz questo brano, e soprattutto se non lo considerate bello, dal basso della mia insignificanza vi scomunico sine die, e se rilanciate, come diceva il mitico Mario Magnotta, «Mi iscrivo ai terroristi». Vabbè non vi scomunicherò, né mi iscriverò ai terroristi, perché la libertà è sacra. A questo proposito ho letto una recensione di Filippo Bianchi del concerto alla Quercia del Tasso; scrisse citandolo testualmente che «la musica di Pat Metheny era frigida». Per quanto mi riguarda, io con la musica di Pat Metheny abbiamo avuto orgasmi plurimi e continuativi, ma questo è il mistero dell’individualità e degli orgasmi. In questo pezzo si esalta il sassofonista e Pat Metheny fa rivivere la grande tradizione della chitarra jazz, da Wes Montgomery a Jim Hall su tutti, e Dewey Redman si esalta nei suoi territori abituali. Con «Turnaround» l’omaggio a Ornette Coleman è diretto, essendo questo blues atipico un suo famoso pezzo. Non poteva mancare un assolo di Charlie Haden su un brano di Coleman. In «Open», improvvisazione collettiva, il brano è firmato da tutti i musicisti; il brano di abbondanti quattordici minuti è il più lungo del disco. In questo episodio, in «Pretty Scattered» e in «The Bat» suonano insieme Mike Brecker e Dewey Redman. L’atmosfera evoca sempre quella dei gruppi di Ornette Coleman a ritmi incalzanti e sostenuti, tranne «The Bat» che si presenta come una ballad dalle atmosfere rarefatte, tipica del Pat Metheny più lirico e intimista. Talmente affascinato dalla figura di Ornette Coleman, Pat Metheny successivamente, nel 1986, registrò un disco insieme, «Song X». In quell’album comparivano anche Charlie Haden e Jack DeJohnette, quando si dice corsi e ricorsi storici.
La vecchia epoca dei primi anni ’80 con sogni annessi si salda ai sogni nuovi con quel tratto di disincanto che la modernità si porta dietro; «Old And New Dreams» (vecchi e nuovi sogni) che è anche il nome di un gruppo acustico che dal 1976 al 1987 (Dewey Redman, Charlie Haden, Ed Blackwell e Don Cherry) continuò a suonare alla maniera di Ornette Coleman perché il sassofonista si era dato all’elettrico con i Prime Time. Il periodo elettrico di Ornette Coleman è quanto di più inascoltabile che io abbia mai sentito e lo dico, avendo sempre apprezzato la svolta elettrica del jazz. Riascoltando i lavori di quell’ultimo periodo ho un moto di fastidio; io così ecumenico che non sono altro, li ho risentiti solo per spirito di documentazione. E a proposito di disincanto e di una certa patina di malinconia, mi avvio con «Going Ahead», ultima traccia del disco e alla fine di questo scritto. Un brano per sola chitarra di Pat Metheny di una bellezza sconfinata, almeno per la mia maniera di intendere i confini e gli sconfinamenti, e non posso che accomiatarmi da come avevo iniziato, ovvero con un tributo alla musica: «Ogni giorno (ti ringrazio)», (Every Day (I Thank You).

e Charlie Haden