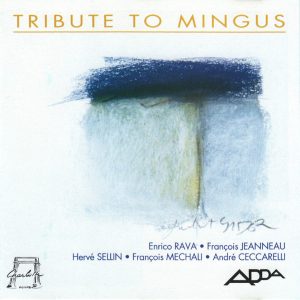Alla ricerca di una consapevole ingenuità: «Improvvisamente», l’ultimo lavoro di Marco Detto

DIGIPACK4P
…un lavoro sanguigno – ma con momenti di grande delicatezza – che pare mosso da una forte urgenza espressiva, dove il gesto pianistico non si preoccupa di una perfezione che cristallizza l’atto ma dell’intenzione che a un tempo si muove con l’azione sonora e le dà la vita.
// di Valentina Voto //
È stata da poco pubblicata l’ultima fatica discografica di Marco Detto, noto pianista della scena jazzistica meneghina che può vantare una lunga carriera, più di venti album all’attivo, diverse collaborazioni di vaglia (su tutte quelle con Peter Erskine, Palle Danielsson ed Eddie Gomez) e una voce a lui dedicata nel Dizionario del jazz italiano di Flavio Caprera.
Il nuovo album si intitola «Improvvisamente», e vede Detto leader di un trio sui generis, diverso dal suo tipico combo, come è quello con gli storici collaboratori Marco Ricci e Giorgio Di Tullio: al basso elettrico infatti troviamo Michele Tacchi, mentre alla batteria siede Alessandro Rossi. Sono trascorsi tre anni dall’ultimo lavoro in solo, «Blue Moon», e ben più tempo dagli ultimi lavori di sole novità di Marco, come è questo (prodotto dall’Associazione Culturale Eugenio Nobili e con grafica di copertina dell’inseparabile Annalisa Parisii). Qui, infatti, il trio si cimenta in una serie di brani originali e (quasi tutti) inediti a firma Detto, che però sono stati rifiniti in studio e impreziositi dai contributi di Tacchi e Rossi. L’atmosfera pare diversa dai lavori precedenti, nell’idea forse di una rilettura, soprattutto timbrica (si sentano gli inserti discreti di synth) di quel mainstream di qualità sempre percorso da Detto nel corso della sua carriera. E se le anime di questo album possono apparire diverse, esse restano sempre coerenti nel concorrere allo sviluppo di quella che sembra una storia, un racconto, i cui episodi portano i nomi di ciascun brano e il cui soggetto pare la genesi stessa della musica, di quella non solo di Marco, ma più in generale di ogni musicista di jazz, e del tipico processo creativo ed espressivo del genere.
In una lettura connotativa sicuramente suggestiva, «Improvvisamente», «Nota dopo nota», «Semplice», «Senza parole» (brano già presente nell’album omonimo del 2022 con Maria Antonietta Puggioni al violoncello), «Sospeso», «Incerto» – e inseriremmo anche «Gentleman», legandolo a una gentilezza di spirito che tiene ben lontano il nostro dall’egoriferitismo tanto in voga oggi – paiono mettere a fuoco alcuni degli aspetti comunemente, e giustamente, legati alla creatività estemporanea del genere, fatta di dubbio, spiazzamento, sorpresa, di complessità levigata e camuffata a tal punto da trascolorare nel suo contrario, infine di continuo movimento e spinta a procedere sempre avanti, passo dopo passo, «nota dopo nota», per tentativi, errori, correzioni in itinere, come è richiesto da quel vagare tra controllo e abbandono, automatismo e guizzo, da quell’errare anche nell’ignoto, che è tipico dell’improvvisazione. La spinta melodica resta forte, come è proprio della produzione di Detto, e le melodie sono improntate sempre a una certa cantabilità, ma conservano una spiccata coloritura e forza ritmica, mai celando la densità e complessità del gioco armonico sotteso. Ne viene fuori un lavoro sanguigno – ma con momenti di grande delicatezza – che pare mosso da una forte urgenza espressiva, dove il gesto pianistico non si preoccupa di una perfezione che cristallizza l’atto ma dell’intenzione che a un tempo si muove con l’azione sonora e le dà la vita. Di valore il lavoro di Rossi, ma di pregio ci è parso soprattutto quello di Tacchi, contrappeso perfetto al gesto pianistico quasi terrigno, materico di Detto, grazie ai suoi misurati ed eleganti interventi, a quelle linee melodiche e quella resa timbrica che lo fanno apparire aria laddove Detto si mostra come la terra più mota (da notare poi che, il basso, di solito acustico, è da sempre lo strumento favorito dal nostro per i suoi dialoghi dal piano).
Attenzione infine all’espressione vocale di comple(ta)mento: Detto in passato è stato criticato da colleghi franciosi proprio (e solo) per i suoi «fastidiosi lamenti» durante l’atto sonoro. Ma, a questo punto, noi chiediamo: non è forse proprio l’estetica del suono «sporco», o meglio «ricco», ciò che non solo connota timbricamente il jazz ma che è anche grandemente apprezzato da noi ascoltatori del genere? E se l’energia è tale da non potersi esaurire nel solo gesto fisico, perché trattenerla e non liberarla attraverso la voce, che ne sarebbe il veicolo d’elezione? Nel rapporto di un jazzista con la musica che crea, poi, è sempre in gioco tutto il suo corpo, inteso come un òlon, un intero mai scisso e mai da considerarsi tale. Un Jarrett al piano non sarebbe lo stesso senza i suoi tipici contorcimenti e mugugni, e non vediamo perché usare, si parva licet (e noi crediamo che lo sia), parametri differenti di giudizio e di ascolto.
Ad ogni modo, l’ultima uscita di Marco Detto ci ha dato l’opportunità di intervistare l’artista e di parlare un po’ della sua musica e della sua carriera. È stata una conversazione aperta e franca, piena di buffe interruzioni, occhiate eloquenti, parole sospese, e percorsa da sincere umiltà e dedizione alla musica. A ricordarci che, alle volte, è più semplice esprimere il nostro Sé più autentico con le note piuttosto che con le parole…ma è sempre necessario qualcuno che ci sappia e ci voglia ascoltare. E ci doni qualcosa che tanto sfugge oggigiorno: tempo.

QUI VI PROPONIAMO UNA PARTE DELLA NOSTRA LUNGA CHIACCHIERATA.
D. Marco, ci diresti qualcosa del tuo ultimo album, Improvvisamente?
R. Eh, mi risulta difficile discorrere della mia musica e della genesi della mia musica… è certo legata ai pensieri che ho… A posteriori l’album sembra una storia, sembra tutto legato: «Sospeso» è quel momento di sospensione che c’è quando inventi; «Semplice» è ciò a cui tutti miriamo, quell’idea complessa che però deve scorrere e n0n risultare tale; «Incerto» è il dubbio che c’è sempre, perché ogni nota è sempre un salto nel buio – che non è però casualità, ma la ricerca di una consapevole ingenuità in una musica che procede sempre «nota dopo nota» e si lascia dietro sempre questo mistero… Tu ti abbandoni al tuo vissuto e al tuo bagaglio teorico per metterlo al servizio della storia e della musica, e l’ascoltatore si deve affidare a te e a quello che gli racconti dopo che lo hai invitato a vivere con te questo tempo nel tempo. Suoni chi incontri, chi vivi, chi ti sta affianco, quello che ti accade. D’altronde noi siamo chi incontriamo e quello che ci accade, no? E questo è vero anche per quest’album.
D. La novità più evidente di questo disco credo sia la formazione, con Michele Tacchi al basso elettrico e Alessandro Rossi alla batteria.R. Tacchi insegna composizione a Londra ed è stato mio allievo quando aveva vent’anni, a Gallarate. Negli ultimi dieci anni, anche con Rossi, abbiamo avuto modo di suonare insieme diverse volte, e quando mi sono trovato a ragionare sul nuovo disco ho pensato a loro, che sono anche persone gentili… è stato bello lavorare insieme, e il risultato finale è frutto anche di un bel lavoro collettivo. Poi credo sia la prima volta che registro un intero album con un basso elettrico, anche se Marco Ricci in diversi dischi passati lo aveva utilizzato in aggiunta al suo contrabbasso, e c’è anche una presenza esigua del synth – corno e hammond –, che ho usato più come un colore. Se avessi dovuto suonare standard forse avrei desistito, ma ho pensato che i brani così avrebbero potuto suonare bene. Così come col basso elettrico.
D. Si nota comunque che i temi sono, come sempre, molto orecchiabili e cantabili… potremmo dire questa una cifra della tua scrittura?
R. Sì. Quando scrivo devo sentire un tema che mi rimane. Tanti progetti nuovi, contemporanei, perseguono altre estetiche, altri tipi di scrittura, ma a me appaga sentire prima una melodia – che riconfermo a me dopo averla scelta e riprodotta –, e poi le variazioni sulla melodia stessa e l’improvvisazione… D’altronde se pensiamo agli standard, al repertorio per noi classico, a My Funny Valentine, Gershwin, Porter, lì ci sono tutti temi chiari, c’è una melodia riconoscibile e cantabile… Questa è la mia visione certo! Non pretendo che sia legge… Ma a me piace far tesoro della tradizione, anche se vivo adesso, con una marea di influenze che entrano inevitabilmente nella musica.
D. Questo disco è nato così, «improvvisamente», o avevi pianificato un album di soli inediti?
R. Beh, io scrivo sempre: mi piace scrivere musiche nuove per suonarle dal vivo, e ne avevo accumulate un po’ (ne ho delle altre ancora). Ne impiego eh di tempo per scrivere, perché ne scarto di materiale… qualcosa prima di scriverlo e di fissarlo mi deve catturare, emozionare. Alla fine ho scelto queste… È come quando improvvisi: quello che devi cercare di evitare non è tanto l’errore della nota sbagliata – perché è ciò che fai dopo l’importante –. La tristezza è quando nell’improvvisazione non riesci a trovare la musica. Questo è l’errore per me imperdonabile ed è per evitare questo che ancora lavoro e studio, ogni giorno, e per avere la libertà di iniziare un viaggio sempre attento e consapevole, ma allo stesso tempo improntato a ingenuità e chiarezza. È chiaro che se c’è un momento di buio entra il cambio automatico, l’azione meccanica, ma devi servirtene in extremis, come ancora di salvezza, ed è ciò che devi cercare di rifuggire, soprattutto in un disco. È anche quello che insegno… dico come affronto io l’accadimento dell’improvvisazione, la musica, ma poi non voglio certo che i miei allievi suonino come me! Devono essere loro a raccontare la loro storia. Lo studio è questo: suonare ed essere riconoscibili. Anche se, certo, è inevitabile sentire nel tuo suono anche altre influenze, però non devono essere prevalenti.
D. Quali sono le tue di influenze (non prevalenti)?
R. Guarda, c’è così tanta musica.. però i pianisti da cui ancora oggi scopro qualcosa di nuovo e che hanno ciascuno una peculiarità che mi attira sono Monk, per l’aspetto ritmico… ma c’è anche la melodia cantabile… quindi Bill Evans… e poi c’è anche Jarrett, che mi ha sempre folgorato, in solo o in trio, quindi Hancock, Corea, Zawinul, fino a Powell ed Ellington… sono tutti pianisti che ho dentro, come tantissimi altri. Però il jazz è musica onnivora, quindi io ascolto anche musica eurocolta [N.d.R. il figlio di Marco, Martino, è non a caso proprio un pianista classico], così come apprezzo anche un bel pezzo di musica leggera. Poi, sai, io ho avuto un percorso di crescita così disordinato…
D. Ce ne parleresti?
R. Sono totalmente autodidatta. Mio padre strimpellava un organetto e mi insegnò lui la prima canzoncina. Presto però ho iniziato ad ascoltare il progressive rock, quindi Genesis, Pink Floyd e così via, ma non appena ho scoperto il jazz… L’ho scoperto partendo dai Weather Report, poi sono andato a ritroso, innamorandomi di Garner, Ellington… mischiavo ascolti del primo jazz con gli ascolti degli anni della mia crescita, quindi c’era Ellington accanto a Corea accanto a Cole Porter ecc. È stato un percorso di formazione molto disordinato. Il bop per es. l’ho ascoltato dopo e tanti jazzisti che non riuscivo a comprendere per la mia incompetenza, anche di ascoltatore, li ho graditi solo in seguito. Quindi tutto è arrivato molto più lentamente… Però è anche vero che i miei primi vent’anni li ho vissuti in Abruzzo e non c’erano i mezzi che ci sono oggi. Un disco di jazz non lo trovavi facilmente, soprattutto in una città di provincia del Centro Sud come era la mia. Quando i miei genitori si sono trasferiti qui alla fine è stato un bene per la mia musica, ci sono state sicuramente più opportunità.
D. Ci racconteresti qualcosa delle tue collaborazioni più note?
R. Ecco, devo dirti che è accaduto tutto come in un film, naturalmente, senza pressioni. Quando collaborai con Erskine e Danielsson avevo 32 anni e due dischi alle spalle, non c’era ancora Internet. Dopo aver ottenuto il via libera dall’etichetta per la produzione del disco, trovammo il manager del loro trio (quello con John Taylor) e gli scrissi. Mi disse di spedire un mio CD e dei brani nuovi, così gli mandai il mio lavoro precedente e dei brani registrati su cassetta. Fece sentire tutto a Erskine e Danielsson e i due apprezzarono e mi dissero «Quando abbiamo un giorno libero lo facciamo». Il disco nato da quella collaborazione infatti, La danza dei ricordi, è stato registrato in 7 ore: quei brani non li avevo mai suonati neanche con il trio (che al tempo era con Ricci e Di Tullio), avevo voluto tenerli fermi. Venivano da Bologna e lo abbiamo inciso in un giorno. Non abbiamo mai suonato dal vivo, ovviamente.
D. E con Eddie Gomez?
R. Con Gomez è stato lo stesso. Ero stato a suonare a NY con Paula West e avevo il numero di Gomez (che mi aveva dato Ricci); così lo andai a trovare e gli diedi il mio disco del 1998, Altrove, pensando «Chissà quante migliaia di persone gli hanno portato un disco….» Questo succedeva ad aprile. A gennaio Gomez mi chiamò per telefono, perché gli avevo lasciato il mio numero, e meno male che non l’ho mandato a quel paese! Pensavo fosse uno scherzo… Lui parlava un po’ in italiano, un po’ in spagnolo, io parlavo male l’inglese. «Chick no puede tocar, McCoy no puede, tu puede tocar…?» «Tocar?», e ho impiegato un po’ per capire cosa volesse da me: «Tocar! Play!», «Ah! Suonare!». E fu così che feci quattro concerti, sostituendo questi giganti in un tributo a Bill Evans, con Jeremy Steig al flauto e Lenny White alla batteria. L’anno dopo l’etichetta ha accettato di produrre un disco in trio che avevo inciso a NY (con Gomez e White), quindi abbiamo fatto un’altra tournée in trio. Però è accaduto tutto così… Una volta, in auto, mi è capitato di chiedere a Gomez «Eddy, tu suoni con Chick Corea e con tanti grandi… mi diresti io a chi assomiglio?» E, mentre guidava, mi ha risposto «Sì, un po’ a Bill Evans… un po’ a Chick… ma tu suoni Marco Detto» . Lì per lì ci rimasi male, avevo 37 anni. Ma ripensandoci poi…- »Me gusta il tuo senso della melodia» – mi fece piacere.
D. Ormai hai una carriera piuttosto lunga alle spalle… nella tua produzione c’è sempre l’importanza di raccontare una storia e la massima rilevanza data al tema, trattato ogni volta con grande attenzione, ma c’è qualcosa che è cambiato nel tuo suono e nel tuo modo di approcciarti al suono?
R. Mah, a volte risento cose mie vecchie. La fonte, la radice, la riconosco sempre, perché sempre ritrovo le melodie, sempre «suono Marco Detto». La melodia e il ritmo sono entrambi aspetti che mi attraggono (perché spesso, invece, è più presente la matrice, diciamo, africana)… Però, ecco, oggi c’è certo una maggiore consapevolezza per il respiro e nel respiro, cosa che in giovane età non avevo, preso com’ero dalla foga del suonare. Do un peso maggiore al silenzio, e alla scelta, così come avviene nelle relazioni: da giovane frequenti chiunque, poi diventi più selettivo.
D. Una domanda (schiettamente retorica) circa il panorama musicale attuale: è davvero così desolante? Dico dal punto di vista dei contenuti, ma anche da quello del riconoscimento economico… L’arte ha ancora valore?
R. Non lo so… Vivo un momento generale di smarrimento e confusione. Sono così contento di aver generato nuova musica, ma non penso sia più oggetto di una reale considerazione. Penso sia più che peggiorata, in generale, l’attenzione che tutti rivolgono a tanti musicisti e all’ascolto – se ancora si ascolta. Forse sono altre le leve che spingono, altri i metri di valutazione. Pensavo di essere nell’età del raccolto, ma il raccolto è sconsolante. Le cose che mi sono accadute in gioventù sono fantastiche, ma accadute come in un film, senza leve occulte o altro. Ed è una gioia che non dimenticherò. Dal punto di vista lavorativo, però, oggi è triste, veramente triste. Non so più cosa serva per poter far sentire la propria musica, il proprio lavoro. Quando ho suonato ad Umbria Jazz da sideman (perché, a dispetto di ciò che si crede, io posso suonare eccome da sideman), una volta sceso dal palco, in molti si sono avvicinati complimentandosi e dicendomi «Ma non ti conoscevo! Dove sei stato finora?». Ecco, sono ancora qui…
D. C’è forse anche un problema di pubblico, che è anche anagrafico…?
R. Oh! Se penso al pubblico dei miei ultimi concerti, erano quasi tutti più grandi di me! Se vedo un «giovane», ha 45/50 anni. Quando ho cominciato a suonare jazz – quindi diciamo nel 1980 –, al Capolinea, alle Scimmie e in tutti i jazz club del circondario il pubblico era formato da miei coetanei. Ora, se va bene, sono miei coetanei, cioè sessantenni! È vero anche che quando ascolti non devi avere pregiudizi… devi affidarti alla nave che salpa sul palco e fidarti di quello che ti viene raccontato, farti portare… ma forse c’è anche un problema ancora più grande di umanità, basta vedere quello che ci circonda, e questo germe di disattenzione, in primis nelle relazioni, che ha dilagato ovunque…Sento che è un’umanità più «sicca» quella di oggi. E se manca questa, come può esserci pubblico per la musica?