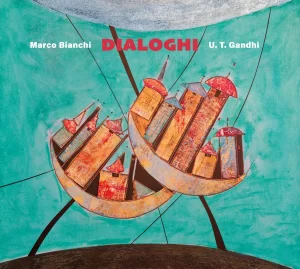«Eastern Rebellion, Vol. 2» di Cedar Walton: una continuità rinnovata nel cuore del mainstream moderno (Timeless, 1977)

Riascoltato oggi, il disco rivela una qualità che sfugge alle classificazioni rapide: non è un semplice proseguimento del primo volume, né un tentativo di aggiornamento stilistico, ma rappresenta piuttosto una dichiarazione di continuità consapevole, un modo di affermare che il mainstream, quando sostenuto da interpreti di tale levatura, può ancora offrire risultati di notevole profondità e una vitalità sorprendente.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Cedar Walton occupa una posizione singolare nella storia del pianismo afroamericano del secondo Novecento: non un innovatore clamoroso, ma un artefice di equilibrio, un musicista che ha saputo fondere rigore strutturale, senso della forma e una naturale propensione alla cantabilità, inventando un linguaggio immediatamente riconoscibile, pur restando pienamente inscritto nella tradizione.
La sua formazione, nutrita dall’esperienza con Art Blakey e dai frequenti contatti con i protagonisti dell’hard bop, gli permise di assimilare la grammatica del jazz moderno senza irrigidirla. Walton non procedeva per rotture, ma per raffinate modulazioni interne, dove il suo tocco, sempre nitido e controllato, evitava l’enfasi e privilegiava una chiarezza espositiva, derivata tanto dall’attenzione alla linea melodica quanto dalla cura delle progressioni armoniche. Riascoltandolo, ci si avvede che nei suoi accompagnamenti emerge una sorta di impostazione contrappuntistica che non sovrasta mai l’interlocutore, ma ne sostiene il discorso con una coerenza interna rigorosa. Il suo fraseggio si distingue per una mobilità misurata, dove la mano destra articola idee melodiche limpide, spesso costruite su cellule brevi che si trasformano con naturalezza, mentre la mano sinistra disegna un sostegno armonico solido e mai invadente. Walton predilige voicings ampi, distribuiti con precisione, che conferiscono al suo pianismo una qualità quasi orchestrale. Questa attitudine a rendere trasparente l’ordito armonico, senza gravarlo, lo colloca nella linea che unisce Hank Jones, Tommy Flanagan e Barry Harris, pur mantenendo una voce personale, più asciutta e meno incline al lirismo espanso.
All’interno della scuola afroamericana, Walton rappresenta un nodo di raccordo fra l’eredità bebop e la successiva stagione del post-bop. Da un lato conserva la chiarezza ritmica e la logica discorsiva dei maestri degli anni Quaranta e Cinquanta; dall’altro introduce una sensibilità più moderna, attenta alla continuità del procedura e alla coesione dell’insieme. La sua scrittura, soprattutto nei gruppi da lui guidati, mette in luce un interesse costante per la forma intesa come processo in evoluzione, non come semplice giustapposizione di sezioni, in cui ogni brano procede secondo una coerenza implicita che riflette una progettualità compositiva matura e consapevole. Il suo ruolo nella tradizione non si esprime in un atto rivoluzionario, bensì nella capacità di mantenere vivo un linguaggio, rinnovandolo dall’interno con una lucidità rara. Walton incarna quella linea del jazz afroamericano che non cerca l’effetto, ma la continuità; che non punta alla rottura, ma alla profondità; che non si affida alla spettacolarità, ma alla precisione del dettaglio e alla solidità del discorso musicale
Quando nel 1975 apparve «Eastern Rebellion, Vol. 1», l’incontro fra Cedar Walton, George Coleman, Sam Jones e Billy Higgins delineò un territorio espressivo in cui il mainstream moderno trovava una sua forma di rigore e naturalezza, lontana dalle derive elettriche e dalle contaminazioni che in quegli anni ridefinivano il lessico del jazz. Quel primo capitolo, costruito su un equilibrio impeccabile fra invenzione melodica e disciplina ritmica, mostrava quattro interpreti di solida esperienza intenti a presidiare un linguaggio che non aveva alcuna intenzione di cedere alle mode del momento. Con «Eastern Rebellion, Vol. 2», registrato nel 1977 e pubblicato dall’etichetta olandese Timeless, Walton prosegue quella traiettoria, ma la orienta verso una dimensione più raccolta, quasi cameristica, affidandosi a un organico invariato nella sezione ritmica e rinnovato nella voce solistica: al posto di Coleman entra Bob Berg, la cui presenza imprime all’intero concept una fisionomia diversa, più assertiva e meno legata alla tradizione hard-bop degli anni Sessanta. La musica non indulge in effetti scenici né in tecniche estese, e proprio questa sobrietà consente di cogliere la qualità intrinseca del quartetto. Walton, autore di tutte le composizioni, modella un impianto che favorisce la chiarezza delle linee, la precisione delle progressioni e una continuità intrinseca che rende l’album sorprendentemente compatto. La sue partiture non mirano a stupire, ma a definire un ambiente sonoro in cui ogni gesto trova una sorta di alveo naturale, sostenuto da una retroguardia che agisce come un congegno perfettamente calibrato.
«Fantasy In D» inaugura il percorso con un tema agile, costruito su un moto armonico che alterna slanci e ripiegamenti, lasciando emergere la voce di Berg con una nitidezza che porta in auge la sua attitudine a coniugare energia e controllo. Walton dispensa il suo intervento con un fraseggio limpido, privo di ridondanze, mentre Sam Jones e Billy Higgins mantengono un sostegno elastico, in grado di assecondare ogni deviazione senza perdere la direzione generale. «The Maestro» si orienta verso un’atmosfera più raccolta, quasi meditativa. La linea melodica, essenziale e ben tratteggiata, permette a Walton di sondare un registro più lirico, mentre Berg interviene con un profilo acustico che si sposta fra morbidezza e accenti più marcati. La sezione ritmica, discreta ma vigile, conferisce al tessuto melodico una fluidità che ne esalta la coesione. Con «Ojos de Rojo» la cinetica di gruppo s’inalbera: Walton pennella un disegno ritmico più serrato, che Higgins interpreta con una finezza inconfondibile. Berg, qui particolarmente ispirato, intarsia frasi che oscillano fra tensione e distensione, mentre Jones mantiene un ancoraggio saldo, quasi un asse portante attorno al quale ruotano le altre voci. Il punto di massima estensione arriva con «Sunday Suite», una composizione di quasi diciotto minuti che consente al quartetto di dispiegare un arco narrativo ampio e suddiviso in sezioni che si susseguono con sorgività. Walton guida l’intero tracciato con una prassi procedurale che alterna episodi più rarefatti a momenti di maggiore cromatismo, senza mai smarrire la coerenza del disegno complessivo. Berg, Jones e Higgins reagiscono con un interplay che testimonia una profonda intesa, frutto di un ascolto reciproco costante e di una sensibilità condivisa per modulo espressivo.
«Eastern Rebellion, Vol. 2» non mira a imporsi attraverso soluzioni eclatanti, ma in virtù una continuità estetica che affonda le radici nella tradizione acustica del jazz moderno, pur lasciando emergere una sensibilità pienamente inserita nel contesto degli anni Settanta. La sua forza risiede nella lucidità del gesto, nella cura delle transizioni e nella capacità di Walton di delineare un percorso che unisce rigore e immaginazione senza mai indulgere in eccessi esibizionistici. Riascoltato oggi, il disco rivela una qualità che sfugge alle classificazioni rapide: non è un semplice proseguimento del primo volume, né un tentativo di aggiornamento stilistico, ma rappresenta piuttosto una dichiarazione di continuità consapevole, un modo di affermare che il mainstream, quando sostenuto da interpreti di tale levatura, può ancora offrire risultati di notevole profondità e una vitalità sorprendente.