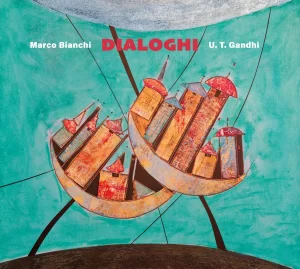Gene Ammons con «The Soulful Moods»: non un semplice lotto di ballate ma un metodo insuperabile per raccontare il sentimenti (Moodsville Records1963)

«The Soulful Moods» non va considerato un disco minore, non costituisce un episodio laterale, soprattutto, non è un esercizio di stile, ma sancisce una metodica sopraffina che fa di Gene Ammons uno di maggiori balladeer della storia del jazz moderno.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Gene Ammons appartiene a quella categoria di sassofonisti che la storia del jazz ha trattato con una distratta ingiustizia. Per decenni il suo nome è rimasto confinato in un limbo di riconoscimenti intermittenti, come se la sua voce tenorile – una delle più personali del dopoguerra – fosse troppo diretta, alquanto franca e decisamente poco incline alle mode per ottenere il credito che meritava. La sottovalutazione non va considerato un dettaglio marginale: ma costituisce un sintomo. Ammons non costruì mai un personaggio, non mirava all’effetto, soprattutto non trasformò mai il proprio suono in un manifesto politico; per contro preferì battere un’altra via, ossia quella dell’intensità controllata, dell’emozione che non si esibisce e della frase che non chiede attenzione ma la ottiene per necessità interna. Come scriveva, all’epoca, il critico Stanley Dance: «Se negli ultimi anni Ammons è stato poco considerato, forse dipende dal fatto che la sua musica ha una sobrietà che va in direzione opposta rispetto allo spettacolo autoreferenziale oggi richiesto per emergere».
Le ballate sono sempre state il luogo in cui i veri tenoristi hanno mostrato la loro identità più profonda: non il virtuosismo, non la rapidità, non la forza bruta, ma la ballata. Fu proprio su questo terreno che Hawkins affermò la sua autorità, che Lester Young esternò la sua vera essenza, che Ben Webster fece del timbro una presenza fisica e che Rollins e Coltrane lasciarono affiorare la loro parte più vulnerabile. «The Soulful Moods» si accosta a questa procedura: un disco che non usa la lentezza come rifugio, ma come strumento di verità. Ammons affronta alcuni standard senza alcuna volontà di ornare o modernizzare; li percorre con quella calma intensa che appartiene ai balladeer di rango, dando a ciascun episodio un peso preciso, una direzione chiara e una necessità. Siamo alle prese con un album che non chiede di essere giudicato per la sua atmosfera, ma per la qualità del pensiero che custodisce.
L’etichetta di honker, appiccicata al tenorista negli anni, per via dei package-shows e dei duetti ad alto voltaggio con Sonny Stitt, ha fatto più danni di quanto si ammetta. Bastano pochi minuti di ascolto per capire quanto fosse fuorviante: Ammons non fu mai un acrobata del volume, né un professionista dell’eccesso. Anche nei contesti più rumorosi, la sua voce rimaneva riconoscibile per la qualità del timbro, per la morbidezza del fraseggio, per quella malinconia strutturale che tagliava trasversalmente tutto il repertorio. Il problema, semmai, è che, in genere, la memoria collettiva conserva gli episodi più appariscenti e dimentica la sostanza. La sua influenza, invece, fu profonda. Rollins, Coltrane, Dexter Gordon, Stitt e altri hanno assorbito qualcosa da lui: chi la compattezza del suono, qualcuno la naturalezza del blues e altri la capacità di trasformare uno standard in un terreno di confessione. Ammons non appartiene a una scuola precisa, e forse proprio questa diventa la ragione della sua marginalizzazione. Egli non mai rappresentato l’epigono di Hawkins, o il discepolo di Lester Young, incarnando invece la figura del musicista abile nel metabolizzare entrambi senza diventarne una copia. Un ibrido fertile, e come spesso accade agli ibridi, difficile da classificare.
«The Soulful Moods» mette in luce, in maniera inequivocabile, il suo sistema operativo. Il contesto Moodsville potrebbe far pensare a un album di pura atmosfera, ma Ammons lo usa per mostrare la parte più intima del suo linguaggio, basata su un blues che non ha bisogno di alzare la voce, una malinconia che non indulge, una tenerezza che non scivola mai nel sentimentalismo da collezione Harmony. La scelta degli standard – otto componimenti che appartengono alla memoria collettiva del jazz – diventa un banco di prova ideale, dove non è ravvisabile alcun trucco, nessuna copertura, ma solo la nuda qualità del suono e la capacità di espandere una melodia. Accanto a lui, un trio calibrato con cura: Patti Bown, pianista di eleganza tersa e fine sensibilità armonica; George Duvivier, uno dei bassisti più affidabili e della scena newyorkese; Ed Shaughnessy, batterista capace di discrezione e slancio. Un retroguardia che oltrepassa il concetto di mero accompagnamento, per incorniciare ed amplificare l’intreccio tematico. La sequenza degli standard diventa, in questo disco, una sorta di autoritratto in controluce. Ammons entra in «Two Different Worlds» con una calma che non ha nulla di inerte, per contro sembra recuperare il tema mentre lo plasma, lasciando emergere una malinconia asciutta, priva di enfasi, che fa del componimento una confessione sussurrata. Il tempo medio gli consente di far affiorare un carattere ambiguo, sospeso tra dolcezza e disincanto, mentre il blues che scorre in ogni curva del suo discorso non è un ornamento ma il nucleo stesso del suo pensiero. In «But Beautiful» la lentezza non scivola mai nel languore. Ammons indaga la linea portante con una delicatezza che evita la retorica, e quando la dinamica si dischiude, lo fa con un’intensità sorvegliata, come se il sax cercasse un punto di sincerità più che un culmine, tanto che la ballata non diventa un esercizio di stile, ma un luogo in cui l’emozione si chiarisce, nota dopo nota, con una modus agendi che non ha bisogno di spiegazioni.
«Skylark» riceve un trattamento diverso: l’introduzione, breve e quasi mimetica, suggerisce un moto circolare, un richiamo, prima che il tema si distenda in quel timbro vellutato che è una delle firme di Ammons. Il tema, consumato da decenni di interpretazioni, qui ritrova una freschezza inattesa, sebbene non sia rintracciabile nessuna volontà di reinventarla, ma solo la capacità di farla respirare con naturalezza, come se fosse nata per la sua voce tenorile. Patti Bown inserisce un intervento conciso ma decisivo, ossia un contrappunto che illumina il percorso di Jug senza appesantirlo. Con «Three Little Words» il disco cambia inclinazione. Il tempo si alza, ma Ammons non sfrutta la velocità per mostrare agilità, ma piuttosto preferisce una mobilità elastica e una leggerezza che non perde mai il centro. Il trio diventa una piccola officina ritmica: Bown si concede un’espansione più ampia, Duvivier e Shaughnessy danno vita a un terreno pulsante ma discreto, mentre l’insieme genera quella intimità vivace che appartiene ai quartetti più affiatati. «On The Street Of Dreams» riporta l’album nella sua zona naturale: la ballad come spazio di esposizione interiore. Ammons non forza nulla, non cerca effetti e non abbellisce. Il tema procede con una linearità che diventa quasi un gesto etico, teso a dire solo ciò che serve, senza aggiungere un grammo di superfluo. Ne nasce una calma che non risulta mai decorativa, ma abitata fino in fondo. «You’d Be So Nice To Come Home To» introduce una tinta latina leggera, un’oscillazione che non snatura il costrutto sonoro, ma gli dona una luminosità diversa. Ammons mantiene la sua voce riconoscibile, mentre il trio si apre a un gioco più brillante. Bown, in particolare, sgancia un assolo fluido, pieno di piccole deviazioni armoniche che rendono procedimento più vivo senza farlo diventare un episodio virtuosistico. «Under A Blanket Of Blue» rappresenta uno dei vertici del disco. L’introduzione di Patti Bown, quasi cinematografica nella sua sobrietà, prepara l’ingresso di Ammons che sembra provenire da un luogo remoto. Il suono si allarga, ma non perde mai la sua qualità intima, dove ogni tratto di materializza come un passo misurato e un gesto che non vuole impressionare ma chiarire. L’ordito tematico diventa un territorio di prossimità emotiva, dove il sax sembra parlare più che cantare. «I’m Glad There’s You» chiude il percorso con una grana sottile che non scivola nel sentimentalismo. Ammons adotta un timbro più soffuso, quasi un sussurro, lasciando che il tema estrinsechi da solo la capacita seduttiva. Nelle sue mani non è un semplice standard romantico, ma diventa un atto di gratitudine trattenuta, una dichiarazione che non ha bisogno di alzare la voce per risultare credibile. «The Soulful Moods» non non va considerato un disco minore, non costituisce un episodio laterale, soprattutto non è un esercizio di stile, ma sancisce una metodica sopraffina che fa di Gene Ammons uno di maggiori balladeer della storia del jazz moderno. Siamo alle prese con una confessione in musica, quella di un musicista che si mette a nudo senza esibizionismo, forte di un quartetto che ascolta più di quanto suoni e di un repertorio che ritrova la sua necessità. È un album che continua a parlare perché non ha mai cercato di gridare.