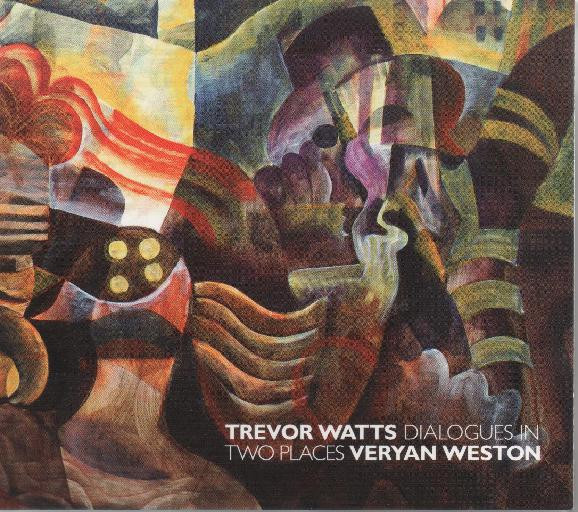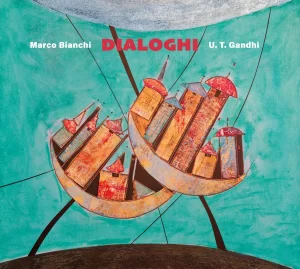Trevor Watts: ritratto con cornice di un infaticabile costruttore di mondi sonori

Trevor Watts
La lezione che Watts fissò come una regola di vita: la libertà non si chiede, ma si esercita. Trevor si caratterizza così come un artista ultraottantenne che continua a sondare inedite combinazioni, valutare nuovi compagni di cordata e cercare luoghi inesplorati, incarnando la figura di musicista che ha fatto dell’ascolto un’etica e della curiosità la propria guida.
// di Francesco Cataldo Verrina //
Il giovane Trevor passava interi pomeriggi a rovistare nella collezione di dischi del padre, un piccolo tesoro custodito in una credenza che sembrava più un altare che un mobile. Il vecchio giradischi, con la sua cinghia che faticava a ingranare, diventava il centro di un rito quotidiano: bastava abbassare la puntina sul vinile perché la stanza si riempisse di nuances provenienti un mondo lontano, fatto di pianoforti che sembravano cantare ridendo, voci che giocavano con il ritmo, orchestre che si muovevano come organismi vivi. Ore sottratte al gioco e allo studio scorrevano così, tra i solchi consumati di Fats Waller, la brillantezza ironica di Nellie Lutcher, la morbidezza elegante di Tex Beneke, l’universo orchestrale di Duke Ellington. Ogni disco apriva una finestra diversa: Waller gli mostrava come l’umorismo potesse convivere con una precisione assoluta; Lutcher gli insegnava la leggerezza come forma di intelligenza; Beneke gli rivelava la grazia del fraseggio; Ellington gli offriva un mondo costruito su colori, contrasti, presenze che dialogavano tra loro come personaggi di un racconto. Trevor non aveva alcun interesse a imitarli, ma si lasciava attraversare da ciò che ascoltava, come se ogni disco depositasse dentro di lui un sedimento prezioso, un granello dopo l’altro, fino a creare un terreno che avrebbe nutrito tutto ciò che sarebbe venuto in seguito. Non copiava nulla, ma consentiva a quelle musiche di adagiarsi, maturare e trovare un posto.
Da Fats Waller assorbì una combinazione rara: la precisione assoluta che convive con un’ironia naturale, mai forzata. Da Nellie Lutcher gli rimase addosso una grazia nel muoversi tra melodia e ritmo, una leggerezza che non scivola mai nella superficialità. Tex Beneke gli insegnò un fraseggio che non inseguiva l’effetto, ma puntava a un equilibrio interno e una continuità che non aveva bisogno di alzare la voce. Duke Ellington, infine, gli mostrò un mondo costruito sulle relazioni, un suono che nasce dall’incontro tra individui, da presenze che dialogano, si sfiorano e si completano senza mai annullarsi. Tutto ciò, per Trevor Watts non costruì un semplice bagaglio di ascolti, ma diede forma al suo modo di concepire la musica, con un’impronta che lo accompagnerà per sempre. A ottantasei anni Trevor Watts conserva la stessa urgenza creativa che lo animava quando, negli anni Sessanta, contribuiva a ridefinire la musica improvvisata britannica con lo «Spontaneous Music Ensemble». Il suo cammino non seguì mai pedissequamente la scia delle tendenze, evolvendosi in virtù di incontri, relazioni, svolte e intuizioni che diventarono paesaggi decisivi. Ciascun momento della sua vita artistica scaturiva da una necessità concreta, mai da un programma teorico. Watts rifiutò sempre l’idea di incarnare un’estetica astratta, vivendo la musica come un impegno quotidiano e una maniera di stare al mondo a testa alta.
La sua formazione si corroborò in solitudine. A Halifax non esistevano club jazz, comunità organizzate o maestri a cui rivolgersi. Come detto, però, in casa circolavano i dischi che il padre aveva portato dal Canada: Fats Waller, Nellie Lutcher, Tex Beneke, Duke Ellington. Quelle voci lontane gli spalancarono una finestra su un universo sconosciuto. In seguito arrivarono Charlie Parker, Stan Getz, Ernie Henry, Sonny Rollins, Shorty Rogers, quindi Cecil Taylor, Ornette Coleman e John Coltrane. Trevor Watts crebbe in un territorio in cui i dischi di Charlie Parker circolavano come mappe di un continente ancora da esplorare. Parker non gli fornì un modello da imitare, ma un’idea di velocità mentale, ossia la sensazione che il sax potesse piegare il tempo come un metallo caldo. Da lì passa a Stan Getz, che gli mostrò un’altra possibilità: la linea che scivola, la frase che sembra scolpita nell’aria con un gesto unico. Ernie Henry gli comunicò l’idea di un timbro più tagliente, una sorta di lama sottile che incide senza alzare la voce. Sonny Rollins gli consegnò un’altra combinazione segreta, grazie alla quale Trevor maturò la convinzione di poter trasformare un motivo in un essere vivente, capace di mutare progressivamente in tempo reale, come un ramo che continua a generare nuove direzioni. Shorty Rogers gli suggerì un tipo di scrittura atta a non soffocare l’improvvisazione, ma piuttosto a incanalarla come un corso d’acqua dentro un letto flessibile. Questa prima costellazione di jazzisti non stabilì un pantheon, ma innescò un campo magnetico proattivo. Dal canto suo il giovane Trevor non copiava nessuno, ma si spostava tra queste presenze ingombranti come un viaggiatore che attraversa regioni diverse e ne trattiene il clima, non la cartografia.
Una seconda ondata di influenze modificherà l’elettricità del suo pensiero. Cecil Taylor gli fece capire che il pianoforte poteva diventare una fucina di energia pura, un luogo in cui il suono non illustra un’idea ma la genera. Ornette Coleman gli instillò un’altra suggestione: la libertà non è assenza di regole, ma un patto tra musicisti che si ascoltano come se stessero camminando su una corda tesa. Coltrane, infine, lo contagiò una visione più ampia, legata alla possibilità che il sax potesse diventare un canale, un condotto attraverso cui passa qualcosa che non appartiene solo al musicista, ma a un’intera comunità sonora. Watts non mise questi nomi in fila, ma li portò con sé come strati geologici. I primi gli consegnarono la grammatica, i secondi gli diedero la spinta a superarla. Fu come attraversare due mari diversi, di cui il primo insegna a navigare, mentre il secondo indica che l’orizzonte può essere spostato. Il risultato non produsse una somma, ma un nucleo gravitazionale di forze instabili che continueranno a vibrare dentro la sua musica. Parker rappresentò la scintilla, Getz il respiro, Henry l’assertività, Rollins la costruzione, Rogers l’architettura elastica, Taylor il terremoto sotto i piedi, Coleman l’apertura e Coltrane la traiettoria verticale. Per intenderci, Trevor Watts non appartenne a nessuno di essi, ma senza di loro non avrebbe trovato il proprio passo. Egli ascoltava tutto senza gerarchie, come se ogni disco fosse un messaggio in bottiglia. Non frequentò scuole di musica, non ebbe accesso a percorsi accademici. A quindici anni abbandonò gli studi tentando di sottrarsi a un destino di lavori ripetitivi. La musica gli concesse un varco possibile, e il linguaggio jazzistico, con la sua libertà espressiva fondata su una costante richiesta d’identità, divenne la sua lingua.
L’ingresso di Trevor Watts nella scena londinese coincide con un periodo di intensa circolazione musicale, in cui artisti provenienti da ambiti diversi si ritrovavano a condividere palchi, prove e intuizioni: nei club poteva capitare di dividere lo stage con Sonny Boy Williamson. In questo ambiente maturò l’incontro con Long John Baldry, uomo di riferimento del blues britannico e catalizzatore di molte esperienze giovanili dell’epoca. Le formazioni di Baldry riunivano musicisti con provenienze differenti, e proprio questa varietà consentì a Watts di confrontarsi con modalità espressive che si discostavano dal jazz che aveva ascoltato in adolescenza. Le serate nei club, spesso affollate e imprevedibili, gli permisero di entrare in contatto con un modo di fare musica diretto, immediato e privo di sovrastrutture. Baldry aveva un approccio istintivo, capace di modificare l’andamento di un componimento in base all’energia del momento, e questa libertà colpì profondamente Trevor. Egli capì che nessuno gli avrebbe imposto limiti: se una frase si fosse estesa oltre le aspettative della partitura o se un intervento si fosse dilatato ad libitum, la musica avrebbe trovato comunque un suo equilibrio. Da quell’esperienza ricavò una consapevolezza destinata a restare, ossia la possibilità di intervenire nel flusso sonoro senza esitazioni, affidandosi alla propria sensibilità e alla capacità di cogliere ciò che accadeva intorno. Baldry non rappresentò un modello da imitare, ma un esempio concreto di come la pratica musicale potesse svilupparsi attraverso decisioni istantanee, relazioni impreviste e una disponibilità costante al rischio.
Una lezione che Watts fissò come una regola di vita: la libertà non si chiede, ma si esercita. Se Sonny Boy prolungava gli assoli senza vincoli, anche lui avrebbe potuto tranquillamente farlo, senza che nessuno potesse imporgli dei limiti. In questo clima venne alla luce lo Spontaneous Music Ensemble con John Stevens, un progetto che elaborò un proprio modus operandi indipendente dai modelli americani. L’incontro tra Trevor Watts, al sax alto e soprano, e John Stevens, impegnato su batteria e percussioni, si verificò in una fase nella quale la scena londinese stava sperimentando modalità improvvisative lontane dagli stilemi più diffusi del jazz moderno. I due sodali frequentavano gli stessi luoghi, gli stessi musicisti, gli stessi spazi di intermediazione culturale, tanto che da questa vicinanza prese forma l’idea di un laboratorio stabile dedicato all’ascolto reciproco e all’interazione istantanea. Nasceva così lo Spontaneous Music Ensemble, un collettivo in continua evoluzione, definito più dalla pratica quotidiana che da un programma estetico. Il rapporto tra Watts e Stevens si reggeva su una complementarità evidente. Stevens lavorava su interventi essenziali, su variazioni minime e su un controllo rigoroso dell’intensità. Watts portava una tensione melodica più ampia, una propensione a far emergere linee che si evolvevano con naturalezza, senza forzature. Tale differenza non generava distanza, ma ravvivava il dialogo. Stevens conformava un ambiente sonoro asciutto, fatto di gesti brevi e mirati; Trevor inseriva figure che si annodavano con quel tessuto, dando vita a una dinamica che non dipendeva da ruoli fissi ma da una costante attenzione all’altro. La loro collaborazione si reggeva su una pratica condivisa. Passavano ore a lavorare su esercizi che miravano a ridurre l’ego individuale, a lasciare spazio all’imprevisto ed a riconoscere il valore di un gesto minimo. Stevens insisteva sull’importanza di ascoltare prima di intervenire; Watts rispondeva con una sensibilità che gli permetteva di cogliere ogni sfumatura e di intersecarsi nell’ordito tematico con precisione. Le loro differenze stilistiche, invece di produrre attrito, generavano un equilibrio raro: uno spazio in cui la musica si sviluppava attraverso relazioni, intuizioni e decisioni istantanee. Lo Spontaneous Music Ensemble divenne così un punto di riferimento per una generazione di musicisti che mirava a un metodo differente di concepire l’improvvisazione. Non un repertorio, non una forma predefinita, ma un procedura basata sull’ascolto, sulla responsabilità collettiva, sull’attitudine a riconoscere l’idea nel momento in cui affiora. Il dialogo tra Watts e Stevens rappresentò una delle esperienze più significative della musica improvvisata europea, un incontro in cui differenze, affinità e sensibilità complementari si amalgamavano con una spontaneità che ancora oggi mantiene una vitalità sorprendente.

Nel 1971, Trevor Watts partecipo al Palermo Pop Festival con Julie Driscoll e lo SME. La platea si divise tra entusiasmo e ostilità, dal campo da calcio volò terra verso il palco, i sedute vennero spostate per consentire al gruppo di suonare. Watts non arretrò, trasformando il caos in energia condivisa. L’episodio sintetizza bene la sua attitudine: nessuna ricerca di compiacimento, solo fedeltà a ciò che accade in quel momento. Nel 1982, il sassofonista diede vita a «Moiré Music», un progetto che intrecciava musiche dell’Africa occidentale, improvvisazione europea, pulsazioni rituali e canto collettivo. L’ingresso nel progetto di Nana Tsiboe, percussionista ghanese attivo tra tamburi tradizionali, congas, kpanlogo e strumenti a corde come il seprewa, rappresentò per Trevor Watts un punto di svolta nella definizione del progetto. La loro collaborazione non si fondava su un’idea esotizzante dell’Africa, né su un’adesione acritica a modelli etnici, ma su un incontro concreto tra pratiche musicali differenti. Watts, al sax alto e soprano, non si avvicinava alle tradizioni dell’Africa occidentale con l’atteggiamento del collezionista o dell’etnomusicologo: entrava in quel mondo attraverso l’ascolto diretto, la relazione personale e la disponibilità a lasciarsi guidare da un’altra logica ritmica. L’approccio di Watts si distingueva nettamente da quello di molti jazzisti afro-americani che, negli stessi anni, recuperavano elementi africani come parte di un discorso identitario o politico. Per Watts, cresciuto in un contesto britannico privo di radici diasporiche, l’Africa non costituiva un ritorno simbolico, ma un territorio sonoro da abitare attraverso la pratica condivisa. La sua attenzione non si rivolgeva a un’idea astratta di «origine», ma alla vitalità dei gesti musicali, alla complessità dei cicli ritmici, alla possibilità di instaurare un dialogo paritario con musicisti portatori di tradizioni diverse. Nana Tsiboe colse immediatamente questa disposizione. Durante una sessione, un suo fraseggio suggerì a Watts che il brano stava per concludersi, quindi i due chiusero simultaneamente con una spontaneità che lasciò entrambi sorpresi. Tsiboe commentò: «È raro incontrare qualcuno che ascolta in questo modo.» In quella frase si riconosce l’essenza del loro rapporto, ossia un’interazione fondata sulla sensibilità reciproca, non sui ruoli prestabiliti. Con «Moiré Music» Trevor porto la sua musica in luoghi instabili: Bogotà durante l’insurrezione, la Birmania di Ne Win, Mandalay con la polizia segreta in sala. In Birmania un faro militare illuminava la sala nel momento di massima intensità sonora, mentre il gruppo rispose aumentando ancora l’energia. Al Mandalay eseguirono «Redemption Song» come atto di resistenza discreta. All’interno di «Moiré Music», la figura di Tsiboe non funzionava come elemento ornamentale o come richiamo a un immaginario terzomondista. La sua pratica ritmica ridefiniva l’intero assetto del gruppo, offrendo a Watts un terreno su cui sviluppare linee melodiche che si intrecciavano con i cicli percussivi senza sovrastarli. L’incontro tra i due generò un linguaggio che non apparteneva né alla tradizione jazzistica europea né a quella africana, ma a una zona intermedia in cui le differenze non venivano cancellate: venivano messe in relazione. Questa dimensione extra-occidentale non costituiva un gesto politico esplicito, ma una scelta estetica che implicava una forma di responsabilità. Trevor non adottava materiali africani per inserirli in un discorso personale, ma li accoglieva come parte di un processo collettivo, in cui ogni musicista contribuiva con la propria storia e la propria sensibilità. È in questo senso che la sua posizione si differenziò da molte operazioni coeve, non in virtù di un uso simbolico dell’Africa, ma sulla scorta di una pratica comunitaria che affiorava dall’incontro quotidiano con Tsiboe e con gli altri membri della compagine.
Watts amava da sempre gli incroci inattesi. Con Liam Genockey e Peter Knight implementò un linguaggio che non assomigliava a nulla di preesistente. Knight, che anni prima aveva liquidato quella musica come «spazzatura autoindulgente», divenne un compagno di viaggio. Quando Trevor coinvolse Liam Genockey (batteria, percussioni) e Peter Knight (violino, mandola, strumenti elettrificati), «Moiré Music» stava attraversando una fase di ampliamento, segnata dall’ingresso di musicisti provenienti dall’area folk-rock britannica. Genockey e Knight portavano con sé un’esperienza maturata in contesti nei quali tradizioni popolari, elettrificazione e pratiche improvvisative convivevano con naturalezza. Tali elementi introdussero nel progetto una dimensione timbrica e ritmica distante sia dal jazz europeo che dalle musiche dell’Africa occidentale già presenti nel gruppo. Watts, al sax alto e soprano, trovò in Genockey un partner versatile nel sostenere concezioni ritmiche articolate senza irrigidirle. La sua batteria imbastiva un tessuto mobile, ricco di incastri, che dialogava con le percussioni di Nana Tsiboe e con le linee di Watts, generando un habitat espressivo in perenne mutazione. Knight, con il violino e la mandola, aggiungeva una componente melodica che non apparteneva a nessuna delle tradizioni già attive nell’ensemble: un arco in grado di passare da figure essenziali a trame più estese, sempre attento a ciò che accadeva nel gruppo. L’incontro tra queste provenienze – jazz britannico, tradizioni africane, folk-rock elettrificato – non si coagulò in un amalgama uniforme. Infatti, ciascun musicista mantenne una sua identità, e proprio questa distinzione alimentò la vitalità dell’ensemble. Watts non impose un modello, ma invitò Genockey e Knight a portare la loro esperienza dentro una sorta di opificio aperto, in cui la pratica collettiva orientava le scelte musicali. Sul piano discografico, questa fase trovò espressione in diverse formazioni legate a «Moiré Music», tra cui «Moiré Music Drum Orchestra», dove la presenza di Genockey e Knight contribuì a un suono più ampio, caratterizzato da una forte componente ritmica e da un intreccio costante tra strumenti a corda, percussioni e sax. Le registrazioni di quel periodo esprimevano un melting pot sonoro che si sviluppava attraverso cicli sovrapposti, figure che si espandevano con naturalezza e interventi che emergevano senza ruoli gerarchici. L’apporto di Genockey e Knight non costituì un episodio isolato, ma un passaggio determinante sulla successiva traiettoria evolutiva di Watts. La loro presenza consolidò un’idea di ensemble come organismo plurale, in cui la diversità delle provenienze diventava una risorsa capace di far germogliare inattese configurazioni sonore. Tale apertura rimase una costante nella produzione di Watts, che seguitò a collaborare con musicisti provenienti da ambiti differenti, mantenendo viva una pratica fondata sulla relazione e sull’ascolto reciproco.
Con Eternal Triangle, il sassofonista continuò a reinventarsi. Il trio con Weston e Harris non ripropose in chiave nostalgica l’esperienza di «Moiré Music», ma inaugurò un nuovo capitolo. «Eternal Triangle» fece i primi vagiti all’inizio degli anni Ottanta, in un periodo in cui Trevor Watts stava ridefinendo il proprio lavoro in piccoli organici dopo le esperienze più ampie di «Moiré Music». L’idea prese forma durante una serie di sessioni informali a Londra, in spazi che Watts frequentava abitualmente per lavorare su materiali nuovi insieme a musicisti con cui condivideva una lunga frequentazione. In quel contesto maturò la decisione di forgiare un trio stabile, fondato sulla compliance tra rigore e apertura, capace di sostenere una musica priva di ruoli gerarchici. Il nucleo del progetto si consolidò attorno a Trevor Watts (sax alto e soprano), Liam Genockey (batteria, percussioni) e Colin McKenzie (contrabbasso). I tre avevano collaborato in situazioni diverse, ma non avevano ancora lavorato in una formazione così essenziale. Fu proprio l’organico ridotto che permise loro di scandagliare una dimensione più asciutta rispetto alle grandi formazioni degli anni precedenti. Watts trovò in Genockey un partner abile nel calibrare l’intensità con precisione, mentre McKenzie forniva un ancoraggio elastico, in grado di sostenere e allo stesso tempo di spingere il costrutto sonoro verso direzioni inattese. Le prime prove si svolsero in piccoli studi londinesi, spesso in orari irregolari, quando gli spazi erano liberi e il trio poteva lavorare senza interruzioni. Da quelle sessioni affiorò un linguaggio che univa la tensione melodica di Watts, la mobilità ritmica di Genockey e la solidità di McKenzie. Il nome «Eternal Triangle» alludeva alla stabilità della formazione e alla possibilità di generare una musica che potesse rinnovarsi costantemente pur mantenendo una impalcatura essenziale. Il trio trovò presto una propria identità anche sul piano discografico. Le registrazioni realizzate in quel periodo documentano una musica che si sviluppava attraverso linee sovrapposte, interventi che si intrecciavano con naturalezza e una costante attenzione all’ascolto reciproco. «Eternal Triangle» divenne così uno dei progetti più rappresentativi della maturità di Watts, capace di unire esperienza, disciplina e una forte propensione all’improvvisazione collettiva.
Alla sua veneranda età, il sassofonista ha dichiarato più volte di sentirsi poco considerato nel suo paese, senza trasformare mai questa percezione in risentimento. Per lui la musica non coincide con un mestiere da promuovere, ma con un’analisi e una sperimentazione che taglia l’intera esistenza. Trevor non punta agli applausi, ma desidera comprensione, cercando, come afferma, «alla massima chiarezza possibile» della propria musica, sentendosi irrequieto ed animato da un perenne dinamismo interiore che non gli ha permesso di ripetersi. Trevor si caratterizza come un artista che continua a sondare inedite combinazioni, valutare nuovi compagni di cordata e cercare luoghi inesplorati, incarnando la figura di musicista che ha fatto dell’ascolto un’etica e della curiosità la propria guida. Alcuni passaggi fondamentali della sua discografia consentono di avere una visione alquanto nitida ed esaustiva del processo evolutivo del sassofonista inglese.
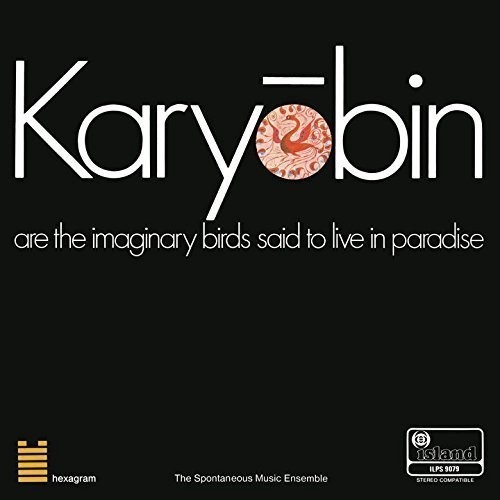
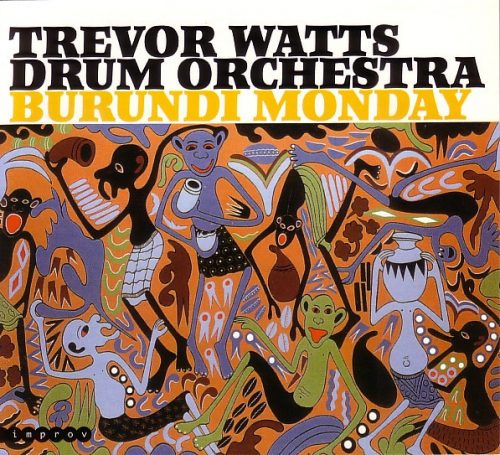
«KARYOBIN» (SPONTANEOUS MUSIC ENSEMBLE, 1968)
«Karyobin» venne registrato nel febbraio 1968 ai Lansdowne Studios di Londra, in un periodo in cui lo Spontaneous Music Ensemble stava definendo un linguaggio che non aveva equivalenti né in Europa né negli Stati Uniti. Il gruppo riuniva Trevor Watts al sax alto, Evan Parker al sax soprano, Derek Bailey alla chitarra, Barry Guy al contrabbasso e John Stevens alla batteria. Non si trattava di una formazione di tipo tradizionale, ma era un opificio relazionale, in cui ogni prassi procedurale veniva valutata in riferimento agli altri, senza ruoli fissi e senza gerarchie.
Si parte dalla title-track, «Karyobin», in cui il flusso tematico non si srotola per esposizione tematica, ma attraverso micro-eventi che si dispongono nello spazio come particelle autonome. Watts interviene con frammenti brevi, spesso collocati ai margini del tessuto sonoro, mentre Stevens lavora su un set ridotto, limitando il materiale percussivo a colpi secchi, sfregamenti e accenti isolati. L’armonia non risulta assente, ma è implicita nelle relazioni tra i timbri, nelle distanze tra gli attacchi e nella tensione che si sviluppa quando Parker e Watts si avvicinano senza sovrapporsi. Questa sezione funziona come un campo di forze, non come un impianto strutturale. «For You To Share» dispensa una dinamica più rarefatta. Bailey elabora interventi puntiformi, quasi privi di attacco, che modificano la percezione del tempo. Trevor ribatte con un controllo timbrico rigoroso: non espone linee, ma scolpisce il suono, modulando l’aria e la pressione dell’ancia. L’armonia nasce dalle sovrapposizioni casuali, dalle risonanze interne del contrabbasso di Guy e dai silenzi che separano un movimento dall’altro. L’interscambio tra i musicisti diventa più evidente, al punto che ognuno ascolta non ciò che l’altro fa, ma ciò che potrebbe fare, e questa sospensione genera una tensione costante. In «Plus Equals» il gruppo adotta un registro più opulento. Guy libera figure che non hanno funzione di sostegno, ma di deviazione, dove ogni arco modifica la direzione del flusso. Watts e Parker annodano linee che non convergono mai, mantenendo una distanza che diviene un elemento strutturale. Stevens lavora su una pulsazione irregolare, fatta di accenti che non si ripetono, e questo impedisce alla musica di stabilizzarsi. L’armonia rimane mobile, instabile, nonché costruita su intervalli che emergono e scompaiono senza lasciare tracce. «Checkpoint Charlie» sancisce il momento più equilibrato del concept, dove il gruppo raggiunge una tipologia di trasparenza che permette di percepire ogni gesto nella sua singolarità. Watts distribuisce figure che sembrano nascere dal silenzio, mentre Bailey lavora su armonici che ampliano lo spettro timbrico. Stevens orienta la struttura con gesti minimi, spesso al limite dell’udibile. La relazione tra i musicisti assume un carattere quasi cameristico , in cui non si avverte conflitto, ma una costante ridefinizione dell’habitat espressivo. L’album si chiude con «Little Red Head», la sezione più mobile. Il dialogo tra sax e chitarra assume una forma più diretta, senza perdere la delicatezza che caratterizza l’intero tragitto. Guy introduce un movimento più deciso, mentre Stevens aumenta la densità degli interventi. Watts mette in luce una capacità rara, ossia quella di entrare e uscire dal tessuto sonoro senza alterarne l’equilibrio. Questo modulo funziona come una sintesi dell’intero progetto, sorretto da un equilibrio fragile tra gesto e ascolto, tra presenza e ritiro.
«Karyobin» rimane un documento fondamentale non perché rappresenti un’epoca, ma poiché mostra come cinque musicisti possano sviluppare un linguaggio basato sulla responsabilità reciproca. Ogni sezione si sostanzia come un mondo autonomo, e ciascuna relazione implicita modifica la percezione dell’insieme. Siamo alle prese con disco che non si esaurisce, ma continua a produrre senso ogni volta che lo si riascolta.
«DRUM ORCHESTRA» (TREVOR WATTS, 1982)
«Drum Orchestra» nasce da un incontro in cui il ritmo non è un fondamento, ma una corrente che attraversa i musicisti come un fiume sotterraneo. Trevor Watts, al sax alto e soprano, penetra in un ambiente in cui la pulsazione non procede in linea retta, ma si delinea come una rete di sentieri che s’incrociano, si allontanano e si ritrovano. Nana Tsiboe porta con sé tamburi dell’Africa occidentale, voce e strumenti a corde; Frank Perry aggiunge percussioni che sembrano provenire da un’altra latitudine; gli altri membri dell’ensemble contribuiscono con timbri che si avvicinano senza mai confondersi. La musica non si appoggia a un centro tonale, si espande come un cerchio d’acqua che continua a generare onde.
L’opener, «Drum Dance», mette subito in evidenza suddetta procedura. Tsiboe intesse una trama di colpi che non puntano alla simmetria, dove ogni gesto apre un varco e ciascun accento sposta l’orizzonte. Watts entra come una voce che taglia un paesaggio in movimento, in cui il sax non guida, ma si lascia trasportare, come un nastro di fumo che cambia direzione a seconda delle correnti. Perry interviene con percussioni che non aggiungono peso, ma profondità, come se scavassero piccole cavità nel terreno sonoro. L’armonia non deriva dagli accordi, piuttosto nasce dall’incastro dei timbri e dalle risonanze che emergono quando il sax sfiora la tessitura ritmica. Con «Forest Patterns» la musica prende un respiro più ampio. Le percussioni si dispongono come alberi in una radura, in cui non seguono un ordine, ma ossigenano un ambiente in cui ogni suono trova il proprio spazio. Watts lavora su percorsi che si allungano come rami, mentre Tsiboe porta voce e strumenti a corde che ampliano la gamma espressiva dell’ensemble. L’ordito sonoro non procede, ma cresce. Si percepisce la sensazione di osservare un bosco che si espande lentamente, senza fretta, lasciando che qualunque elemento trovi la propria collocazione. «Night Signals» porta il il line-up in una zona più raccolta. Le percussioni si assottigliano, come se la notte avesse assorbito parte del loro peso. Watts interviene con un fraseggio che non cerca densità: lascia affiorare frammenti che sembrano lucciole in un campo scuro. Gli strumenti a corde africani rispondono con un timbro che non sostiene né contrasta, ma illumina. L’intreccio motivico assume una qualità quasi notturna, come se ogni gesto fosse un segnale lanciato da un punto lontano. In conclusione, «Circle Motion», riporta l’ensemble a un’energia più assertiva. Le percussioni tornano a occupare lo spazio con maggiore decisione, ma senza perdere la flessibilità che caratterizza l’intero progetto. Watts modula l’intensità con una precisione che gli permette di innervare il paesaggio sonoro come una corrente d’aria che cambia direzione senza spezzarsi. La musica si staglia come una spirale che non chiude mai il proprio giro, continuando a espandersi, a generare nuove traiettorie e a suggerire percorsi che rimangono aperti.
«Drum Orchestra» non appartiene a una tradizione precisa: vive in un territorio in cui ritmo, voce e movimento si avvicinano senza annullarsi. Ciascuna parte del concept evidenzia una diversa modalità di relazione: espansione, sospensione, introspezione e ampiezza. Siamo alle prese con un lavoro che non cerca formule, ma si affida a un linguaggio che nasce dall’incontro tra sensibilità diverse, come un tessuto in cui ogni filo mantiene la propria identità pur contribuendo al disegno complessivo, tanto da esprimere un aspetto fondamentale della poetica di Watts: la capacità di trasformare il ritmo in un luogo di dialogo, non in una struttura da seguire


«MOIRÉ MUSIC» (TREVOR WATTS, 1985)
Nel momento in cui «Moiré Music» prese corpo, l’impressione dominante fu quella di un ensemble che ansimava come un unico corpo. Non c’era un centro da cui tutto partiva, ma la musica sembrava emergere da un crogiolo di energie già attive, come se ogni musicista avesse portato con sé un frammento di mondo pronto a incontrarne altri. Trevor Watts, al sax alto e soprano, si trovò immerso in un ambiente sonoro che non assomigliava a nessuna delle sue esperienze precedenti. Nana Tsiboe apportava un sistema ritmico stratificato, fatto di tamburi dell’Africa occidentale, voce e strumenti a corde; Liam Genockey trattava la batteria con una flessibilità che sfuggiva a ogni schema; Peter Knight, con violino e mandola, aggiungeva una trama melodica che dava l’idea di provenire da un’altra geografia; Colin McKenzie forniva un sostegno mobile, capace di orientare il flusso senza irrigidirlo.
L’opener, «Moiré One», si conforma come un mosaico in movimento, dove le percussioni non cercano un ciclo riconoscibile, ma un ingranaggio che si allarga e si restringe con naturalezza. Tsiboe e Genockey costruiscono un terreno instabile, vivo, in cui ogni colpo modifica la percezione del tempo. Trevor s’introduce senza forzare, lasciando che la progressione si formi mentre attraversa il tessuto ritmico; il sax non guida, ma osserva, ascolta e si adatta. Knight interviene con un violino che non cerca un ruolo melodico tradizionale, per contro le sue figure sembrano collegare zone lontane del suono, come se aprissero passaggi interni all’ensemble. McKenzie sostiene tutto con un basso che non delimita, ma orienta, offrendo un punto d’appoggio che rimane sempre in movimento. Con «Moiré Two» l’impianto tematico assume un carattere più disteso. Le percussioni si aprono, lasciando varchi più ampi in cui sax e violino possono dialogare senza urgenza. Watts lavora su intervalli più larghi, come se volesse esplorare la distanza tra un gesto e l’altro; Knight risponde con una progressione inquieta che non completa la procedura, ma si affianca ai sodali, delineando una seconda prospettiva. McKenzie libera un movimento che accompagna senza ingabbiare il percorso, mentre Tsiboe aggiunge voce e piccoli strumenti che ampliano l’aura fonica senza alterare l’equilibrio. Qui l’armonia non deriva da progressioni, piuttosto punta sulle risonanze interne, i vuoti e le sovrapposizioni che si formano quando i timbri si sfiorano.
«Moiré Three» porta il convoglio in una zona più sospesa. Le percussioni si diradano, lasciando emergere un dialogo più intimo tra sax, violino e basso. Watts non mira all’opulenza, ma lavora su frammenti brevi, come se ogni intervento fosse un modo per ascoltare meglio ciò che accade intorno. Knight distilla armonici che dilatano lo spettro sonoro, mentre McKenzie implementa un sostegno che non impacchetta un itinerario ideale, ma una remota possibilità. L’intreccio tematico sembra reggersi su un filo sottile, in cui qualunque gesto ha il peso di una decisione. In chiusura, «Moiré Four», consente all’ensemble di esprimere una maggiore assertività. Le percussioni tornano a occupare lo spazio con maggiore decisione, ma senza perdere la flessibilità che caratterizza l’intero progetto. Watts modula l’intensità con una precisione che gli consente di indirizzare il flusso senza imporre un centro, tanto che il sax attraversa un paesaggio in continuo mutamento, mentre Knight pennella figure che allargano ulteriormente la gamma espressiva dell’ensemble. L’ordito tematico si ingrossa come un organismo che cresce dall’interno, senza coercizioni, ruoli fissi o gerarchie. «Moiré Music» vive in un territorio in cui differenze culturali, pratiche strumentali e sensibilità individuali si intersezionano senza annullarsi. È un disco che non appartiene a una tradizione precisa, ma che definisce la propria identità attraverso relazioni multietniche, intrecci semantici e fenomeni di inculturazione, seguitando così a produrre interesse e curiosità, poiché non si appoggia a formule prevedibili o codificate, ma è piuttosto il frutto di un sodalizio allargato e un di linguaggio in perenne mutazione.
«ETERNAL TRIANGLE» (TREVOR WATTS, 1984–85)
«Eternal Triangle» nacque in un periodo nel quale Trevor Watts stava lavorando su un organico essenziale, ridotto a sax, contrabbasso e batteria. Questa scelta non comportò un impoverimento del materiale, ma un ampliamento dello spazio intrinseco, dove ogni gesto acquistava un peso diverso e ciascun intervento modificava la direzione del gruppo. Watts, al sax alto e soprano, trovò in questa formazione una libertà che non dipendeva dall’assenza di altri strumenti, ma dalla possibilità di muoversi in un ambiente in cui ogni suono veniva percepito nella sua interezza. Colin McKenzie, al contrabbasso, offriva un sostegno elastico, capace di indirizzare il discorso senza irrigidirlo; Liam Genockey, alla batteria, modellava il tempo con una mobilità che sfuggiva a ogni schema ritmico prevedibile.
L’opener, «First Triangle», sancisce subito la logica interna del trio. McKenzie innesca un battito che non cerca un centro nevralgico, ma si dirama per deviazioni, piccoli slittamenti ed accenti che aprono varchi inattesi. Watts entra con una procedura che non impone direzioni, ma osserva il terreno, lo misura, lo solca con un fraseggio che alterna opulenza e sottrazione. Il kit percussivo di Genockey interviene non sostiene né spinge, ma sembrerebbe commentare e suggerisce un percorso alternativo, al fine di modificare la percezione del tempo attraverso colpi isolati, rimbalzi e sfumature che ampliano l’aura fonica. L’armonia non deriva dalle progressioni, ma dalle distanze fra i tre e da ciò che rimane sospeso. Con «Second Triangle» la musica assume un carattere più disteso. McKenzie distribuisce un dinamismo più ampio, quasi circolare, che permette al sax di involarsi con maggiore libertà. Watts opera su intervalli larghi, come se volesse sondare la distanza tra un gesto e l’altro, mentre Genockey implementa un ambiente ritmico che non definisce un percorso, ma una possibilità. Il trio mostra una qualità rara: la capacità di mantenere una tensione costante senza ricorrere ad accumuli o velocità. Ogni intervento sembra nascere da un ascolto profondo e dalla consapevolezza condivisa del ruolo di ciascuno. «Third Triangle» spinge il triunvirato in una zona più introspettiva. McKenzie riduce il materiale, lavorando su note singole che emergono come punti di riferimento in un paesaggio più rarefatto. Watts risponde con un fraseggio che non cerca continuità, ma che lascia affiorare frammenti, respiri, figure contenute che sembrano nascere dal silenzio. Genockey interviene con una batteria che si colloca al limite dell’udibile, come se ogni colpo fosse un modo per misurare la distanza fra i tre. La musica si muove su un filo sottile, in cui ogni gesto ha il peso di una decisione. La conclusione, «Fourth Triangle», riporta il trio a un’energia più ampia. McKenzie introduce un movimento più deciso, mentre Genockey aumenta la densità degli interventi senza perdere la flessibilità che caratterizza l’intero progetto. Watts modula l’intensità con una precisione che gli permette di orientare il flusso senza imporre un centro. Il sax attraversa un paesaggio in continuo mutamento, mentre contrabbasso e batteria concimano un terreno che si espande e si restringe con naturalezza. La musica procede come un organismo che cresce dall’interno, senza forzature, senza ruoli fissi e senza gerarchie.
«Eternal Triangle» mostra un modo di intendere il trio che non si basa sulla riduzione, ma sull’ampliamento dello spazio interno. Ciascuna parte del disco rivela una diversa modalità di relazione, ossia densità, sospensione, introspezione ed espansione. È un lavoro che continua a produrre senso perché non si appoggia a formule, ma si evolve attraverso ascolto reciproco, intuizioni, responsabilità condivisa. E rivela un aspetto fondamentale della poetica di Watts: la capacità di trasformare un organico essenziale in un laboratorio di possibilità.
«6 DIALOGUES» (TREVOR WATTS & VERYAN WESTON, 2002)
«6 Dialogues» è il frutto di un incontro a due in cui il pianoforte di Veryan Weston e il sax di Trevor Watts non cercano un equilibrio prestabilito: lo costruiscono mentre avanzano, come due camminatori che procedono su un terreno che si forma sotto i loro passi. Non esiste un ruolo dominante, non c’è un’idea di guida: ogni gesto modifica la direzione dell’altro, e ciascun suono apre un varco che prima non esisteva. Il duo lavora con una concentrazione che non ha nulla di ascetico. Siamo alle prese con una forma di attenzione condivisa, simile a quella di due artigiani che modellano la stessa materia da lati opposti del banco.
Il primo episodio, «Unrest Assured», attiene proprio a questa logica. Weston non stabilisce un’armonia di riferimento, ma dispone accordi come pietre in un giardino, lasciando che il sax scelga il percorso. Watts entra con un timbro che non cerca di imporsi, ma di misurare la distanza tra le note del pianoforte. La musica si muove come un filo teso tra due mani, dove ogni battito produce una vibrazione diversa, ogni deviazione apre una nuova possibilità. Non esiste un tema, non si percepisce un impianto accordale da seguire, ma c’è un terreno che si costruisce mentre viene attraversato. Nel secondo movimento, «Split Frequencies», il duo adotta un passo più ampio. Weston dispensa figure che non cercano continuità, ma una sorta di geometria mobile, come se ogni accordo fosse un oggetto che ruota su se stesso. Watts ribatte con progressioni che non completano il discorso del pianoforte, ma lo inclinano, lo spostano e lo osservano da un’altra angolazione. L’ordito sonoro assume una qualità quasi tattile, al punto che sembra di vedere le superfici che i due modellano, come se stessero lavorando l’argilla con strumenti diversi. Il terzo dialogo, «Rest Unassured», porta il disco in una zona più rarefatta. Weston riduce il materiale a poche note, lasciate cadere come gocce su una superficie liscia. Watts interviene con un fraseggio che non punta alla densità, ma lascia affiorare frammenti, respiri e figure brevi che sembrerebbero emergere dal silenzio, mentre la musica non procede, ma affiora. È come osservare un paesaggio all’alba, quando i contorni non sono ancora definiti e ogni dettaglio appare più grande di quanto sia.
Il quarto episodio, «Finding & Binding», innesca un’energia più mobile. Weston lavora su registri diversi, come se volesse aprire più stanze nello stesso edificio; Watts attraversa queste stanze con una linea che cambia consistenza a seconda dello spazio in cui si trova. La musica si distribuisce con una qualità quasi narrativa. Sebbene non racconti una storia, prova a suggerisce un percorso, come una mappa disegnata a mano in cui ogni tratto indica una direzione possibile. Nel quinto movimento, «Blending & Bending», il duo raggiunge una forma di equilibrio che non ha nulla di statico. Weston dispone accordi che sembrano sospesi a mezz’aria, mentre Watts interviene con un timbro che si assottiglia, si espande e si ritrae. L’asse tematico si manifesta come una fiamma che cambia forma senza spegnersi: non c’è un centro, ma una serie di punti che si illuminano a vicenda. La conclusione, «Spacing & Placing», riassume l’intero percorso senza chiuderlo. Weston libera una figura che sembra un invito, non una sintesi; Watts risponde con una procedura che non cerca di concludere il discorso, ma di lasciare aperto ciò che è stato costruito, mentre il suono si dissolve come una traccia sulla sabbia: non scompare, ma rimane nella memoria come un gesto che continua a produrre senso. «6 Dialogues» sancisce un modo di intendere il duo non basato sulla complementarità, ma sulla co-creazione. Ogni parte del disco rivela una diversa modalità di relazione, ossia esplorazione, sospensione, inclinazione ed apertura. Siamo di fronte a un lavoro che non cerca effetti speciali, non punta alla spettacolarità, ma imbastisce un linguaggio che nasce dalla responsabilità reciproca, dall’abilità di ascoltare ciò che ancora non è stato detto, portando in auge un aspetto fondamentale della poetica di Watts, ossia il desiderio di fare di qualsiasi incontro un laboratorio permanente di possibilità.