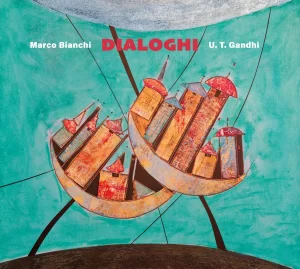Intervista inedita a Dexter Gordon. Anno 1988

Dexter Gordon
«Il tenore mi ha permesso di allargare le frasi, di farle scorrere come piccoli racconti. Non cercavo di imitare nessuno, cercavo un modo per far convivere ritmo e canto, per dare allo strumento una voce che avesse un carattere preciso».
// di Francesco Cataldo Verrina //
Dexter Gordon è stato un personaggio «enorme» sotto tutti gli aspetti, non solo per l’imponenza della sua corporatura. È storicamente provato che ebbe un’acclarata influenza sullo sviluppo del sassofono tenore, riuscendo ad essere un punto di confluenza tra Lester Young e Coleman Hawkins. Sonny Rollins e John Coltrane ne subirono inizialmente il fascino. Già adolescente, si distinse per una padronanza tecnica fuori dal comune e per una sensibilità interpretativa che lo portò, a soli diciassette anni, ad entrare nell’orchestra di Lionel Hampton. In quel contesto, ricevette il soprannome «Society Red», allusione ironica al suo stile elegante e alla sua capigliatura stirata, in sintonia con i codici estetici della gioventù nera urbana degli anni Quaranta. Negli ultimi anni della sua carriera dimostrò di essere anche un valido attore: nel 1986 fu il protagonista del film di Bertrand Tavernier «Round Midnight». La ricetta di Gordon conteneva ingredienti dichiarati, che nascevano dalle invenzioni di Lester Young e dalla profondità armonica di Coleman Hawkins, impastate con la genialità di Charlie Parker, ovviamente Dexter aggiunse il proprio lievito creativo, ispirando una nuova generazione di sassofonisti. Era il 1988, quando per un circuito radiofonico lo intervistammo insieme a Irma Sanders che, nello sbobinare il vecchio nastro, ha fatto come al solito una piccola opera d’arte, adattando i contenuti alla scrittura senza alterarne il senso.
D Vorrei partire dalla tua formazione. In che modo l’ambiente familiare di Los Angeles ha orientato il tuo primo contatto con la musica?
R Sono cresciuto in una casa dove la musica entrava senza cerimonie. Mio padre curava persone come Duke Ellington e Lionel Hampton, e io li vedevo arrivare con una semplicità che mi colpiva. Non avevo bisogno di immaginare un mondo lontano, perché quel mondo era già lì, davanti a me. Quando Hampton mi chiamò nella sua orchestra avevo diciassette anni, ma dentro sentivo già una direzione. Il soprannome «Society Red» nacque in quei giorni, tra prove, risate e serate in cui cercavo di capire chi fossi. Quel nome mi aiutò a riconoscermi e a capire come volevo stare sulla scena.
D Il passaggio dallo swing al bebop ha rappresentato un momento decisivo della tua crescita artistica. Che cosa hai percepito in quel cambiamento?
R Il bebop mi ha aperto un orizzonte nuovo. Con Parker, Gillespie, Powell e Navarro mi sono trovato dentro un linguaggio che chiedeva attenzione e ascolto. Il tenore mi ha permesso di allargare le frasi, di farle scorrere come piccoli racconti. Non cercavo di imitare nessuno, cercavo un modo per far convivere ritmo e canto, per dare allo strumento una voce che avesse un carattere preciso.
D Gli anni Cinquanta coincidono con una fase complessa della tua vita. Che segno ha lasciato quel periodo nella tua musica?
R Sono stati anni difficili. Le dipendenze, le detenzioni e le assenze. Non voglio addolcirli. Ogni volta che entravo in studio sentivo però che la musica poteva ancora sostenere tutto. Non ambivo alla confessione, puntavo verso una linea che avesse senso. Anche nei momenti più fragili riuscivo a individuare un punto da cui ripartire, e quel punto finiva sempre dentro una frase o dentro un suono.
D Il trasferimento in Europa nel 1962 apre un nuovo capitolo. Che cosa hai trovato tra Parigi e Copenaghen?
R Quando arrivai in Europa mi resi conto subito che il clima umano era diverso. Le persone mi accoglievano con una curiosità sincera. A Parigi trovai spazio per capire meglio chi ero diventato. A Copenaghen incontrai una continuità che mi mancava da tempo. Ogni concerto diventava un’occasione per mettere ordine nel mio suono. Mi esibivo con musicisti europei e americani, e ognuno portava un accento diverso. Barney Wilen, Bent Jædig, Jesper Thilo: con loro non cercavo allievi, ma intavolavo conversazioni. In quegli anni non ho inseguito un modello, ma un luogo in cui potermi riconoscere.
D Vorrei soffermarmi su «Go!». Che cosa ti ha guidato in quella sessione del 1962 al Van Gelder Studio?
R Quando registrai «Go!» mi sentii subito a mio agio. Con Sonny Clark, Butch Warren e Billy Higgins bastava un cenno per capirci. «Cheese Cake» venne fuori con naturalezza, come se l’avessimo suonata insieme da sempre. In quel periodo il mio fraseggio si stava allargando, cercava una linea più distesa. Quel disco scorre come una storia breve, costruita senza forzature.
D L’anno successivo hai registrato «Our Man in Paris». Che cosa è emerso da quell’incontro con Bud Powell, Kenny Clarke e Pierre Michelot?
R Parigi mi aveva cambiato. Con Bud e Kenny ritrovai un pezzo della mia storia, ma in un luogo che mi permetteva di guardarla da lontano. Gli standard non erano più routine, diventavano materia viva. «A Night in Tunisia» prese una forma che non avevo previsto. Il mio suono si fece più largo, più pieno, come se la città stessa mi avesse dato un colore nuovo. L’intero disco porta dentro quella distanza e quella libertà.
D Nel 1964 hai realizzato «One Flight Up». A che cosa miravi con quel disco?
R «One Flight Up» fu un passo avanti. «Tanya» si aprì come un viaggio lungo, senza fretta. Il gruppo respirava insieme, e io mi lasciavo portare. Non cercavo di guidare tutto, miravo a un equilibrio. L’armonia si muoveva come un paesaggio che cambia lentamente, e io mi inserivo senza forzare. Quel disco rappresenta il momento in cui ho capito che lasciando più spazio agli altri, potevo avere più possibilità me.
D «Dexter Calling…» rivela una versatilità spesso sottovalutata. Che cosa rappresenta per te quel lavoro?
R Quando ho inciso «Dexter Calling…» volevo costruire melodie pulite, senza fronzoli. «Soul Sister» e «Ernie’s Tune» sono nate così, da un’idea semplice che cresceva da sola. La sezione ritmica ha dato al disco una solidità che mi ha permesso di modellare ogni frase con chiarezza. Cercavo una forma breve che potesse contenere un mondo intero, senza bisogno di complicazioni.
D Il ritorno negli Stati Uniti culmina con «Homecoming: Live at the Village Vanguard». Che cosa ha significato per te quel rientro?
R Tornare al Vanguard dopo tanti anni fu come rientrare in una stanza che conoscevo bene, ma che non vedevo da tempo. Con Woody Shaw, Ronnie Mathews, Stafford James e Louis Hayes ritrovai un’energia che avevo lasciato in sospeso. Il disco porta dentro tutto questo: memoria, dignità, presenza. Il pubblico non fu un contorno, fu parte del suono. Quell’album per me ha rappresenta un ritorno, ma anche un nuovo inizio.
D La tua presenza nel film «Round Midnight – A mezzanotte circa» introduce un’altra dimensione della tua arte. Che cosa ti ha dato il set cinematografico?
R Sul set non ho recitato, ho vissuto. Quel personaggio aveva molto di me, e io non ho dovuto inventare nulla. Ciascuna pausa, ogni sguardo, qualunque frase veniva da anni di musica e di vita. La candidatura all’Oscar fu una sorpresa, ma non la vissi come un premio al cinema. La sentii come un riconoscimento alla mia musica e al mio modo di stare nel mondo.
D Guardando il tuo percorso, quale eredità desideri che continui a vibrare nelle generazioni successive?
R Vorrei che la mia voce strumentale restasse una presenza, non un ricordo. I dischi, i concerti, il film: tutto quello che lascerò è nato da un bisogno di raccontare. Se qualcuno, ascoltandomi, troverà una direzione o una domanda nuova, allora vuol dire che la mia storia continuerà.