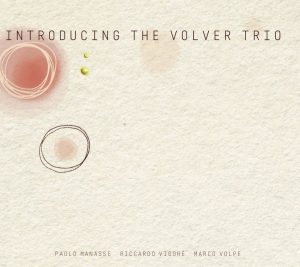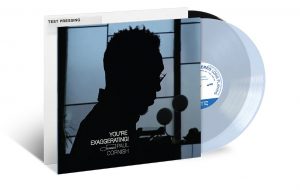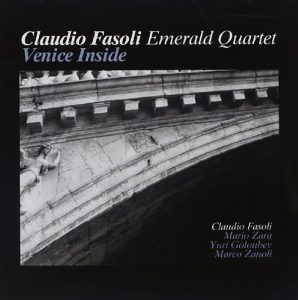Claudio Fasoli Emerald Quartet con «Venice Inside», la magia e la malinconia della città lagunare (Blue Serge, 2009)
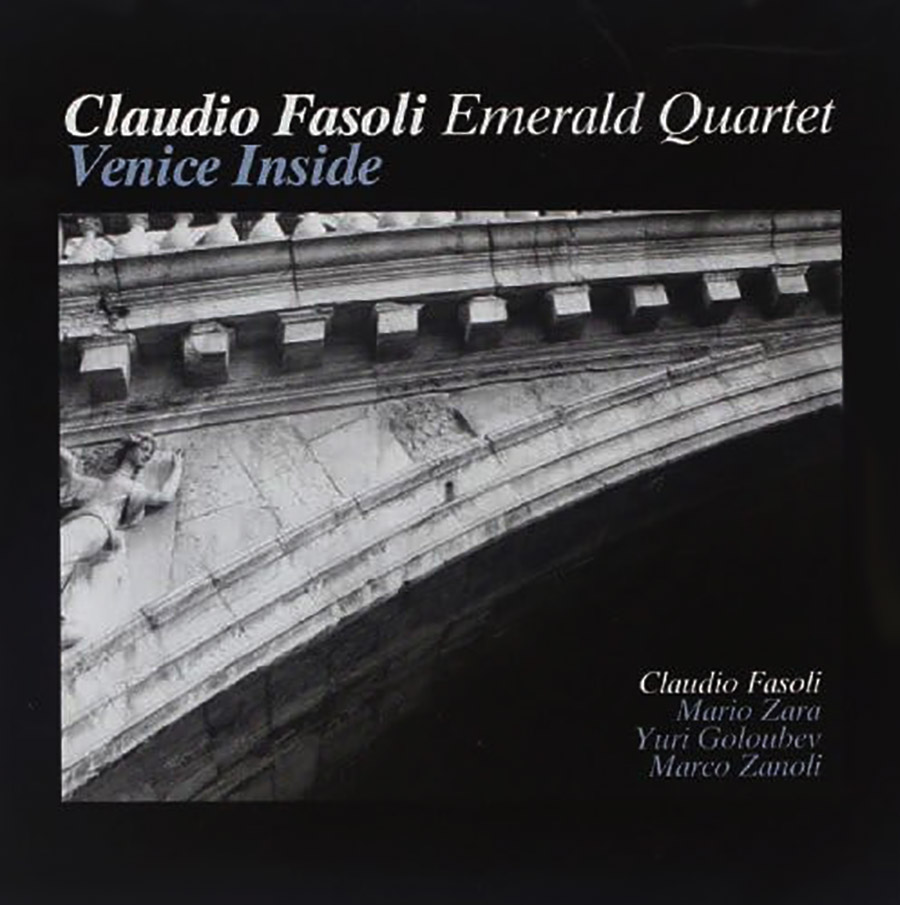
«Venice Inside» si colloca nel tracciato di una scrittura musicale che perlustra e rielabora. Le suggestioni pittoriche di Canaletto e Bellini, le atmosfere letterarie di Thomas Mann, le inquietudini cinematografiche di Roeg e Antonioni, tutto concorre a costruire un universo sonoro che reinventa la citta lagunare, la trasfigura e la interroga.
// di Francesco Cataldo Verrina //
«Venice Inside», album di Claudio Fasoli con il supporto con l’Emerald Quartet, formazione che si distingue per la finezza esecutiva, si presenta come un’ode dedicata alla memoria sonora di Venezia, sua città natale. I nove costrutti tematiche che ne delineano l’ordito si nutrono di immagini interiori, rimandi architettonici e suggestioni acustiche che affiorano dalla trama urbana, dove le velature delle chiese, il respiro dei canali, l’impronta delle calli e delle isole, tutto concorre a costruire un ambiente sonoro stratificato, ricco di sfumature e tensioni latenti. Il titolo stesso, «Venice Inside», allude ad una penetrazione meditativa nel tessuto della città, una sorta di indagine affettiva che non si limita alla superficie ma ne interroga le ombre, le luci e le fragilità. La figura della «Serenissima» viene evocata come organismo in bilico, soggetto ad una lenta erosione che si riflette nel profilo acustico del sassofono soprano, con cui Fasoli ne modella il suono con una malinconia trattenuta, che non cede mai al compiacimento, sostenuta da una compostezza espressiva che si fa quasi liturgica.
La costruzione modulare dei brani rivela una scrittura attenta all’equilibrio interno, in cui molte pagine musicali si aprono con una voce solitaria, che agisce come nucleo germinativo, per poi espandersi secondo logiche di accumulo e stratificazione. Il pianoforte di Roberto Zara, in particolare, disegna un tessuto armonico che sostiene ed orienta, offrendo una base mobile e ricettiva alle linee del sassofono, in un contrappunto che si fa riflessione condivisa. L’impianto compositivo dell’intero lavoro si colloca nel solco della musica da camera, ma ne amplia la portata evocativa, dove ogni episodio sonoro si sostanzia come uno spazio di ascolto, un luogo in cui la memoria urbana si trasforma in gesto musicale. La bellezza che ne scaturisce manifesta come ordine interno, come equilibrio formale che rimanda alla geometria nascosta della città. «Venice Inside» si propone come esercizio di interiorizzazione, come tentativo di tradurre in linguaggio musicale ciò che Venezia suscita alla mente, ossia una malinconia lucida, una quiete inquieta, una tipologia di resistenza poetica contro l’oblio. Le influenze armoniche che attraversano l’opera sono molteplici. Si avverte la presenza del jazz modale, nella sua declinazione più europea, quella che da Garbarek a Rava ha saputo coniugare libertà espressiva e rigore formale. Si percepiscono perfino echi della musica impressionista, soprattutto nell’elaborato pianistico, dove la sovrapposizione di accordi quartali, le progressioni non funzionali e le cadenze sospese rimandano a Debussy e Ravel, non come citazione, ma come atmosfera, come impronta linguistica. In alcuni episodi, la sequenza accordale si avvicina alla logica della musica seriale, pur senza adottarne i rigori. Si tratta di una tensione verso l’astrazione, la rarefazione e un’estetica della bellezza che si lascia scoprire.
La modalità esecutiva sancisce una consapevolezza interpretativa che rifugge ogni automatismo idiomatico, prediligendo un approccio cameristico fondato sull’ascolto reciproco, sulla modulazione timbrica e sulla costruzione di spazi acustici condivisi. L’interazione tra i quattro strumentisti si concretizza come un sistema di relazioni mobili, dove ogni gesto musicale si colloca nel solco di una mentalità dialogica, mai gerarchica. Il sassofono di Fasoli, sia nel registro soprano sia in quello tenore, modella secondo le esigenze del contesto armonico, agendo come voce perlustrativa, predisposta a ritagliarsi spazi di lirismo senza mai eccedere. La sua prassi esecutiva si regge su un controllo del fraseggio che privilegia la continuità, la fluidità e la sospensione, con un uso calibrato del vibrato ed una predilezione per le dinamiche interne. Il pianoforte di Zara, dal canto suo, interviene come tessitore di trame, disegnando geometrie timbriche che si fondano su una partitura modulare, dove l’accordo assume le sembianze di un mutante perpetuo. Il contrabbasso di Goloubev si distingue per una tecnica che coniuga precisione e cantabilità, dove l’arco viene impiegato come strumento di articolazione espressiva, capace di riportare alla mente atmosfere che rimandano alla musica colta del Novecento europeo, da Hindemith a Britten, con una sensibilità che si interseca nel riflesso della tradizione russa. Le percussioni di Zanoli agiscono come voce autonoma, abile nell’intervenire nel tessuto sonoro con accenti, attese e rilanci, in una pratica che si avvicina all’idea del teatro musicale, dove ogni colpo di scena diventa un gesto dimostrativo e qualsiasi pausa è un’attesa. Dal punto di vista dell’interplay, l’album si appoggia ad una prassi che potremmo definire interattiva, nel significato semantico del termine. In effetti non si tratta di scambi tematici o di semplici risposte, ma di una costruzione collettiva del flusso sonoro, dove qualunque intervento appare frutto di ascolto, di reazione e di rielaborazione. L’arte del contrappunto diviene tecnica e poetica al contempo: le voci si accavallano, si annodano, si distanziano e si rincorrono, secondo una grammatica che favorisce la coerenza relazionale.
Venice Inside» si dispiega come una struttura tematica di rara coerenza espressiva, dove ogni passaggio sonoro si attesta come una pagina autonoma, ma interconnessa, in cui la varietà accordale e l’opulenza timbrica concorrono a delineare un ordine interno che rimanda alla geometria nascosta della città lagunare. «Riotera» si apre con una sequenza pianistica che interroga lo spazio acustico, modulando le tensioni ain virtù di una progressione di accordi sospesi tra il modo dorico e il lidio, con incursioni cromatiche che suggeriscono una dimensione interrogativa. Il sassofono soprano di Fasoli s’innesta con discrezione, tracciando una linea melodica che si sposta per intervalli di quarta e quinta, evocando un senso di attesa e di sospensione. Il dialogo con Mario Zara si costruisce sulla logica del contrappunto timbrico, dove il pianoforte agisce come tessuto armonico mobile, capace di accogliere e rilanciare le proposte melodiche del sax. In «Aponal», il contrabbasso di Yuri Goloubev assume una funzione strutturale, disegnando un profilo acustico che si muove tra pedal points e modulazioni tonali lente, quasi a scandire il respiro dell’isola che dà il nome al brano. Il sax tenore di Fasoli s’inserisce con una traiettoria che privilegia la cantabilità, ma senza cedere alla retorica lirica, in cui la scrittura si fa meditativa, con una vibrazione interna che richiama la quiete solenne di un canale al tramonto, come nei quadri di Francesco Guardi, dove la luce esalta o attenua i colori. «Arcana» riprende la formula dell’introduzione pianistica, ma con una maggiore ricchezza armonica, dove gli accordi si dispongono secondo una logica di sovrapposizione quartale, con aperture modali che prefigurano l’ingresso del sassofono soprano. La percussione di Marco Zanoli interviene come voce autonoma, creando un tessuto ritmico che dialoga con il portato melodico, con un modus agendi che richiama la poliritmia di un certo jazz contemporaneo europeo. L’atmosfera che ne scaturisce potrebbe rimandare alle inquietudini visive di «A Venezia… un dicembre rosso shocking» di Nicolas Roeg, dove la città si fa presagio.
«Stae» si distingue per un’impronta bluesy, ma filtrata attraverso una sensibilità accordale che evita ogni cliché. Il pianoforte di Zara distilla un assolo che si divide tra il blues modale ed il lirismo romantico, sostenuto da una sezione ritmica che plasma l’essenza del groove. L’assenza di Fasoli consente al trio di esplorare una dimensione più libera, dove il finale percussivo di Zanoli agisce come sigillo espressivo. «Arogarb» presenta una peculiarità timbrica che si alloca nel riverbero di sonorità mediorientali. Il contrabbasso ad arco di Goloubev e il sax soprano di Fasoli costruiscono un interplay che si muove tra microtonalità e intervalli non temperati, portando in superficie un’atmosfera cinematografica che potrebbe accompagnare una scena di contemplazione in un film di Tarkovskij, dove il tempo si dilata. Le percussioni accentuano questo carattere esotico, fondendo le voci in un amalgama che si espande. «Rialto» emerge come esercizio di improvvisazione libera, dove Fasoli esplora il registro acuto del sax soprano con una prassi che si estrinseca tra l’atonalità e la modulazione rapida. L’armonia si fa audace, con cluster e dissonanze che intensificano il senso di movimento. Così, il ponte non è solo luogo, ma metafora di passaggio, di transizione e di slancio. «Cannaregio» disegna una ballata che si pone nel solco della tradizione lirica, ma con una perifrasi armonica che evita la prevedibilità. Il pianoforte di Zara e il sax tenore di Fasoli si crogiolano in un duetto che privilegia le cadenze sospese, le modulazioni inattese e le aperture modali. L’atmosfera interroga la poesia di Diego Valeri, dove la malinconia diventa consapevolezza. «Squero» chiude l’album con una pagina di intimità cameristica, in cui la semplicità formale non coincide con povertà espressiva, in cui il dialogo tra Zanoli e Fasoli si evolve su una temperie di sottrazione, di rarefazione e di silenzio. L’impianto armonico si riduce all’essenziale, come certa architettura veneziana non ostentata. Nel suo complesso, «Venice Inside» si colloca nel tracciato di una scrittura musicale che rielabora. Le suggestioni pittoriche di Canaletto e Bellini, le atmosfere letterarie di Thomas Mann, le inquietudini cinematografiche di Roeg e Antonioni, tutto concorre a costruire un universo sonoro che reinventa la città lagunare, la trasfigura e la interroga.